1912
Estratti in lingua francese.
H. de Balzac, Une bourgeoise sans ambition (Fragment de « Grandeur et décadence de César Birotteau »), in C. Ghiotti, G. Dogliani, Les Écrivains français des trois derniers siècles. Morceaux choisis illustrés par de nombreuses notes explicatives biographiques, littéraires, historiques et géographiques et par des « Remarques grammaticales et syntaxiques ». Nouvelle édition (A l’usage des Écoles Techniques, des Gymnases, des Écoles Complémentaires et du Ier Cours de l’Institut Technique), Turin, Librairie G. B. Petrini de Giovanni Gallizio, 1912, pp. 469-470.
Honoré de Balzac, Une enfant martyr (D’après “Pierrette”), in Giuseppe Colò, Parmi les fleurs. Anthologie française moderne avec acheminement à la conversation et à la composition à l’usage des écoles italiennes, Pistoie, Librairie D. Pagnini, 1912, pp. 254-256;
Une bourgeoise sans ambition (D’après “Grandeur et décadence de César Birotteau”), Ibid., pp. 299-301.
Traduzioni.
Onorato Balzac, Il Carnefice (El Verdugo), «L’Università Popolare. Rivista quindicinale», Milano, Anno XII, N. 1, 1 Gennaio - N. 2, 15 Gennaio - N. 3, 1 Febbraio 1912, pp. 12-13; 28-30; 44-45.
Viene riproposta la traduzione (anonima) di El Verdugo già pubblicata dagli editori Treves di Milano nel 1906.
Onorato de Balzac, Il Curato di Tours. Romanzo di Onorato de Balzac, «Il Capolavoro. Periodico quindicinale», Napoli, Prem. Stab. Tipografico S. Morano, Società Editrice “La Cultura Popolare”, Anno II, N. 3, 15 Gennaio 1912, pp. 3-18.
Questa nuova traduzione – anonima – de Le Curé de Tours è indipendente da quella fornita da Francesco Mantella-Profumi nel 1905 per l’editore Bideri.
Essa si fonda sul testo dell’edizione Furne (1843): non è riportata la dedica “À David, statuaire”. I tagli e le omissioni di ampie sequenze testuali operati dal compilatore lungo tutto il romanzo rendono questa traduzione alquanto lacunosa e insoddisfacente.
H. de Balzac, La donna abbandonata. Prima traduzione italiana di Vincenzo Lubrano, Napoli, Gennaro Monte - Editore (Officina Tip. Nobile & C.), 1912, [pp. 160].
Struttura dell’opera:
La donna abbandonata, pp. 5-61.
Il Messaggio, Ibid., pp. 65-83;
Madamigella Paulet di A. de Musset, Ibid., pp. 87-129; Breve sunto dell’assassinio di Enrico IV commesso da Ravaillac, Ibid., pp. 133-160.
Esemplata sul testo dell’edizione Furne (1842), la traduzione che Vincenzo Lubrano fornisce de La Femme abandonnée può considerarsi, nel complesso, abbastanza fedele e corretta nonostante qualche imprecisione linguistica e alcune improprietà stilistiche nelle quali è incorso il compilatore. Non è presente la dedica del romanzo alla ‘Duchesse d’Abrantès’.
Anche per la traduzione de Le Message, il testo di riferimento è quello dell’edizione Furne (1842). Non è riportata la dedica del racconto a Damaso Pareto. Nonostante qualche errore nella resa in lingua italiana del modello balzachiano, la presente traduzione può ritenersi corretta.
Balzac, Un dramma in riva al mare. Novella di Balzac, in Giorgio Ohnet, Cuori in pena. In riva al fiume. Romanzo. Unica traduzione italiana autorizzata, Napoli, Lubrano e Ferrara Editori (Cooperativa tipografica, Largo dei Bianchi), 1912, pp. 119-141.
Su questa traduzione (anonima) di Un drame au bord de la mer – il cui modello è il testo dell’edizione Furne (1846) – è difficile fornire un giudizio positivo a causa delle frequenti libertà che il compilatore si prende nei confronti del testo di Balzac attraverso l’omissione abbastanza significativa di sequenze testuali lungo tutto lo svolgersi del racconto.
O. di Balzac, Il dramma della locanda rossa. Racconto, Milano, Prem. Stab. Tip. La Stampa Commerciale, 1912, pp. 64.
Siamo di fronte alla riproduzione, senza alcuna variante formale, della traduzione del racconto filosofico balzachiano pubblicata ne «L’Illustrazione Popolare» a partire dal N. 32 del 10 Agosto 1884.
Balzac, L’Israelita. Romanzo, Milano, Fratelli Treves, Editori (Tip. Treves), 1912 («Biblioteca Amena», N. 826), pp. 326.
Condotta sul modello dell’edizione Souverain (1840) – nella quale il testo di Clotilde de Lusignan, ou le Beau Juif è pubblicato con il titolo de L’Israélite – questa traduzione italiana del romanzo giovanile balzachiano si struttura in 29 capitoli integrati dal Prologo e dalla Conclusione. L’anonimo compilatore si mostra assai poco fedele nei confronti del testo originale: numerose, infatti, sono le omissioni di parti più o meno estese del tessuto narrativo operate lungo tutto lo svolgersi del romanzo.
Balzac, Papà Goriot. Romanzo. Traduzione di Ketty Nagel, Milano, Fratelli Treves, Editori (Tip. Fratelli Treves), 1912 («Biblioteca Amena», N. 652), pp. 295.
Cfr. 1903.
Onorato di Balzac, I Parenti poveri. I. La Cugina Betta di Onorato di Balzac. Traduzione di Galeazzo Falconi, con prefazione, Milano, Fratelli Treves, Editori (Tip. Fratelli Treves), 1912 («Biblioteca Amena», N. 744), Secondo migliaio, pp. VIII-404.
Cfr. 1908.
Studî e riferimenti critici.
Autoriassunti e Riviste. V. Morello — “Balzac e l’antropologia”. — Dalla «Nuova Antologia» Ref. Med. 1912, «Annali del Manicomio Provinciale di Perugia», Perugia, Anno VI, Fasc. I-II, Gennaio-Giugno 1912, pp. 105-114.
In un articolo comparso alcuni anni or sono sulla Nuova Antologia Vincenzo Morello da Maestro, richiama l’attenzione dei positivisti italiani sull’ opera di Balzac ne’ riguardi dell’antropologia criminale. Ne riportiamo i punti salienti per il piacere dei lettori e nostro.
Balzac vide e descrisse l’uomo e la società, quali sono.
Poche creazioni dell’umana fantasia sono così compenetrate di arte e scienza, come la Commedia umana. E poche fantasie possono vantare le emule della natura nella creazione dell’uomo, come questa di Balzac. Dopo 50 anni, l’immensa costruzione letteraria, che si chiama la Commedia umana, sembra, più che la nostra stessa nella quale siamo incastrati, una grande costruzione storica e sociale vivente; e l’autore un condottiere di tribù, più che un evocatore di fantasmi. Per definire e qualificare la Commedia umana [il corsivo è nostro], si son trovati in questi 50 anni, mille metafore; e chi la chiamò al tempio di Salomone, tutto oro e marmi preziosi; e chi la chiamò la Torre di Babele, nella quale risuonano tutte le lingue e tutte le passioni combattono insieme, nello stesso tempo; ma non si trovò per l’autore la metafora che organicamente lo rappresentasse e definisse; dell’autore, anzi, nessun artista, nessuno scultore ha ancora saputo ritrarre le sembianze, fissare in un tipo umano nel marmo la forma e l’espressione; quasi che in questo mezzo secolo, i tratti di quella magica figura si siano dileguati dalla memoria e dalla conoscenza degli uomini, come i raggi del sole, che, in una magnifica primavera, nel dar vita ad un popolo di fiori nella terra e a un popolo di sogni nel cuore umano, si dissolvano nei colori e nei profumi, nei desideri e negli amori che essi stessi generano o fecondano.
Più che una primavera, in verità, Balzac produsse un mondo, o per lo meno portò nel suo cervello tutto un mondo e tutta una società. — «Quattro uomini», egli scriveva a M.me Hauska (sic), in un momento di giusta superbia, «avranno avuto vera influenza in questo secolo: Napoleone, Cuvier, O’Connell, e il quarto vorrei essere io. Napoleone ha vissuto del sangue d’Europa: Cuvier ha disseccato il globo; O’Connel si è incarnato in un popolo; io avrei portato una società tutta intera nel mio cervello [»].
La critica letteraria, se vide i legami che univano la personalità e l’opera in genere di Balzac alle idee morali del suo tempo non vide in particolare l’importanza dei romanzi criminali, non colse e forse non poteva cogliere le relazioni correnti tra i tipi creati dal romanziere ed i tipi prodotti nella vita, non seppe rintracciare il cordone ombelicale che legava il mondo criminale di Balzac col mondo criminale del tempo; e spropositò quindi pietosamente, fino al punto da lamentare con Brunetière, che il Balzac disperdesse le sue forze in «melodrammi giudiziari, non meno ignobili che puerili, come l’ultima incarnazione di Vautrin». Eppure, ci sarebbe voluto tanto poco ad essere più precisi e meno ingiusti! Uno scrittore come Balzac non si può studiare con gli antichi criteri retorici e gli antichi intendimenti accademici. L’opera di Balzac è un’opera di vita; sorge dall’humus sociale, tutta e intera, e vi resta con le radici profonda, in perpetua fioritura.
Ora è ben questo humus che bisogna esaminare per comprenderne la costituzione chimica, per seguirne le correnti d’irrigazione.
Dove comincia e dove finisce la realtà e la finzione nei personaggi di Balzac? La parte animale, la parte umana, la parte fantastica di questi personaggi è così fusa in una terribile unità vivente, che voi ve li vedete venire dinnanzi questi Cennari, e non sapete ben distinguere qual sia la radice della loro carne e quale sia lo stelo della fantasia dello scrittore. Così la persona di Rastignac ha la stessa radice della persona di Adolfo Tiers; la giovinezza di Luciano di Rubempré scoppia dalla stessa giovinezza di Iules Ianin (sic); e D’Arthez e Luchet escono dalla stessa matrice donde uscirono Félix Pyat e Chrestien; e così infine la vita di Vautrin si confonde con la vita di Collet, di Ponsard, di Cognard, di Poucet, di Mitifian, di tutti i grandi delinquenti del suo tempo, dei quali piglia, volta a volta, i nomi, le gesta, il carattere, la figura, formando un gruppo di figure miste in una faccia, come quello che nel XXV dell’Inferno formano l’uomo e il serpente nella reciproca trasformazione del loro movimento e della loro natura.
Ma se per l’ambiente e pel costume, Balzac è il cronista del suo tempo; per il metodo scientifico è un precursore: il precursore dell’antropologia criminale. Tutto quello ch’egli osservò o intuì nella anatomia, nella fisiologia, nella psicologia del delinquente è stato poi ratificato, provato, riprovato dall’antropologia criminale — che non sospetta neppure lontanamente di avere avuto la culla in quella grande opera letteraria.
Vantrin (sic) — quale ci appare nella prima pagina del Père Goriot — è un uomo di oltre quarant’anni. Spalle larghe, il busto bene sviluppato, i muscoli bene rilevati, le mani spesse, quadrate, con falangi fitte di pelo, a ciuffetti, di un rosso ardente. Egli è tutto rosso — come gli uomini primitivi; — e l’ombra nella quale passa la sua figura è solcata di vampe sanguigne. Egli passa nella società, attraverso le leggi, le imboscate della polizia, i tradimenti dei suoi complici, come un selvaggio del Nuovo Mondo tra i rettili, le bestie feroci, le tribù nemiche. Egli sa o indovina gli affari di coloro che lo circondano; ma nessuno di coloro può arrivare a scoprire le sue occupazioni o penetrare i suoi pensieri — Chi sono io? — egli dice a Rastignac, col quale ha bisogno di farsi valere. — Chi sono? Vantrin. Che fo? Quel che mi piace ... Ed è bene che sappiate che per me uccidere un uomo e lo stesso che ... — E qui compie la frase lanciando uno spruzzo di saliva. «Non è del resto una bella partita a giuocare — essere solo contro tutti e avere della chance». |
Esaminate, una a una queste proposizioni. Esse sono ľespressione della psiche criminale: sono formole mentali che derivano, che fioriscono dalla sostanza stessa della coscienza criminale. Come parla Vantrin, parlano tutti i delinquenti. Balzac ha dato al suo personaggio gli attributi, le energie, le parole, gli accenti, che la natura dà ai suoi prodotti criminali.
L’onestà non serve a niente — dice come principio generale, Vantrin. — E il Ferri nota nelle Tavole psicologiche dichiarazioni di ladri come questa: «Io sono fatalista: non credo all’onestà». Quell’ onestà, che non serve davvero a nulla, quando si tratta di combattere contro la persona o contro i beni altrui! Ma la dichiarazione caratteristica di Vantrin, è quella che si riferisce all’indifferenza assoluta, all’assoluta semplicità nel manifestare la nessuna repugnanza a commettere un omicidio. Il est bon de vous apprendre — dice a Rastignac — que je me soucie de tuer un homme comme de ça! — dit — il, en lançant un jet de salive.
La fantasia psicologica di Balzac aveva colto, insieme il segno caratteristico della coscienza e dell’espressione di Vantrin: del delinquente nato, del delinquente molteplice, del delinquente di genio, che è insieme ladro e omicida, che organizza una truffa come un agguato, che inventa un piano di polizia, che sventra un uomo come una porta, e tratta una serratura come una coscienza umana. Si quelque serrure allait mal, il l’avait bientôt démontée rafistolée, huilée. limée remontée en disant: Ça me connaît. — Non ricordate, leggendo di questa abilità di Vantrin, la celebre dichiarazione, del celebre scassinatore Di Hessel, che si vantava di aprire con un soffio una serratura?
Ma una meravigliosa prova della profondità di osservazione, e, quasi vorrei dire, divinazione del nostro autore, è nella descrizione della condotta di Vantrin dopo il delitto. Tutto quello che l’antropologia criminale ha osservato, sperimentato, provato e riprovato nelle sue lunghe inchieste e nei suoi studi più sicuri, Balzac aveva già osservato, divinato, descritto cinquant'anni prima. L’identità delle parole, delle frasi, delle espressioni di Vantrin con altri criminali veri e reali, si riscontra miracolosamente anche negli atti, nella condotta susseguente al reato.
La fantasia scientifica di Balzac è tanto grande, e forse più grande, che quella poetica. Egli interpreta con mirabile esattezza, con quella fantasia, i segni caratteristici della figura, scopre le leggi naturali che risiedono nel fondo dei fenomeni morali; e identifica con miracolosa intuizione psicologica tutti i movimenti e gli atti e le parole dei personaggi imaginari coi movimenti gli atti e le parole dei personaggi reali della stessa specie e della stessa natura.
Quando Vantrin è scoperto, in mezzo agli altri abitatori della pensione Vauquer, Balzac riassume in alcuni tratti sintetici magistrali tutta la fisionomia morale del gran delinquente. «Il bagno coi suoi costumi e il suo linguaggio, con le sue brusche transazioni dal gaio all’orribile, la sua spaventevole grandezza, la sua familiarità, la sua bassezza, fu tutto a un tratto rappresentato da quell’uomo, che non fu più un uomo, ma il tipo di tutta una nazione di degenerati, d’un popolo selvaggio e logico, brutale e svelto. In un momento Colin (sic) divenne un poeta infernale, su cui si dipinsero tutti i sentimenti umani — salvo uno solo — «il pentimento». Colpo da maestro quest’ultimo. Tutto il resto della descrizione poteva essere fatta da qualunque altro scrittore, ma la battuta finale, l’eccezione rapidamente accennata e semplicemente enunciata, non poteva essere che di Balzac. Senza quella eccezione, Colin sarebbe stato un delinquente di maniera, un eroe d’occasione. Con quella eccezione diventa un personaggio vivo e vero. È proprio l’assenza di quel sentimento che distingue e caratterizza il delinquente nato da tutti gli altri. «Durante parecchi anni, scrive il Marro nei Carcerati, «non ho mai mai — osservato il minimo segno di pentimento, mai il più piccolo disagio morale. E in tanti anni avrei potuto ben coglierne qualche indizio».
Tutte queste osservazioni, di ordine particolare, sono poi integrate da alcune idee generali, sintetiche, che meglio illuminano e rivelano la psiche del delinquente.
Il Balzac non solo osservò e divinò in tutta la sua ampiezza la psiche del delinquente nato, ma ne studiò anche l’irradiazione. Gli uomini come Vantrin hanno troppa abbondanza di forze vitali perchè non sentano il bisogno di scaricarsene in parte, per alimentare altri soggetti.
Essi cercano quindi il debole per corromperlo, per formarlo, per ricrearlo a loro imagine, per farsene un amico, un complice, un aiuto e spesso un conforto. «Egli non s’era fatto l’amico del giovane Celestino che per inoculargli nelle vene il cattivo sangue che correva nelle sue», dice Claude, di Edouard Henry. E così si può dire di Vantrin verso Luciano di Rubembiè (sic). Quello che aveva tentato invano con Rastignac, tipo superiore e volontario, Vantrin tentò con successo con Luciano, tipo mediocre, di coscienza incerta, di carattere dubbio. E la conquista di Luciano fu il più grande trionfo di Vantrin nel commercio sociale. Meriterebbero uno studio a parte le due tentazioni di Vantrin, nel Père Goriot e nelle Illusioni perdute, su Rastignac e su Luciano di Rubempré.
Quanta sapienza, quanta crudeltà, quanta ferocia, quanta audacia di pensiero e di parole nella tentazione di Rastignac — l’uomo forte, l’uomo col quale non si può giocare di equivoci, l’uomo che si prepara ad essere egli stesso un lottatore e forse un corruttore nella vita! E invece, quanta unzione, quanta dolcezza, quanta amabilità, quanta metafora, con Luciano, l’uomo morbido, senza energia e senza avvenire: il corrotto incosciente? Con Rastignac, il patto di Mefistofele con Faust; con Luciano, l’amabilità di Pietro e Iaffier nella Venezia salvata di Otway. Egli ha bisogno di impadronirsi dell’anima e della vita di uomini come Rastignac o Luciano di Rubempré – per mezzo dei quali comunicare alla società, della quale è al bando. Come in un’atmosfera di tempesta i suoni si propagano più celermente e più fortemente, nell’atmosfera di quelle giovani anime in tumulto, Vantrin capiva si sarebbe dovuto più celermente e fortemente propagare l’energia del suo pensiero e del suo istinto criminoso. Egli sa il gesto, la parola, l’atteggiamento morale da pigliare di contro all’uno o all’altro: con Rastignac, da pari a pari, da gente che si guarda negli occhi e si comprende anche di là del proprio pensiero; lupo contro lupo; -— con Luciano Rumbemprè (sic), da superiore a inferiore, da protettore a protetto, da confessore a penitente. Con Rastignac, quindi, Vantrin si dichiara; con Luciano si nasconde; -- a Rastignac mostra il petto, mostra la profonda ferita avuta in duello, mostra i canini esercitati a tutti i morsi, con Luciano si chiude tutto nella veste e nel nome e nell’ombra del gesuita che aveva assunti al suo ritorno dalla Spagna. Con Rastignac, insomma, egli è, secondo la sua metafora, la palla di cannone che tenta di sfondare: con Luciano la peste che penetra vittoriosa nell’anima e nel corpo.
Nelle pagine che il Balzac consacra alle relazioni tra Carlos Herrera e Luciano è tutta la psicologia dell’incubo e del succube, ricercata alle sorgenti, disegnata nel suo corso, descritta fino agli sbocchi. E poichè Balzac pensa a tutto, pensò anche alla definizione, nell’ordine penale, del succube; e anticipando sulla sistemazione, egli definì Luciano di Rumbempré un demicriminel (sic). Quando dopo la truffa al Nucingen, di cui egli era e doveva essere complice, perchè il milione doveva servire al suo matrimonio con la Grandlieu, e la susseguente morte di Ester, fu tratto in prigione, e sottoposto a interrogatorio, Luciano non seppe resistere all’assalto delle diverse domande del giudice istruttore, s’imbrogliò, si irritò, si commosse, accusò, si accusò? E allora Balzac osserva: «Supponete ora un semi-criminale, come Luciano, che salvato da un primo naufragio della virtù ...». — E più giustamente di così non era possibile osservare e definire. La scuola criminale positivista dà, infatti, al succube il nome di criminoloide (sic?) ... Ma per la storia, il gran «professore di scienze sociali», come Balzac stesso si chiamava, aveva bollato prima fra tutti nel segno, col suo sorprendente acume scientifico e morale!
Ma dove «il professore di scienze sociali» più sicuramente e più singolarmente rivela il suo genio e le miserie altrui, e laggiù nel cerchio VIII. nella gola fera delle prigioni, dove sono caduti e raccolti tutti i delinquenti che la giustizia è potuta riuscire a fermare nella via. L’aria si tinge di nero; la fronte umana si piega umiliata allo spettacolo. I carcerati passano, evitandosi, lanciandosi sguardi cupi e sorrisi lividi, secondo i pensieri del momento. La galera pare un manicomio. Il delitto e la follia — domanda Balzac, precorrendo la risposta e la definizione dell’antropologia criminale — il delitto e la follia non hanno qualche somiglianza tra loro? Tutta quella gente che preferì, come dice Dante, vita bestiale all’umana, ha veramente figura bestiale più che umana. Balzac disegna quelle figure con un rilievo scientifico che sbalordisce. Tutti i tratti fisici e morali dei delinquenti ch’egli descrive, noi li vediamo riprodotti negli atlanti della scienza e nelle cronache giudiziarie moderne. Ognuno di essi porta il suo marchio. Balzac osserva e stabilisce il carattere indelebile che dà a ciascuno l’esercizio del mestiere. Ecco la Pouraille, piccolo, secco, magro, volto di faina, stupido quanto agile, feroce contro il prossimo, quanto obbediente verso il suo capo. Ecco Teodoro Calvi, ladro e assassino, il compagno di affetto e di catena di Vantrin in galera, pallido, olivastro, femineo, occhi incavati, fronte depressa; ecco Biffon, celebre ladro, di piccola statura, grosso e grasso, su due gambe bene arcuate, con sul volto tutti i caratteri dell'animale carnivoro; ecco Fil-de-Svie (sic), che a primo aspetto somiglia a un lupo per la larghezza delle sue mascelle vigorosamente pronunziate, e fa ribrezzo pel colore del volto pallido e butterato; ecco Asie, la zia e la educatrice di Vantrin, l’antica amante di Marat, ladra, assassina, avvelenatrice, che par la madre di tutti i delitti, e le cui mani hanno fatto mille mietiture. Tutte queste fronti depresse, e sfuggenti, queste gambe arcuate, questi volti di faina e di lupo, queste mani adunche, si piegano innanzi a Vantrin, obbedienti ad ogni cenno di questo Cromwell del bagno, paurosi ad ogni minaccia, fiduciosi in ogni proposito, credenti in ogni resurrezzione (sic). Quando essi sono uniti o quando comunicano lontani; come genti di diversa specie da quella della quale sono nati, hanno un loro linguaggio particolare, il loro argot, modellato col conio della loro anima, così diversa e così lontana dalla nostra. Balzac è il primo a rilevare l’importanza e a dare importanza d’arte a questo linguaggio, a studiarlo, a interpetrarlo, a illustrarlo. Non vi è infatti linguaggio più energico e colorito di quello formatosi attraverso mille paure mille fughe, mille tragiche peripezie. Ogni parola è un’imagine brutale, ingegnosa o terribile; le sillabe, che cominciano o finiscono le parole, sono aspre, stridenti, roventi come ferri e come acidi ... Qui, come vedete, noi siamo tanto lontani da Victor Hugo che da Bostojewski (sic), tanto lontani dal principio della riabilitazione quanto dalla regione della sofferenza umana; qui siamo nella zona intermedia tra l’umanità e l’animalità, qui siamo alle ultime trincee, alle ultime frontiere della ragione umana e del sentimento civile, e alla porta dell’istintiva bestialità, e della preistorica barbarie. Ma ahimè da queste lontane provincie, dal fondo oscuro del bagno, qualcuno sorge ad imporsi nella società: Vantrin sorge a dominare e a comandare. Quando caduto definitivamente nelle mani della giustizia, i giudici tentano di fare il processo a Vantrin, non possono: la loro iniziativa si frange; la loro buona buona volontà rimane paralizzata; la legge stessa rimane confusa.
La giustizia, di fronte a Vantrin, dichiara la sua bancarotta e viene a patti. Perchè? Perchè Vantrin ha in mano i segreti della Duchessa di Manfrignense (sic), di Madame di Sérizy, di Clotilde Grandlieu: ha in mano l’avvenire del giudice istruttore, la fortuna del procuratore generale, la salute di più di un ministro: parecchie alte famiglie in pericolo! Qui l’azione precipita. — Noi siamo alla mercè di un forzato — dice il duca di Grandlieu, piegandosi all'orecchio della duchessa di Manfrigneuse. — C’est fait — risponde la duchessa. E Vantrin è liberato. — Ecco la morale di questa storia — aggiunge subito, serenamente l’autore che ha legato alla stessa catena, nella stessa galera, sotto il martello delle stesse necessità, la classe alta e la bassa, l’uomo politico e l’uomo di affari, la dama galante e l’avventuriera, la moglie del giudice e la zia di Vantrin, il polso del condannato e il codice della legge. Ed ecco la morale della vita umana?
Albe e tramonti. Un medico crudele … o troppo onesto, «Il Corriere di Trani (La Bohème)», Trani, Anno X, Num. 2, 18 gennaio 1912, p. 1.
Dottore — domandò il celebre romanziere Balzac al suo medico — io voglio saper da voi tutta la verità ... Quanto tempo credete che mi rimanga ancora da vivere?
Il dottore non rispondeva.
– Via, dottore, mi prendete per un bambino? Vi ripeto che non posso morire come il primo venuto: un uomo come me è obbligato a fare il suo testamento al pubblico.
La parola testamento fece aprire la bocca al medico.
– Caro malato, quanto tempo vi abbisogna per quel che vi rimane a fare?
– Sei mesi — rispose il Balzac con l’aria di un uomo che ha calcolato bene; e guardava fisso il medico.
– Sei mesi! Sei mesi! — rispose il dottore scotendo la testa.
– Ah! — esclamò con dolore il romanziere — voi non mi concedete sei mesi: mi darete almeno sei settimane?
Il dottore scosse la testa come la prima volta. Il Balzac si alzò a sedere sul letto, indignato.
Il dottore aveva preso proprio sul serio l'intimazione del malato: era risoluto di dirgli la verità. Balzac ansioso, centuplicava la sua forza morale por esser degno della verità.
– E che, dottore, sono dunque un uomo morto? Grazie a Dio, mi sento ancora in grado di combattere; ma sento puro il coraggio di sottomettermi. Son pronto al sacrifizio. Se la vostra scienza non v’inganna, non m’ingannate: che cosa possa ancora sperare?... Sei giorni? — ripetè il grande scrittore — ebbene indicherò a grandi tratti quel che mi resta da fare per compiere la mia opera ...
La volontà umana fa miracoli ... posso dare una vita immortale a quanto ho creato: mi riposerò al settimo giorno … e il suo sguardo divenne mesto, pieno di dolore il suo sospiro ...
Dacché il Balzac faceva queste domande, era invecchiato di dieci anni: non trovava più la sua voce por interrogare ancora il medico, che non trovava voce por rispondere.
– Caro malato — disse finalmente il dottore tentando di sorridere — chi può decidere di un'ora qui in terra? Può morire prima di voi chi sta ora benissimo; ma voi avete parlato di testamento al pubblico ...
– Ebbene?
– Ebbene, questo testamento bisogna farlo oggi stesso.
Il Balzac alzò la testa:
– Non ho dunque che sei ore da vivere? — esclamò spaventato, e cadde sul guanciale.
L’ultima parola del medico fu il colpo di morte; tosto cominciò l’agonia. Egli aveva voluto la verità: e la verità imprudentemente pronunziata dall'uomo della scienza lo aveva ucciso prima del tempo.
Marginalia. Balzac e Schopenhauer, «Il Marzocco», Firenze, Anno XVII, N. 12, 24 Marzo 1912, p. 5.
Tra la filosofia di Schopenhauer e il sistema filosofico che Balzac espone nel suo romanzo Louis Lambert vi sono analogia così evidenti che non possono sfuggire. Vi insiste la Frankfurter Zeitung. La base della filosofia di Schopenhauer è, come è noto, col concetto di rappresentazione, il concetto di volontà. Il mondo è una rappresentazione in questo senso: che non si può concepirlo altro che rappresentato in una intelligenza. Ma l’essenziale di questo mondo fenomenico è la volontà. La volontà si manifesta sotto forma di forza e, in tutti gli esseri, sotto la forma di voler vivere, di volontà di vivere. L’intelligenza non è che lo strumento: all’infuori di alcuni casi di conoscenza dell’io e di emancipazione, essa rappresenta la parte di strumento, di mezzo, al servizio dello scopo fissato dalla volontà … Ora qual’ è, secondo Balzac, la filosofia dell’intimo amico suo collegiale di Vendôme? «A idee nuove – scrive il romanziere – parole nuove, o parole antiche, rinnovate, allargate, diffuse, meglio definite. Lambert aveva dunque scelto, per definire le basi del suo sistema, alcune parole volgari che già rispondevano vagamente al suo sistema. La parola volontà serviva a nominare l’ambiente in cui il pensiero fa le sue evoluzioni, o, con espressione meno astratta, la massa di forza con la quale l’uomo può produrre, al di fuori di sé stesso, le azioni che compongono la sua vita esteriore. La volizione, parola dovuta alle riflessioni di Locke, esprimeva l’atto col quale l’uomo usa la volontà. La parola pensiero, per lui il prodotto quintessenziale della volontà, designava anch’essa l’ambiente in cui nascevano le idee alle quali ella serve di sostanza. L’idea, nome comune a tutte le creazioni del cervello, designava l’atto con cui l’uomo usa del pensiero. Così la volontà, il pensiero erano i due mezzi generatori; la volizione, l’idea erano i due prodotti. La volizione gli sembrava l’idea giusta, dal suo stato astratto ad uno stato concreto, dalla sua generazione fluida ad una espressione quasi solida, se tuttavia queste parole valgono a formular vedute così difficili a precisare. Secondo lui, il pensiero e le idee sono i movimenti e gli atti del nostro organismo interiore, come le volizioni e la volontà costituiscono quelli della vita esteriore. Aveva fatto passare la volontà avanti il pensiero. Per pensare bisogna volere – diceva. – Molti esseri vivono allo stato di volontà senza tuttavia giungere allo stato di pensiero». Così Balzac: e questa gerarchia è proprio quella capitale nella filosofia di Schopenhauer. Louis Lambert fu pubblicato per la prima volta nel giugno-luglio 1832 mentre il Mondo come volontà e rappresentazione era comparso nel 1819. Balzac, è vero, dichiara che Louis Lambert formulò i principî della sua filosofia sotto il titolo di Trattato della volontà fin dal 1812 e che questo manoscritto fu poco dopo distrutto. Egli rientra nel romanzo …
Rivista delle Riviste. Un plagio di Balzac?, «Rassegna Contemporanea», Roma, Anno V, Fasc. VI, Aprile 1912, p. 180.
Venne pubblicata tempo fa un’opera inedita di Balzac: l’Amour Masqué ou Imprudence et Bonheur, romanzo che sarebbe stato offerto in dono alla duchessa di Dino, e ove si narrava d’un ufficiale di cavalleria che, avendo incontrato una sera al veglione una donna mascherata, ne diviene l’amante per una sola notte d’amore, e per lunghi anni cerca invano di scoprire il mistero della strana relazione dalla quale una figlia è nata. È solo in un supremo convegno che la donna si rivela a lui prima di allontanarsi per sempre. Ora, scrive Pierre Lavedan nel Mercure de France (16 marzo), nel Magasin littéraire dell’aprile 1845 è comparsa una novella, firmata Moléri, che svolge l’identica trama, non solo, ma con la stessa successione di avvenimenti e situazioni: in alcuni luoghi è persino identico il testo. Qual’è la chiave dell’enigma? Moléri era lo pseudonimo di Hippolyte-Jules Demolière, scrittore, ai suoi tempi, assai noto: la questione sta quindi nel sapere chi, fra i due scrittori, fu plagiario. Il Lavedan pone, senza rispondere, il dilemma in questi termini: o Moléri, ha riassunto e riprodotto il romanzo di Balzac che aveva avuto modo di conoscere, o è stato Balzac a trascrivere e amplificare il racconto del Moléri. (Balzac et Moléri ou le curieux dilemme).
Di tutto un po’, «La Democrazia. Quotidiano della Provincia dell’Umbria», Perugia, Anno XXXIX, Num. 81, 6-7 Aprile 1912, p. 2.
Il Paradiso di Maometto.
I francesi ci pigliano gusto a lacerare di tanto in tanto uno dei capolavori che posseggono al Louvre. Forse ne hanno troppi.
A questo proposito l’Éclair racconta un aneddoto di Balzac.
Durante i primi anni di regno di Luigi Filippo uno dei saloni più eleganti di Parigi era quello della signora Bascary de Willeplaine. Questo salone era stato battezzato il «Paradiso di Maometto», perché accoglieva le più belle donne di Parigi.
Molti uomini illustri frequentavano questo paradiso terrestre, e notevolmente assidui erano Balzac e Donizetti.
Una sera di ricevimento fu trovato un quadro ad olio tutto tagliuzzato. Chi fece questa mirabolante scoperta fu Donizetti che stava improvvisando al piano guardando in aria.
Ma nessuno seppe dire come e il perché di questo vandalismo.
Una bella signora si rivolse a Balzac dicendogli:
– Voi che avete una conoscenza profonda del cuore umano, diteci se il colpevole è un uomo o una donna?
– Non è un uomo – rispose Balzac.
Le donne protestarono.
– E neppure una donna – aggiunse il romanziere.
– E allora chi è stato?
– Un bruto!
Marginalia. Un mistero balzachiano, «Il Marzocco», Firenze, Anno XVII, N. 14, 7 Aprile 1912, p. 5.
I nostri lettori ricordano certamente quel romanzetto inedito di Balzac di cui anche noi parlammo a lungo nelle nostre colonne: l’Amour masqué. Ricevuto dalla contessa di Dino – si narrava – Balzac aveva scritto per lei sola questo romanzo restato ignoto e le aveva fatto omaggio del manoscritto rilegato sontuosamente con le armi della duchessa. Il manoscritto dalla biblioteca di questa era passato a quella del figlio e poi nelle mani di Luciano Aubanel, il quale lo aveva affidato ad un editore. Tutti ricordano la grande impressione che fece la pubblicazione dell’Amour masqué. Un romanzo ignoto di Balzac! Non si sarebbe potuto trovar di meglio per avvincere la curiosità del pubblico di tutto il mondo. Il romanzo era piuttosto una lunga novella che si può riassumer così: un giovane ufficiale, Leone di Préval, incontra al ballo dell’Opéra una sconosciuta che si lascia amare mascherata, senza indomani. Sa in seguito che questa donna, vedova senza figli, ha desiderato soltanto di averne uno, ha tentato e superato l’avventura amorosa per diventar madre. Ella ha messo al mondo una figlia, che Préval non vedrà mai, a meno che un pericolo urgente non lo richiami. Dopo ricerche disperate quanto inutili, egli racconta una sera in società la sua avventura. Ognuno disapprova e vilipende la donna, eccettuata madame de Roselis, la quale, naturalmente, è la donna mascherata. Alla fine, il suo amore risale dalla figlia al padre. Ad un secondo ballo dell’Opéra cui ella si fa condurre, ritrova Préval e gli scopre il mistero … Préval e la dama si sposano e tutto è finito. Ma tutto ora ricomincia per noi con un altro mistero. Un collaboratore del Mercure de France in un Magazin (sic) Littéraire del 1845 ha scoperto una novella intitolata il Domino bianco e firmata Moléri, la quale novella pone a Gand le stesse precise scene che Balzac fa svolgere a Parigi. Gli eroi sono gli stessi sotto nomi differenti, tutte le avventure sono identiche, intere frasi si rassomigliano: solo la novella è più corta. Che cosa se ne deve concludere? Chi era questo Moléri? Moléri è un semplice pseudonimo di Balzac? Tutt’altro, Moléri non è celebre, non è stato mai celebre, ma è stato un personaggio reale, è esistito, ha fatto rappresentar perfino delle commedie alla Comédie Française e qualcuna con successo. Egli si occupava di politica oltre che di letteratura e fu, dopo la rivoluzione del ’48, attaché al segretariato della Presidenza della Repubblica. Allora c’è plagio, ma chi è il plagiario? Bisognerebbe sapere quale delle due novelle è anteriore all’altra. Ma se noi conosciamo la data del Domino bianco non conosciamo quella dell’Amore in maschera. Potrebbe darsi benissimo che Balzac, per imbastire in fretta un lavoro che doveva presentare alla duchessa, abbia preso l’ispirazione dal suo oscuro collega. Balzac resta grande anche senza l’Amour masqué …
Un romanzo eccezionale, «La Stampa», Torino, Anno XLVI, Num. 157, 7 Giugno 1912, p. 4.
Tra alcuni giorni inizieremo la pubblicazione di un romanzo inedito di Ponson du Terrail [Fripouille] […]; i volumi lasciati da lui costituiscono una mole di lavoro più che sufficiente a riempire l’esistenza di uno scrittore anche di balzachiana fecondità. […] Così è stato possibile leggere l’anno scorso un romanzo inedito di Onorato Balzac [L’Amour masqué (?)]; così possiamo ora offrire ai nostri lettori un lavoro sconosciuto di Ponson du Terrail […].
Guadagni degli scrittori francesi, «Illustrazione popolare. Giornale delle Famiglie», Milano, Anno 43°, N. 24, 13 giugno 1912, pp. 375-377.
p. 376. Onorato Balzac lottò per tutta la vita contro difficoltà finanziarie. Il suo primo romanzo non gli fruttò più di 10oo franchi, e fino al 1833 egli visse proprio nella miseria. Ingolfatosi nei debiti, per ben venti anni i suoi creditori lo perseguitarono, ed egli lavorò con un accanimento incredibile, scrivendo romanzi sopra romanzi, spesso più di uno ad un tempo. Finalmente il suo matrimonio con la contessa Hanska gli portò la pace desiderata, ma poco dopo, la morte lo rapì immaturamente nel pieno fervore del lavoro. Nel primo periodo della sua attività letteraria, cioè fino al 1835, i suoi guadagni variarono molto; le cose migliorarono quando la Revue de Paris cominciò a pagarlo da 200 a 250 franchi per foglio di stampa. Per i dodici volumi degli Etudes de mœurs au XIX siècle ebbe 33000 franchi; poi, per ogni romanzo, pubblicato prima in qualche giornale o rivista, guadagnò da 3500 a 4000 franchi. Il Constitutionnel gli pagò 9238 franchi il Cousin Pons e 12836 la Cousine Bette. Per pagare i suoi creditori spesso fu costretto a prendere con editori degl’impegni ai quali poi venne meno; donde processi e nuovi debiti; e solo dopo la sua morte la vedova riuscì a pagarli tutti, sopratutto grazie alla fortissima somma (non si sa però quanto) che la casa Calmann-Lévy le versò per la proprietà esclusiva della Comédie Humaine.
Riviste e giornali, «Corriere della Sera», Milano, Anno 37°, Num. 165, 15 Giugno 1912, p. 3.
L’iniziato periodo della villeggiatura fa rammentare all’on. Marangoni nel Corriere di Catania … la villa di Balzac, il rifugio romito nel quale il grande scrittore s’era isolato. La gran trovata sua era stata quella di abolire i domestici … per poter abolire il cordone dei campanelli che avrebbero servito a chiamarli. Le stanze erano nude ma ei le rivestiva colla propria fantasia scrivendo sui muri di ciascuna ciò che avrebbe dovuto adornarle. Sulle pareti del vestibolo si leggeva a grandi caratteri: “Qui un rivestimento di marmo pario”; nella prima sala: “Qui uno stibolate in legno di cedro”; a sommo del salotto: “Qui un soffitto dipinto da Delacroix”. Gauthier (sic), avendo dormito una sera nella cuccia messa a sua disposizione dal collega, lasciò scritto sulla parete dirimpetto: “Qui un quadro di Raffaello, senza prezzo, come non se ne sono mai visti”. La strana villa ebbe ospiti per una colazione anche Vittor Hugo, la cui attenzione fu attratta da un vecchio noce dominatore del miserrimo giardino. “E’ un albero famoso – disse Balzac al sommo della gioia – . L’ho acquistato dal Comune a caro prezzo pochi mesi fa. Sapete cosa produce?” – Probabilmente … delle noci” rispose Hugo. – “Ohibò! produce … 1500 lire all’anno” – Di noci?” – Niente affatto … D’argento!” – E spiegò come un vecchio diritto feudale obbligasse tutti gli abitanti a deporre presso quell’albero secolare le loro immondizie: e soggiunse: “Io le farò coprire di paglia e di altri detriti vegetali ed alla fine d’ogni anno ne avrò una montagna da vendere ai coltivatori del paese. E’ questo un piccolo Perù, poiché il mio concime sarà migliore del guano degli uccelli sulle isole del Pacifico …”. – Ed Hugo colla sua flemma olimpica: “Ho capito: è del guano … meno gli uccelli …”.
Ritagli e scampoli. Letterati in vacanza, Corriere delle Puglie», Bari, Anno XXVI, N.° 238, 27 Agosto 1912, p. 3.
E’ tradizione antica che le vacanze dei letterati parigini debbano essere singolari. Balzac, quando era in campagna, faceva volentieri il pizzicagnolo nella bottega del villaggio.
I problemi della scuola. Nel Convegno di Macerata, «Scuola Italiana Moderna. Rivista settimanale d’insegnamento primario», Brescia, Anno XX, N. 42, 15 Settembre 1912, p. 321-324.
p. 323. Nella successiva giornata ha parlato il prof. Casalini sul tema della mutualità scolastica. Esordisce osservando che nei paesi rurali causa della non diffusione della pratica della mutualità è la mancanza di elementi che servono ad affiatare gli agricoltori tra loro. Venendo a parlare della piccola proprietà e della sua odierna diffusione, porta l'esempio del Balzac, che ci rappresentò il vero tipo del contadino egoista, ed il Casalini mostra che occorre un dirozzamento per fargli con prendere la vera importanza dell'associazione agraria.
La lettera internazionale a 10 centesimi! Una riforma rivoluzionaria. La posta prima del 1839, «Il Piccolo», Trieste, Anno XXXI, N. 11215, 29 Settembre 1912, p. II.
Non più a buon mercato era la posta in Francia, negli Stati italiani, nell’Impero, in Russia. Per i servizi internazionali la spesa cresceva a dismisura; e si sa del povero Balzac che smaniava perchè non aveva spesso i denari occorrenti per pagare la tassa delle lettere che gli mandava dal fondo dell’Ukrania (sic) «la diletta» sua contessa Hanska, primo grande ed ultimo misero amore del caposcuola del romanzo realista contemporaneo.
Spigolature, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CLXI – Della Raccolta CCXLV, Fascicolo 979, 1° ottobre 1912, pp. 526-527.
p. 526. Non è solo ai giorni nostri che gli scrittori di romanzi d’appendice guadagnano delle fortune: il Paris Journal riferisce le cifre delle somme guadagnate da romanzieri una volta di moda e si tratta veramente di compensi straordinari. […] La Presse pagò a Balzac per i Contadini 20.000 lire.
Ciò che si scrive, «Avanti! Giornale del Partito socialista», Roma, Anno XVI, Numero 277, 5 Ottobre 1912, p. 3.
A Passy presso Parigi, dove Balzac tanto lavorò, non lungi dalla superba villa di Gioacchino Rossini, accanto alla casa del romanziere, in fondo al sobborgo nella via Raynouard, c'è oggi, ancora una piccola vigna. Alcuni fedeli del grande scrittore hanno trasformato la casa in un museo, ed ogni autunno, in picciol numero, si recano a vendemmiare la vigna. L'uva della vigna di Balzac! Mangiarla non equivale a mangiare, per un egittologo fanatico, del pane fabbricato con frumento trovato nel sarcofago di una regina? E’ l'uva di Balzac creatore. Infatti Balzac ha creato. Egli non mentiva mai: ciò che affermava esisteva veramente in lui. Il Corriere delle Puglie raccoglie qualche aneddoto di questa creazione che dà forma reale, vivente, ai sogni dell’artista. Un giorno un amico entrò bruscamente nello studio di Balzac e annunziò la «signora Marneffe» (la signora Marneffe del romanzo «Cousine Bette»! …). Balzac, seriamente, si riavviò i capelli, si accomodò l’abito e rispose tosto: «Fatela entrare!» Cenava lo scrittore una sera a casa di Madame De Girardin e, poiché si parlava a tavola di storia naturale, Balzac immaginò una bestia inventata di sana pianta e si mise a parlarne. Gli ospiti rimasero assai stupiti. Allora il poeta Mery, ch’era tra i commensali, capita la storia, venne in soccorso del romanziere, e con la sua grande erudizione citò Plinio, Buffon, Cuvier, riuscendo ad interessare i convitati ai costumi dell’animale sconosciuto. Mery raccontò storie di viaggi, di scienziati, di naturalisti, snocciolando citazioni cervellotiche. Quando tutti si levarono da tavola, Balzac si avvicinò a Mery, e piano gli disse all’orecchio: «Ma davvero quell’animale esiste?» Perché no?, rispose Mery, non esistono forse Rastignac, papà Goriot, Eugenie (sic) Grandet e De Farlay (sic)? E questo fatto, scrive un letterato che in questi giorni ha potuto assaporare un grappolo della famosa vigna, si ripete ogni anno di questi giorni, allorchè in piccola brigata ci rechiamo a vendemmiare la vigna di Balzac. Quei grappoli d’uva balzachiana eccitano il nostro cervello, ci infiammano la fantasia, tanto che, durante la vendemmia, mentre discorriamo del maestro e dell’opera sua, ci sembra veramente di vedere tutti i personaggi della «Commedia Umana» muoversi attorno a noi, come esseri reali o visibili.
Marginalia. Balzac e un progetto di dramma storico, «Il Marzocco», Firenze, Anno XVII, N. 40, 6 Ottobre 1912, p. 5.
Un dopo pranzo dell’estate 1847, Ippolito Holstein, direttore del Teatro Storico, stava prendendo il fresco nel suo giardino di Bougival quando gli fu annunziata una visita. Era Balzac, il gran Balzac costruttore di nuovi progetti ad ogni ora, il quale veniva a proporgli un grande dramma pel suo teatro storico. Il dramma, naturalmente, non era scritto che nella mente feconda del romanziere, ma aveva già il suo titolo: Pietro II e Caterina di Russia. Balzac non volle entrar nel salotto, non volle accettar complimenti inutili e, sedutosi anch’egli all’ombra, espose la sua intenzione. «A che punto siete del lavoro? Avete un piano dettagliato?», domandò l’Holstein. «Tutto è qua! – esclamò Balzac battendosi con una mano la fronte. – Se volete, si potrebbe dopo domani incominciar le prove del primo quadro». E cominciò senz’altro a raccontar il suo primo quadro. La scena rappresentava un albergo russo. Gran movimento di soldati sulla strada e nell’albergo. Una servetta passa da un gruppo all’altro, da un tavolo all’altro, corteggiatissima. Un soldato la stringe più da vicino, la fa sedere con lui, le offre da bere. Mentre i due si dimenticano, entra un ufficiale, li osserva, osserva specialmente la servetta, batte sulla spalla del soldato rudemente, lo riscuote, si fa dare il suo nome e il numero del suo reggimento, lo caccia e ne prende il posto, in compagnia della donzella. Ora è l’ufficiale che fa la corte da vicino alla serva, che si lascia metter le braccia al collo ed ubbriacar di sguardi e di vino. Ma ecco un altro personaggio si presenta proprio mentre l’ufficiale sta promettendo alla sua bella un alloggio più caldo dell’albergo. Tutti s’inginocchiano. L’uomo ammantellato si scopre. È l’imperatore. Anch’egli batte sulla spalla dell’ufficiale che resta allibito, ammutolito e se ne parte con la coda tra le gambe. Ma anche l’imperatore ha notato, più che l’ufficiale, la serva e mentre il damerino se ne va, promette alla donna: «Io ti darò un palazzo!». Così s’incontravano nel dramma storico di Balzac, Pietro II e Caterina di Russia. Balzac era entusiasta di questo primo quadro e si mostrava anche entusiasta della Russia. «La Russia è per i nostri teatri un (sic) miniera feconda da sfruttare anche dal punto decorativo e plastico. E gli abitanti? Cuori d’oro preferibili a noi. Quanto ai contadini, soltanto fra essi esistono oggi dei tenori. I nostri son tutti Prudhommes raffreddati! … E l’alta società russa? Adorabile! tanto più che vi ho scelto mia moglie!». A malgrado di tanti entusiasmi, Balzac non ne fece di nulla del suo dramma. Aspettava – dice la Quinzaine – particolari ed informazioni, aveva riflettuto all’impresa che era colossale. In breve, il dramma storico restò allo stato di progetto.
Riviste e giornali, «Corriere della Sera», Milano, Anno 37, 7 Ottobre 1912, p. 3.
Balzac, il gran Balzac, costruttore di nuovi progetti ad ogni ora, propose un giorno ad Holstein un gran dramma pel suo teatro Storico. Il dramma, naturalmente, non era scritto che nella mente feconda del romanziere, ma aveva già il suo tiolo: «Pietro II e Caterina di Russia». «A che punto siete del lavoro? Avete un piano dettagliato?» – domandò l’Holstein. «Tutto è qua! – esclamò Balzac battendosi con una mano la fronte –. Se volete, si potrebbe dopo domani incominciar le prove del primo quadro». E cominciò senz’altro a raccontar il suo primo quadro. La scena – narra il Marzocco [cfr. scheda precedente] – rappresentava un albergo russo. Gran movimento di soldati sulla strada e nell’albergo. Una servetta passa da un gruppo all’altro, da un tavolo all’altro, corteggiatissima. Un soldato la stringe più da vicino, le offre da bere. Mentre i due si dimenticano, entra un ufficiale, li osserva, batte sulla spalla del soldato rudemente. Ora è l’ufficiale che fa la corte da vicino alla serva. Ma ecco un altro personaggio si presenta proprio mentre l’ufficiale sta promettendo alla sua bella un alloggio più caldo dell’albergo. Tutti s’inginocchiano. E’ l’imperatore. Anch’egli batte sulla spalla dell’ufficiale, che resta ammutolito e se ne va. Ma anche l’imperatore ha notato, più che l’ufficiale, la serva; e mentre il damerino se ne va, promette alla donna: «Io ti darò un palazzo!» Così s’incontravano nel dramma storico di Balzac, Pietro II e Caterina di Russia. Balzac era entusiasta di questo primo quadro, ma … il dramma non venne mai alla luce. Dopo pochi giorni l’autore, come per tante altre cose, aveva mutato progetto …
Notiziario. Settecento. Goldoni, «Rassegna bibliografica della letteratura italiana», Pisa, Tipografia Editrice Cav. Francesco Mariotti, Anno XX, Nuova serie, Vol. II, Num. 10, 31 Ottobre 1912, pp. 307-308.
p. 308. Osservatore meraviglioso, l’autore dei Rusteghi ci dava già nel Settecento una compiuta e vivace pittura della società di tutto un secolo che trova l’uguale soltanto nella Comédie humaine del Balzac.
Curiosi errori letterari, «L’Unione liberale. Corriere quotidiano dell’Umbria», Perugia, Anno XXXI, Num. 250, 30-31 Ottobre 1912, pp. 1-2.
p. 1. Un anacronismo imperdonabile commette Balzac nel «Cousin Pons», parlando d’un ventaglio «divin chef-d’oeuvre que Louis XV a bien certainement commandé pour M.me de Pompadour. Watteau s’est exterminé à composer cela!». E Watteau morì nel 1721, lo stesso anno in cui la marchesa veniva al mondo. Nella «Muse du Département», lo stesso Balzac descrive una servetta che, dopo aver bendato gli occhi a una persona, per impedirle di vedere, le fa questa strana raccomandazione: «State ben attenta! non perdete di vista nessuno dei miei segni!».
Marginalia. Le varianti di Madame Hanska, «Il Marzocco», Firenze, Anno XVII, N. 44, 3 Novembre 1912, p. 5.
La Correspondance generale di Balzac dava già il testo di trentadue lettere indirizzate a M.me Hanska e l’editore annunziava che il resto della corrispondenza di Balzac con questa femme distinguée era rimasto per disgrazia distrutto a Mosca durante un incendio occorso in casa della stessa signora. Invece ora queste lettere paiono essere rinate dalle ceneri, perché le abbiamo, in numero di duecentoquarantatré, nei due primi volumi di Lettres à l’étrangère. La cosa più singolare è quella che rivela e fa osservare con multipli esempi Joachim Merlant nella Revue Bleue[1]: M.me Hanska al tempo della prima pubblicazione della Correspondance ha corrotto con fini ben prestabiliti e con metodo sempre irritante il testo genuino delle lettere che Balzac le aveva scritto. Le correzioni o meglio appunto le corruzioni sono dovute da prima ad uno scrupolo accademico. Balzac scrive come può; le sue lettere sono spesso poco agghindate, bisognava far loro un po’ di toilette; e meno male. Ma ci sono varianti immaginate per risparmiare certe persone, varianti atte a mostrar dell’esistenza dello scrittore un’immagine più ornata e decente che gli faccia una fisionomia più nobile agli occhi della posterità, varianti infine che procedono da sentimenti intimi di M.me Hanska – piacere di far dire una malizia a Balzac, di volgere in maldicenza o in severità un detto indifferente o clemente, soprattutto arte attentissima di mostrar lei stessa come una principessa lontana che impone al suo adoratore, con una maestà graziosa, ma spietata, un contegno umilissimo e rispettosissimo di sospirante … Gli esempi che di tutto ciò ha saputo trovare il Merlant sono probantissimi. Non v’è che l’imbarazzo della scelta. M.me Hanska cambia non solo espressioni, propositi, fioriture, ma giudizi ed argomenti e cambia nomi e date quando le pare; Balzac scrive: «Al momento in cui, per la seconda volta nella mia vita, non facevo onore alla mia firma e ai lamenti della probità che piange dentro di noi, si aggiungeva il sentimento della profonda solitudine in cui questa volta entro solo …». M.me Hanska pubblica: «Nel momento in cui, per la seconda volta nella mia vita, mi trovavo rovinato da un disastro imprevisto e completo ed alle inquietudini dell’avvenire si aggiungeva etc.». Balzac scrive: «Infine voglio terminare la mia giovinezza con tutta la mia giovinezza, con un’opera al di fuori di tutte le altre opere mie, con un libro a parte che resti in tutte le mani, su tutte le tavole, ardente e innocente, con una colpa, perché vi sia un pentimento violento, mondano e religioso, pieno di consolazioni, pieno di lacrime e di piaceri …». M.me Hanska pubblica: «Voglio terminare la mia giovinezza, non tutta la mia giovinezza con un’opera che resti in tutte le mani femminili, su tutte le tavole, in cui voglio descrivere i timori insensati, le glorie fuor di proposito, la sublimità del dono di se stesso, e vi sia una colpa perché vi sia un’espiazione!». Alcune volte M.me Hanska empie di lodi per lei le lettere di Balzac, di lodi, non di vezzeggiativi. Se Balzac le scrive ma Loulou ella si fa invece chiamare ma princesse. Se Balzac elogia il genio critico che ella dimostra nell’esaminare un suo lavoro, ella rincara la dose. «Sì … non schernitevi, non fate il vostro piccolo gesto familiare, non copritevi gli occhi con le vostre manine affusolate e bianche. I nostri più rinomati critici contemporanei non sarebbero stati più sapienti!». Tutto questo, per esempio, è aggiunto ad una semplicista frase. Queste constatazioni ci edificano su M.me Hanska e ci fanno molto diffidare della Correspondance di Balzac che può essere stata tutta rimaneggiata a questo modo.
Ciò che leggono gli studenti francesi e quelli tedeschi, «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XXII, Vol. XXXII, N. 22, 15 novembre 1912, pp. 1041-1042.
p. 1041. Gli autori preferiti dagli studenti stranieri a Parigi sono: Rousseau, Hugo, Musset, Heine, Sand, Balzac, Maupassant, Dumas figlio, Zola, i Goncourt […]. […]
Alquanto diversi sono i gusti degli studenti che frequentano la biblioteca dell’Institut catholique. Esaminando il movimento dei suoi 20 mila volumi durante un mese, notiamo con maggior frequenza i nomi di San Tommaso, Montaigne, Augusto Comte, Le Play, Chateaubriand, Vigny, Lacordaire, Montalambert, Balzac, Flaubert […].
Romanzo nero, «L’Asino», Roma, Anno XXI, N. 52, 29 Dicembre 1912, p. 4.
Durante il 1913 l’Asino […] pubblicherà tre romanzi ricchi d’interesse, di passione, di vivacità e di dolore, dovuti a penne illustri e battagliere:
Un romanzo di Balzac; […]. [come annunciato nei primi numeri dell’annata 1913, si tratterebbe de: Il figlio del Vescovo, di cui, però, non abbiamo trovato traccia].
Balzac, il titano del romanzo vivace e brioso, dalla satira acuta e dal sorriso profondo.
Giornali e Riviste, «La Stampa», Torino, Anno XLVI, Num. 363, 31 Dicembre 1912, p. 3.
Il dott. Maurice Betteval analizza nella Vie française alcune note inedite di Zola che non sono inutili per meglio conoscere le idee direttive del robustissimo scrittore. […] In un foglietto c’è una nota: Qual è la differenza fra Balzac e Zola? E’ lecito paragonarmi a lui? … Io non voglio, come Balzac giudicare gli uomini, sentenziare sulle loro vicende, essere filosofo, uomo politico e moralista. Io mi accontento di conoscere la realtà e di descriverla cercando le ragioni e le cause che l’hanno creata.
A., Intorno a Ouchy. Il trucco, Corriere delle Puglie», Bari, Anno XXVI, N.° 269, 27 Settembre 1912, p. 1.
Nella scena della vita, insegnava Balzac, questo titanico conoscitore di uomini e di anime, bisogna irrompere come una palla di cannone o scivolarvi come la peste.
[Paul Adam], L’«Associé», «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XXII, Vol. XXXII, N. 6, 15 marzo 1912, pp. 256-257.[2]
p. 256. Il nome di Lucien Mühlfeld evoca il ricordo di molte opere belle […]. L’adolescente che legge le Rouge et le Noir, l’Armance di Stendhal, i principali romanzi di Balzac, il Dominique di Fromentin, l’Education sentimentale di Flaubert, il Monsieur de Camors d’Octave Feuillet, s’istruisce sugli uomini e sui modi della lotta sociale: non può completare, tuttavia, la sua cognizione degli esseri che si muovono intorno a lui, se non apprende anche la verità contenuta oggi nell’Associé. […].
Pochi scrittori, dopo Fromentin, Balzac o Stendhal, hanno posseduto l’arte di analizzare le menti dei loro contemporanei, per mostrarne le energie e le manchevolezze […]. Studio minuzioso e probo del matrimonio moderno nelle classi elevate, quest’opera continua e completa l’indimenticabile libro di Balzac, les Mémoires de deux jeunes mariées; e mostra l’evoluzione compiutasi in tre quarti di secolo nell’anima femminile.
Augusto Agabiti, La riforma moderna dei cimiteri (L’apparecchio “Karnice” per il salvataggio degl’inumati vivi), «Rivista Bibliografica Italiana», Firenze, Anno XVII, Vol. CLXXXVIII, N. 22, 16 Novembre 1912, pp. 421-453.
p. 421. Come quei grandi oggetti dei veneziani, di vetro sculto modellato o ricamato o tessuto, larghi lampadari lucenti e brunite specchiere, sembrano certi animi umani; buoni e raffinati, tuttavia se un colpo violento li batte e li spezza, diventano brutti e pericolosi d’un tratto: le punte stracciano, i lati tagliano per la frattura!
Questo accadde del signor di Vendôme, padrone della villa ornata e scura, detta la Grande Bretêche; cui il Balzac vide chiusa cadente, votata a lenta rovina, da un testamento.
Dopo qualche lustro d’amore e di cortesie usate alla consorte, gentile colta e leggiadra, che fu virtuosa e saggia tutta la vita fuorchè un istante fatale, il signore, buono e generoso fin quando si credette felice, doveva avere d’un subito, in una notte funesta (tornando a casa inaspettato dopo lunghe dispute di politica e di giuoco) un rivolgimento intiero della psiche; la quale come i vertebrati, ha in tempi normali le parti ossee e rigide ricoperte di grasso soffice e di muscoli, ed in momenti di crisi l’ossa acute pone all’esterno, divenendo, a somiglianza dei crostacei, un pugno di budellame cinto e corazzato di aculei.
Sibilla Aleramo, Scritti diversi su Balzac e note di lettura su “Père Goriot”, in Scritti. Note di taccuino, Roma, Fondazione Istituto Gramsci, 1912.
Onorato Allocco-Castellino, Alberto Nota. Ricerche intorno la vita e le commedie con lettere inedite, ritratti ed appendice, Torino, S. Lattes & C. – Librai-Editori, 1912.
p. 104. E, a proposito sempre di imitazione, bisogna andare a rilento nell’apprezzarla. Non basta una somiglianza d'intrecci a condannare le produzioni posteriori a quella che prima ha posto quell'intreccio; Mercadet di Onorato di Balzac non toglie nessun pregio a Les affaires sont les affaires del Mirbeau, né a Il più forte del Giacosa; i Disonesti del Rovetta non perdono nulla per essere venuti dopo i Tristi amori del Giacosa.
Artemidoro, “La Straniera” di Balzac, «Avanti! Giornale del Partito socialista», Roma, Anno XVI, Numero 224, 13 Agosto 1912, p. 3.
Se ci era noto il romanzo dell’amore di Balzac, la pubblicazione delle lettere di Balzac all’Etrangère ci hanno fatto conoscere anche la donna — la sola forse — che l’autore della Commedia Umana abbia amata appassionatamente.
Che delusione! con che accorata tristezza si è costretti a riconoscere quale piccola anima ospitassero le belle forme di Evelina di Hanska! Come è doloroso riconoscere che il più devoto ed eloquente poeta dell’amore, il paladino della donna, l’analizzatore sottile e delicato della bellezza e della sensibilità delle figlie di Eva, l’apologista delle vecchie zitelle, colui che volle scoprire tesori di bontà quando non poteva esaltare fascino di bellezza, il fervente che giunse a conferire una seconda esistenza alla umanità femminile, prolungando fino ad oltre i trent’anni la divina gioventù dell’amore muliebre che i suoi contemporanei restringevano entro i vent’anni, Onorato Balzac, infine, non conobbe che l’amore di una frigida, pretenziosa e bisbetica polacca!
Povero grand’uomo! Nel 1832 aveva 33 anni. Già celebre, ma dissestato dalle sue folli imprese industriali, aveva, per rifarsi, iniziato quel lavoro gigantesco che durò quattro lustri, ed a cui ne dobbiamo quell’imperituro monumento che è la Comédie humaine, si deve pure la morte prematura del grandissimo artista.
La contessa Evelina di Hanska era di cinque anni minore di lui. Nata Rzewuska, di famiglia polacca numerosa e poco agiata, da creatura pratica aveva fatto un eccellente matrimonio, sposando il conte Hanski più vecchio di un quarto di secolo, ricchissimo, poco socievole, e che viveva quasi sempre nel suo castello di Wierzchownia in Ukrania. La contessa era bella, e si annoiava; leggeva per distrarsi, coltivando così la sua inclinazione al misticismo, ed esaltando in pari tempo la sua anima romanzesca. La peau de chagrin di Balzac, pubblicata in quell’anno, le suggerì di scrivere all’autore una lettera datata da Odessa, firmata l’étrangère, che non fu conservata ma, che a volerne presumere il contenuto dalla intonazione di lettere sue ancora esistenti pare si diffondesse in lodi per lo scrittore preconizzandogli successi ancor più notevoli, solo che avesse trascurato le volgari realtà della vita per porgere orecchio ad una Egeria sentimentale, che avrebbe anche potuto essere la sua corrispondente di Odessa.
La provenienza, la firma, il suggello della lettera, esaltarono straordinariamente lo spirito avventuroso di Balzac, che sognò senza dubbio amori gentilizi e cosmopoliti. Qualche tempo dopo, la contessa svelò il suo vero nome, ed il rapimento del romanziere per questa gentil donna che piombava nella sua vita come un aereolito, s’accrebbe considerevolmente. Da lei infatti accetta ogni cosa; acconsente ad adorarla in ginocchio, va in delirio pel suo stile da bacchettona, preferisce una lettera della contessa alla gloria di Byron, ha deciso ad amarla anche senza speranza di dedizione, pur d’essere almeno un poco amato da lei.
Espressioni iperboliche, di una passione tutta cerebrale, che nella realtà non distraevano troppo Balzac dal suo diuturno lavoro. Infatti, alla contessa che si lamenta dei suoi lunghi silenzi, risponde di averle scritte infinite epistole, abbruciate poi col dubbio di dispiacerle; essa si meraviglia di ricevere lettere sue di una calligrafia ignota — erano scritte dalla signora Zulma Carraud alla cui opera d’amanuense il romanziere ricorreva spesso quand’era sovraccarico di lavoro — spiega ch’egli ha tante forme di scrittura quanti sono i giorni dell’anno. Ma la sua illusione almeno è profonda e sincera, e se non è veramente innamorato è tanto convinto d’esserlo sul serio, che per le conseguenze dell’idillio il suo stato d’animo è nel tono conveniente.
Dopo quasi due anni di assidua corrispondenza, nell’ottobre 1833, a Neuchâtel, Balzac ha modo d’incontrarsi colla sua misteriosa ammiratrice. Pare che la contessa Hanska non rimanesse molto rapita dalla figura del romanziere, e la di lui persona fisicamente grossolana e la sua mise trasandata, autorizzano questa supposizione.
La bellezza della signora rinsalda invece Balzac nella sua adorazione, e di ritorno a Parigi tempesta l’amica di lettere appassionatissime, e, questa volta evidentemente sincero. Non bisogna, del resto dimenticare che per le sue ristrettezze finanziarie e per i suoi impegni editoriali egli aveva dovuto darsi una pena infinità per ritrovarsi con lei e che, com’egli le scrisse: «A forza di fare sacrifici un uomo si interessa alla creatura che glieli impone». Queste fatiche sue erano così gravi, che mentre concerta il nuovo convegno di Ginevra ch’ebbe luogo tre mesi dopo, in dicembre, non può tacere alla contessa che lavora 17 ore al giorno per trovare il tempo e il danaro pel viaggio, aggiungendo che sacrifica qualche anno di vita al piacere di trovarsi con lei.
Sarebbe stato più delicato lasciare che essa intuisse ciò, ma la signora di Hanska non avrebbe certo indovinato. Messasi al riparo d’ogni necessità con un matrimonio cospicuo, non avverte neppure il disperato affannarsi degli altri, e Balzac può scriverle crudamente: «Io che conosco anche la miseria posso gridarvi dal mio tavolino da lavoro: Godete del benessere materiale che vi offre il signor Hanski e che voi mi vantate a ragione» senza ch’essa si commuova, alla lotta disperata combattuta dall’amico suo, contro le enormi difficoltà di un’esistenza tempestosissima.
Questa infernale attività dell’autore della Comédie Humaine è troppo nota per insistervi. Si sa com’egli si coricasse alle sei di sera per alzarsi a mezzanotte, ostinandosi per dodici ore ininterrotte in quella sua immane produzione che faceva esclamare ad un avversario: «La resistenza e la fermezza possono essere incredibili sforzi di una volontà tenacissima, ma dove e come quest’uomo si fabbrica del tempo?». E del tempo egli ne ha ancor per rispondere alla contessa che esigendo molto e nulla concedendogli, si mostra pure gelosa. Balzac cerca vincere i suoi sospetti con singolari obbiezioni; dopo averle detto che non può esserci per lui che il suo lavoro ed il suo amore, il suo amore ed il suo lavoro, conclude: «Dormi tranquilla, o mia gelosa! Aggiunge: «Ingannarti? Ma sarebbe troppo facile!» oppure «Il medico mi assicura che un donnaiolo non avrebbe il mio sguardo di fuoco!».
Nel secondo convegno che ebbe luogo, come dicemmo, a Ginevra, e che durò sei settimane, l’amore di Balzac e della signora di Hanska, toccò il suo apogeo. Le lettere che il romanziere scrisse subito dopo all’amante — possiamo oramai chiamarla così — respirano una tenerezza appassionata ed un ardente desiderio. Esse rivelano un cuore buono al quale la realtà dell’amore diede un infinito rapimento, e che per qualche giorno almeno, nulla domanda all’arte ed alla vita che non sia il possesso della persona che ama.
Due anni dopo, a Vienna, Balzac rivede ancora l’amica e ritrova con lei la intima e deliziosa felicità di Ginevra, però lettere scritte in seguito, dal 1835 fino alla morte del conte di Hanska (sic), avvenuta sei anni dopo, testimoniano di un attaccamento sincero, ma assai più calmo.
I due amanti contando sulla tarda età del marito si erano mutualmente promessi in matrimonio fin dai primi incontri. Nondimeno protrassero ancora per nove lunghi anni la loro unione per ragioni che rimasero ignote. Balzac volle forse nobilmente regolare prima lo stato della sua fortuna? O la contessa, prima della sua, volle assicurata la felicità di Anna, la sua unica figliuola superstite? O trovò in famiglia opposizioni insormontabili?
Le lettere che abbracciano tutta quest’epoca non risolvono i dubbi. Nei primi tempi egli la sprona a lasciare presto la Russia, poi insiste sui due eterni temi che gravano la sua esistenza; il lavoro ed i debiti. Deve quasi duecento mila lire, e non può contare che sulla inesauribile produzione della sua mente. Lo sanno bisognoso e lo sfruttano, e mentre Eugenio Sue, milionario, può dettare le sue condizioni, egli è costretto a subire le imposizioni dei suoi debitori.
La questione economica ch’egli pel primo pose arditamente come il più tragico movente d’ogni nostro destino, incombe inesorabile sul suo. Ed è forse ancora la questione economica che ritarda il suo matrimonio. La contessa infatti, esita, si lamenta, suscita delle difficoltà, trema dinnanzi alla cifra dei debiti ch’egli le confessa, dubita di poter vivere a Parigi con cinquecentomila lire di reddito, ed in luogo di affrettare le nozze per avere diritto di sovvenire il disgraziato le indugia e le differisce. Si direbbe che la buona borghese rimpianga il conte di Hanski, che serviva a proteggerla contro l’amante. E nello stesso tempo, mentre per conto suo non trova tempo per scrivergli, deplora l’aridità epistolare dell’amico; e Balzac a rispondere: «Per scrivere, com’io faccio, delle opere di getto in sette, otto o quindici giorni, devo alzarmi alle due di notte, lavorare quindici ore continue, e negli intervalli pensare alle file dell’intreccio, alle scene, alla loro disposizione … Per scrivere alla donna che più si ama è necessario deporre il fardello delle preoccupazioni letterarie e delle combinazioni drammatiche. Ciò si può forse far sempre? …».
E le spiega com’egli non si conceda nemmeno il tempo per lavarsi ed abbigliarsi, e come, scrivendole, è spesso come se le sacrificasse un buono da mille.
La contessa non manca pure di mostrarsi gelosa, e Balzac a rassicurarla, confessandole che non ebbe mai buona fortuna in amore. E scrive: «Io non nego che delle donne si siano lasciate conquistare da un immaginario signor di Balzac e che abbiano cercato di conoscere quel grasso soldataccio paffuto che io sono. Ma le donne vogliono tutte (le più grandi come le più piccole, la duchessa come la cucitrice) che non ci si occupi che di loro, e non soffrono che un uomo si lasci assorbire, non fosse che per dieci giorni, da qualunque cosa, anche la più grande. Ed ecco perché non amano che gli sciocchi. Lo sciocco concede loro tutto il suo tempo e le persuade di essere amate non interessandosi che di loro. Che un uomo di genio accordi ad una donna il suo cuore e la sua fortuna … se non le sacrifica anche il suo tempo, la migliore fra di esse non si crederà ancora abbastanza amata ...».
Malgrado queste crude parole, che potrebbero contenere un’aspra rampogna, la signora di Hanska è sempre viva nel pensiero e nei sensi del grande romanziere; ma essa si mostra pur sempre animata verso di lui da un egoismo atroce per quanto forse incosciente, così da giustificare l’espressione attribuita a Balzac, e che, se autentica, non può essergli sfuggita che negli ultimi suoi mesi di vita, che quella donna lo aveva assassinato a poco a poco».
Ad ogni nuovo convegno — in questo tempo si rividero a Pietroburgo, a Canstast [?] ed a Parigi — noi ritroviamo il grand’uomo più tenero, più riconoscente, più entusiasta che mai, ma le lettere della contessa continuano ad essere irte di cifre ed ispide d’affari.
Di questa lunga avventura durata 18 anni, conosciamo la conclusione.
Sposatisi all’estero il 15 aprile 1850, furono a Parigi nel maggio. Per ricevervi degnamente la donna, destinata al tramonto della sua esistenza, Balzac aveva fatto adornare ed infiorare la sua casa.
Era già scesa la notte quando vi giunsero. Dalla via vedevano le finestre illuminate, ma nessuno accorse allo squillare del campanello. Malgrado l’ora tarda si dovette chiamare un fabbro per rompere la serratura e quando, alla fine, ebbero modo di penetrare nell’appartamento, trovarono il loro domestico improvvisamente impazzito, che correva per le camere, pronunciando parole incoerenti.
Ma questo impressionante episodio è poca cosa, in paragone del dramma che offerse la morte di Balzac. Morì 4 mesi e due giorni dopo le nozze, e questa unione, frutto di tanti sogni e di tante speranze, si era già infranta. L’eccesso di lavoro aveva fiaccata la sua fibra. Victor Hugo che lo seppe gravemente infermo, andato a visitarlo fu ricevuto da una fantesca che gli disse appena; — E’ perduto, la signora non c’è.
Il poeta entrò tuttavia nella camera del moribondo. Vi trovò una vecchia dama — la madre del romanziere che finiva così di sfruttarne il genio ed il cuore — e due vecchi domestici. La signora Evelina di Hanska diventata signora Balzac era infatti partita. Qualche tempo dopo i funerali l’erba cresceva già folta sulla tomba abbandonata del grande scrittore. E’ onesto però riconoscere che la vedova accettò lealmente la successione oberata del marito; fu questo, in seguito, un eccellente affare per lei, ma essa allora, non poteva dubitarne.
Ad ogni modo, se la contessa di Hanska ebbe l’immeritato onore di associare il suo nome a quello immortale di Balzac, resterà tuttavia per gli ammiratori del glorioso maestro ciò che fu sempre realmente per lui: la straniera.
Clelia Barucchi, Études critiques. Le soldat italien jugé par Balzac lors de l’occupation de Tarragone par l’armée de Napoléon. A de Vigny et son pessimisme, Pavia, Tipografia popolare, 1912, pp. 1-15.
«La nostra città accoglie da due giorni fra le sue mura il signor di Balzac, lo scrittore francese che in pochi anni fece il maggior numero di opere che descrivono in ogni maniera la vita dell’uomo e la società; quello ch’è anche il più popolare fra di noi, perché i suoi scritti corrono nelle mani di tutti in originale e tradotti. Esso viaggia in Italia per raccogliere materiali onde scrivere le campagne dei francesi nella Penisola. Questa notizia tanto più ne riesce gradevole, perché siamo certi che il genio di Balzac avrà dal nostro cielo le sue più belle ispirazioni».
C’est avec ces paroles flatteuses que le célèbre polygraphe Sacchi accueille Honoré de Balzac lors de son arrivée à Milan en 1837. Et l’aristocratie milanaise, qui constituait le milieu le plus intellectuel de la ville, démontra tout de suite que l’admiration renfermée dans ces phrases avait un écho partout. L’auteur de la «Comédie humaine», que la renommée littéraire entourait d’une auréole de gloire, était aussi l’homme à la mode auquel l’éclat des succès obtenus dans les Salons parisiens ajoutait une importance hors ligne et un charme nouveau. Aussi dans les familles aristocratiques on se dispute l’écrivain comme le plus bel ornement des Salons, comme un de ces héros du jour dont la seule présence nous honore.
Mais l’esprit caustique de Balzac ne voyait peut-être dans toutes ces démonstrations de sympathie que la gaucherie provinciale, si finement analysée par lui dans quelques scènes de la «Comédie humaine» — car les jugements qu’il formula sur la Société Milanaise ne s’accordent pas avec l’esprit d’un docteur en sciences sociales, comme il aimait à se baptiser, ni avec les sentiments d’un gentilhomme qui venait d’accepter une hospitalité si cordiale. —
On connaît en effet les opinions qu’il manifesta publiquement à Venise chez le Sénateur Soranzo quelques mois après sa demeure à Milan: il osa toucher de son mépris même à la vénérable majesté littéraire de Manzoni et au saint patriotisme qui inspirait Grossi et D’Azeglio.
Ce n’était pourtant pas une nouveauté chez Balzac que cette hostilité contre toute manifestation de l’esprit italien! Déjà en 1832 dans les «Scènes de la vie Parisienne» et plus particulièrement dans une Nouvelle «Les Marana» il avait tracé une esquisse si malveillante du caractère italien qu’il vaut vraiment la peine d’analyser ces curieux — essais de psycologie (sic) sociale — pour en faire ressortir l’inconsistence (sic).
Il me semble inutile de résumer cette Nouvelle dont le seul épisode qui nous intéresse est la prise de Tarragone par l’armée Napoléonienne, et je me bornerai à une remarque: tandis que la tradition a consacré une renommée de bravoure et de gloire aux italiens faisant partie de cette armée, Balzac nous les présente dans sa Nouvelle comme de vrais barbares sans religion et sans honneur. Des types tels que le capitaine Bianchi et le Marquis de Montefiore sont tout ce que de plus conventionnel et de plus fictif peut avoir rêvé l’imagination d’un romancier.
Le célèbre sergent Bianchini devient le «capitaine Bianchi» un véritable antropophage (sic) indigne de vivre parmi les hommes civilisés du XIXe siècle : «Le capitaine Bianchi, le même qui, pendant la campagne avait parié manger le cœur d’une sentinelle espagnole, et le mangea». Et plus loin ; «quoique Bianchi fût le prince des démons incarnés ... il eût été un admirable flibustier».
Le pillage qui accompagna la prise de Tarragone eut, selon Balzac «sa cause occulte».
C’est qu’il y avait un Régiment presque entièrement composé d’italiens! Et les Italiens incorporés dans le 6e de Ligne n’étaient que des «mauvais sujets, donnant des craintes pour leur avenir» et ils s’étaient tous créé «La réputation la plus détestable dans la vie privée».
C’est pourquoi Balzac ne trouva pas de mieux à faire que d’attribuer le déplorable pillage de Tarragone à ces «mauvais sujets» les premiers à l’assaut, les premiers qui entrèrent dans la ville. Ce sont eux les lâches — les cruels — les barbares — car les soldats français, même au moment de tuer les ennemis n’oublient pas de leur apprendre — «le bon ton — l’élégance de la mise — l’esprit de société — la civilisation, la valeur, la force du génie». Quel bonheur que de recevoir la mort de la main d’un français! Et ce qu’il y a de plus curieux et de plus triste dans toutes ces affirmations, c’est que toutes les fois qu’on demande à l’écrivain la source à laquelle il a atteint des nouvelles si dignes de foi, il ne sait nous citer que des «propos de conversations», des renseignements appris par des «militaires de bonne foi». L’auteur de la «Comédie humaine» ne devait vraiment pas être bien fameux en matière d’histoire!
Heureusement les Italiens ne subirent pas en silence de pareilles insultes! Un vieux officier de cavalerie, Antoine Lissoni de Milan, historien des guerres de Napoléon en Espagne qu’il a suivies pas à pas se charge de venger l’honneur des armes nationales dans un beau discours publié à Milan en 1837. Et au nom de la fierté italienne que l’écrivain français avait foulée aux pieds, il reproche à Balzac ses nombreuses contradictions historiques et ses faux jugements sur la vie et sur le caractère de l’Italie.
C’est avec un élan passionné que Lissoni défend sa cause; — et son discours, plus qu’un pamphlet injurieux, est un cri de douleur; plus que de la rancune contre l’écrivain français, on y trouve la désillusion profonde du patriote qui voit mépriser sa patrie et flétrir ses idéalités les plus nobles par un homme de génie tel que Balzac.
C’est l’âme de notre race offensée qui frissonne dans ces pages d’une éloquence suggestive.
On dirait que l’écrivain ne parle pas seulement à Balzac, mais qu’ il s’adresse à la foule des étrangers nous jugeant si légèrement d’après les impressions personnelles de quelque écrivain trop superficiel. C’est la révolte de l’âme italienne qui cherche à faire valoir ses droits historiques et qui révèle au monde entier ses nobles aspirations de liberté et de gloire.
Sous un tel point de vue l’apologie de ce vieux soldat quittant l’épée pour saisir la plume en faveur de sa patrie, prend un caractère d’élévation morale supérieure à celle qui avait inspiré le pamphlet.
A travers ses protestations et ses critiques l’écrivain reste toujours un juge impartial et serein: il ne conteste jamais le génie de Balzac il ne condamne jamais l’œuvre du romancier; il exige seulement de lui une rectification qui sera d’autant plus glorieuse que le nom de Balzac s’élève sur celui de ses contemporains. Avec quelle ardeur d’enthousiasme il exprime de pareils sentiments dans la touchante péroraison qui finit sa défense pro aris et focis.
«Raccogli pure, quanto più ne vuoi, di notizie storiche, antiche o moderne, politiche o militari italiane, ma non far tesoro, non t’adeschino le turpi. se pur gli è il vero che ve ne siano, non fermare il tuo cuore sopra quelle che ti potessero dare facil presa a mordere, a ingiuriar gl’italiani, e non appigliarti al male che tutti hanno. e le nazioni in generale e in particolare ogni uomo, e sopra tutto non tramutare le nostre virtù in delitti, in opere da vitupero. Che alla fin fine per l’una cosa che tu potessi dettare vituperosa all’onore italiano, noi ne potremmo divisare a minuto e scrivere le cento, e in fatto poi di ruberie e di rapine per l’una che tu potessi notarne, ogn’italiano, ogni città, ogni terra, i conventi, i monasteri, i municipi, le confraternite, le chiese te ne rechcrebber tutti in ispettacolo una schiera senza numero d’ogni qualità, d’ogni fatto.
Fa di ammendare il passato, di correggere il fatto, che il dirsi ingannato, il confessarsi errato non è come avvisa il prepotente, il superbo, il temerario, non è no, una viltà, una vergogna, ma si la prova più sicura di sapienza, di virtù, di grandezza d’animo, e il vero saggio allora solamente è grande che riesce a tutti di scuola a virtù, allora solamente può tenersi maggiore degli altri che se ne rende un esempio a cui informarsi.
«Non guardare all’Italia quasi fosse una vile schiava, ma si come a Donna che sempre impera del suo bello, e dell’ingegno suo; guardala a quella guisa che figliuolo guarda alla madre sua, che madre davvero ella fu a molte nazioni, e non montare in superbia, che la figlia sia venuta a tanta potenza e grandezza, chè madre augusta, ingegnosa, eccellente è ancor la mia.
E poichè al dire di te medesimo corrono nelle conversazioni della tua Parigi le menzogne più ingiuriose agl’Italiani, chiarito della cosa, fa ora di nettarci di quelle macchie onde l’invidia. il mal talento o la perversità di qualcuno de’ tuoi ne ha voluto bruttare. Adopera da giusto, ti comporta da verace, da sincero sapiente, che se la calunnia è il pessimo dei delitti, se il sostenere l’ingiustizia è da forte, il ritorcerla in proprio vantaggio è da bassissimo scellerato.
E conoscente appieno come devi esser di noi, non ti cada mai dalla mente, che se il dimenticare i benefizi è da ingrato, se il tacere, il celare le glorie degli emuli, dei compagni è opera da invidioso; il voltare le vittorie altrui in vitupero, in obbrobrio, non è cosa certo da magnanimo. da leale francese».
Cependant cette éloquente apostrophe de Lissoni ne reçu (sic) point de réponse; l’écho de ces mots sévères s’était peut être perdu au milieu des louanges qui de toute part arrivaient à l’écrivain français!
En résumant, ce romancier à l’imagination ardente à la fantasie (sic) débridée n’avait pas l’impartialité ni le sens critiqué auxquels doit toujours s’inspirer un historien: ce qui nous frappe en effet dans «Les Marana» c’est le manque de vérité historique.
Car appeler, historique, une digression bâtie d’après les propos de quelques «militaires de bonne foi» c’est confondre l’art d’imaginer et de conduire un conte fantastique avec l’esprit de critique le plus élémentaire.
Les objections de Lissoni acquièrent une supériorité incontestable sur les affirmations de Balzac, car lui il n’avance jamais rien qu’il ne soutienne par l’autorité d’un témoin indiscutable: il a assisté lui-même aux guerres d’Espagne, il a vu les italiens se jeter au milieu des balles, pleins de courage, d’enthousiame et de foi, insouciants du danger, indifférents à la mort; il a entendu le Général Suchet s’ écrier dans un élan d’admiration: «Ah ! Ils sont de vrais descendants des anciens Romains» il a arraché lui-même deux ou trois pauvres espagnols à la fureur brutale des français!
«Io dormii, o meglio io passai quella tremenda notte in Tarragona, io fui spettatore, testimonio di quella scena d’orrore, di barbarie, e però debbo saper le cose, e non le so per racconto che altri me n’abbia fatto, non le so per dicerie che abbia udito, ma perché ne fui io medesimo testimonio e piccolissima parte. Io vidi quella orrenda catastrofe, io salvai i due, i tre catalani. e sempre dalle zanne dei francesi io li salvai!
Le piazze, le vie, ogni casa era una nuova scena di dolore, di miserie, di sangue. Dopo l’ammazzamento dei resistenti, dopo fuggito il grosso della guarnigione, non s’avea in Tarragona persona che la durasse alla resistenza, alla difesa; nondimeno la strage continuava feroce sugli inermi, sui vecchi, sulle donne, sui teneri lattanti.
Si ammazzava, si feriva senza un perché, senza sapere il perché si ferisse, si ammazzasse; si ammazzava, si feriva alla cieca, alla bestiale, pel solo orrendo piacere di ammazzare, di ferire, ché là il ferire e l’uccidere bisogna dir proprio fosse un piacere. Niente era che salvar potesse quegli sventurati. La viltà non profittava loro a nulla. il coraggio, la resistenza non valevano che solo a rendere più atroce la loro morte.
Battevan de’ pie’ in terra i fanciulli, si tuffavano i pargoletti in seno delle loro madri; supplicavan le madri, le spose, le vergini, richiedevan pietà di una vita già tanto affannosa, disperata, diserta; si gettavano ginocchioni dinanzi a quei bruti gli ufficiali spagnoli, i cittadini d’ogni età, d’ogni condizione, ma ferite crudeli, ma la morte, l’uno dopo l’altro perché fosse più spaventosa e più terribile, eran le risposte, era l’umanità di quei truci, di quei civilissimi assassini».
Et cela suffit, je crois, pour mettre en relief l’inconsistance des affirmations de Balzac dans cette fâcheuse polémique qui nous démontre avec quelle légèreté extraordinaire des étrangers, même de génie, résolvent certains problèmes de psycologie sociale sans en connaître les éléments les plus essentiels ou se laissant guider par de fausses présuppositions.
Et c’est aujourd’hui que j’ai voulu faire connaître ces mensonges flétrissant l’honneur italien, puisque aujourd’hui la bravoure de nos armes doit subir de dures épreuves et combattre plus que la résistence obstinée de nos ennemis, les dénigrements systématiques de maints flibustiers du journalisme, dont les appréciations ne sont point inspirées par l’amour de la vérité, mais se forment d’après une sotte tradition que tant de lumineux exemples d’héroïsme auraient dû effacer.
Bergeret [Ettore Marrone], Fine di gennajo, «La Stampa», Torino, Anno XLVI, Num. 32, 1 Febbraio 1912, p. 3.
Nello scrivere le magiche parole Scena Prima, Capitolo primo, chi non si è sentito per un istante il cervello di Shakspeare (sic) o di Balzac sotto la fronte?
Bergeret, In onore della farmacia, «La Stampa», Torino Anno XLVI, Num. 172, 22 Giugno 1912, p. 3.
Un romanziere del tempo passato – Balzac, per esempio, – per determinare la psicologia e financo la fisionomia di un personaggio, incominciava col dirci la sua professione. Per questo, come per ogni altro rispetto, l’autore della Commedia Umana era nel vero, poi che al principio del secolo passato – ahimè! il nostro secolo, lettrici e lettori – le professioni erano tuttora, per gran parte, ereditarie. Un profumiere, discendente da una stirpe di profumieri, dimorante in un quartiere tutto popolato da piccoli commercianti a somiglianza sua, metteva al mondo altri venditori di acqua di Colonia con la collaborazione della figliuola di un fabbricante di ombrelli.
Bruno Braga, Uomini e cani d’ogni razza, «La Stampa Sportiva», Torino, Anno X, N. 10, 10 Marzo 1912, pp. 6-8.
p. 7. E così via via ancora molti altri, e poeti e scienziati, quali il Voltaire, il Balzac, Locke, Descartes, Bougeant, che si occuparono in ogni misura dell’utile animale.
Raffaele Calzini, Le Gallerie d’Europa: il Museo del Prado, «Emporium. Rivista mensile illustrata d’arte – letteratura- scienze e varietà», Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Vol. XXXVI, N. 211, Luglio 1912, pp. 20-43.
p. 28. L’anima del Goya sembra che ad un punto si sia invelenita […]. La sua arte piuttosto che ironica è satirica: Balzac e Daumier, i due parigini caustici e mordenti, hanno con lui qualche cosa di comune.
Giosuè Carducci, Alessandro Manzoni. Con note di A. Albertazzi, Bologna, Nicola Zanichelli, 1912.
A proposito di alcuni giudizi su Alessandro Manzoni [1873], pp. 5-108.
p. 36. Pare incredibile come sian teneri del Trecento taluni che scrivono con riduzione italiana sbagliata il più bel francese della più brutta maniera di Balzac!
Colloqui manzoniani [1885], pp. 195-240.
p. 217. — I romanzi del Balzac hanno ingenerato il verismo: pure anche dei romanzi del Balzac si discorre e si 'scrive più che non si leggano.
p. 231. I Promessi Sposi hanno mai riscaldato o turbato gli animi degli stranieri, come i romanzi del Balzac riscaldarono i russi? I Promessi Sposi hanno avuto mai un lampo della popolarità che prosegui i Miserabili?
Demetrio Cassarini, La figura ed il carattere di Alfredo Oriani, «L’Italia Centrale. Quotidiano della democrazia di Reggio Emilia», Reggio Emilia, Anno L, N. 303, 20 Ottobre 1912, p. 2.
Nel modesto studiolo: Eschilo, Dante, Shaekespeare (sic), Spencer, Balzac, Vico, Saint-Beuve (sic) […]; anche al disopra di Shaekespeare, adorava Balzac, la cui arte sosteneva fosse unica a ricollegarsi a Dante. […].
Una volta a Roma ammonì D’Annunzio così: «Leggi Balzac che imparerai a scrivere». Rincontratisi il D’Annunzio gli disse: «Oriani ho letto il tuo Balzac; scrive male» e di lui di rimando «va là, ragazzo, non scriverai mai come lui».
Emilio Cecchi, Studi critici di Emilio Cecchi, Ancona, Giovanni Puccini e Figli – Editori, 1912.
“L’Amore dei tre re”, pp. 139-147.
p. 143.
Manfredo:
Perché, perché non mi hai prima concesso
Ch’io le parlassi: ora sarebbe mia …
Divino questo lagno di un marito – diremo balzacchianamente – minotaurizzato!
George Meredith, pp. 231-240.
p. 232. Passate dall’esame della pagina alla considerazione del metodo costruttivo dell’azione: la vostra perplessità diventa ancora più grande. Non una correlazione armoniosa, come in Shakespeare od in Balzac, per la quale i personaggi maturino, a così dire, tutti insieme, attraverso lo sviluppo dei fatti, la propria significazione definitiva e, presentatici quasi materia bruta, pezzi di natura o di rozza storia, ci disvelino poco a poco la loro fisionomia segreta. Personaggi costrutti con questo metodo, che è il metodo istesso della vita e della storia, si muovono accanto ad altri, la cui essenza è fermata a tutta prima in un nodo di aforismi e di definizioni etiche, e la cui fisionomia materiale ci resterà per sempre celata.
Pascarella, pp. 257-265.
pp. 262-263. L’arte narrativa, sia di racconti, sia di sonetti, è ritenuta di grado inferiore all’arte lirica e tragica. Si ammette che un lirico il quale ha prodotto, in tutto, una dozzina appena di poesie, possa rappresentare una crisi vasta e necessaria, un essenziale atteggiamento dello spirito. Un narratore sembra invece uomo adatto a divertire più che ad avvincere, a divagare più che impressionare profondamente. A Balzac, dopo pubblicato trenta volumi, avveniva ancora di sentirsi chiedere: “Quando dunque, signor Balzac, scriverete qualche cosa sul serio?”.
Il segreto di Flaubert, pp. 305-312.
pp. 306 e 309. Cfr. 1911.
“L’Ordination”, pp. 339-346.
p. 342. Se riapriremo, oggi, un romanzo di Balzac, siamo soggiogati dalla forza miracolosa dello scrittore, ma non possiamo sempre accettare le ragioni empiriche che vogliono dare le assolute motivazioni psicologiche dei vari personaggi, come poteva accettarle, per esempio, un lettore di cinquanta anni fa. I fatti, nel romanzo, ci interessano meno, forse anche perché sappiamo che molti autori, per certe tendenze particolari del nostro momento storico, sono portati a malamente sentirli e perciò ad esprimerli con una persuasione interrotta.
Emilio Cecchi, La poesia di Giovanni Pascoli. Saggio critico di Emilio Cecchi, Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1912.
p. 137. Occorre una virtù di sublime abbandono a conseguire questo dominio [del fatto storico], la virtù di saper rinunziare a sé stessi che possedevano Shakspeare (sic) e Balzac. Il Pascoli non la possiede.
Domenico Ciàmpoli, Dizionario di citazioni francesi tradotte. Massime – Sentenze – Pensieri – Proverbi – Epigrammi, Lanciano, R. Carabba, Editore, 1912.
Oltre cinquanta citazioni tratte dalla Physiologie du mariage sono presenti in questo denso dizionario di citazioni francesi e riguardano le seguenti voci: Abitudine (p. 3); Acqua pura (p. 5); Adulterio (p. 7); Affezione (p. 7); Ammirazione (p. 9); Appassionato (pp. 41-42); Arbitrio (p. 42); Armonia (pp. 43-44); Attrazione (p. 52); Azioni (p. 60); Camera da letto (p. 86); Casa (p. 94); Civetta (p. 104); Civetteria (p. 105); Conversazione (p. 125); Corrispondenza (pp. 127-128); Costumi (p. 132); Desiderio (p. 149); Diffidenza (p. 156); Dispotismo (p. 167); Doti (p. 192); Educazione (p. 200); Egoismo (p. 201); Emicrania (p. 207); Energia (p. 208); Fanciulli (p. 228); Geloso (p. 273); Generi (p. 274); Giovanetta (p. 281); Giudicare (p. 284); Inconseguenza (p. 328); Innamorata (p. 344); Insegnare (p. 346); Leggere (p. 370); Marito (p. 408); Matrimonio (p. 410); Medico (p. 414); Moglie (p. 434); Momenti (p. 436); Passione (pp. 511-512); Piaceri (p. 539; Politica (p. 552); Potenza (p. 560); Predestinato (p. 566); Pulce (p. 590); Ridicolo (p. 618); Riguardo (p. 623); Sentimenti (p. 663); Silenzio (p. 668); Spie (p. 689); Suocera (p. 712); Talento (p. 716); Toeletta (p. 732); Tutto o nulla (p. 732); Vecchia (p. 754); Vendicarsi (p. 757); Virtù (pp. 776 e 777); Vita (pp. 782 e 783); Volontà (p. 789).
Altri riferimenti ad opere balzachiane sono desunti dalla raccolta: Maximes et Pensées e da Splendeurs et misères des courtisanes.
[A. Cim], Curiosi errori di letterati, «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XXII, Vol. XXXII, N. 20, 15 ottobre 1912, pp. 923-924.[3]
p. 923. Un anacronismo imperdonabile commette Balzac nel Cousin Pons, parlando d’un ventaglio «divin chef-d’oeuvre que Louis XV a bien certainement commandé pour M.me de Pompadour. Watteau s’est exterminé à composer cela!». E Watteau morì nel 1721, lo stesso anno in cui la marchesa veniva al mondo. Nella Muse du Département, lo stesso Balzac descrive una servetta che, dopo aver bendato gli occhi a una persona, per impedirle di vedere, le fa questa strana raccomandazione: «State bene attenta! non perdete di vista nessuno dei miei segni!». […]
Nella Cousine Bette di Balzac, un commissario di polizia «risponde silenziosamente: Essa non è pazza».
Matteo Cuomo, I libri fortunati, in Nel mondo dei libri. Bizzarrie, Milano, Dott. Riccardo Quintieri Editore, 1912, pp. 125-154.
p. 127. Una sera il Balzac, mentre si ritira a casa, proprio nel quartiere Marteuf, è aggredito da un ladro, il quale l’apostrofa col rituale dilemma: — o la borsa o la vita. —
Il Balzac scoppia in una sonora risata e stringendogli amichevolmente la mano, gli dice:
“La borsa? fratello mio, la borsa è vuota! Non sai che io sono un letterato?”
Il ladro sorride, gli chiede venia e si allontana.
Eppure il Balzac mentiva. Al suo tempo i letterati di grido incominciavano a guadagnare qualche marengo.
I romanzi, pp. 244-264.
p. 250. Ma venuto il secolo XIX, secolo di rivendicazione sociale, il romanzo ottiene i suoi diritti. Ammesso ufficialmente nello Stato Civile dell’arte dallo Scott, preso a battesimo dal Manzoni, confirmato dal Balzac, incomincia a vivere di vita propria ed acquista una vitalità maravigliosa. Poeti, storici, uomini politici, eruditi, filosofi, critici non sanno resistere al suo fascino e diventano romanzieri.
Lucio D’Ambra, Cronaca di letteratura francese. Paul Bourget, l’“Envers du décor”, novelle (editore Plon) […], «Rassegna Contemporanea», Roma, Anno V, Fasc. III, Marzo 1912, pp. 510-515.
pp. 510-511. In uno studio piuttosto recente su Balzac nouvelliste, pubblicato in occasione dell'edizione inglese d’una raccolta di dieci novelle di Balzac, Paul Bourget osservava che l'arte del racconto breve e quella del racconto lungo s'incontrano difficilmente nello stesso autore. E citando, alcuni esempii tolti solamente dalla storia letteraria francese, il Bourget notava che uno dei migliori autori di novelle, il Mérimée, era stato incapace di comporre un romanzo sviluppato sino alle proporzioni d'un volume; che Giorgio Sand, invece, non seppe mai condensare un dramma in una cinquantina di pagine, così come Emilio Zola, come Dumas padre; che anche negli autori che ebbero la fortuna di questo doppio talento di romanziere e di novelliere, vi fu sempre disparità di risultati nei due generi: esempio Flaubert che, romanziere grandissimo, non fu — e lo prova Un Coeur Simple — che un novelliere pregevole; esempio in senso opposto il Maupassant nell’opera del quale lo splendore delle novelle non è mai raggiunto da quello dei romanzi. E il Bourget concludeva che Balzac invece aveva il segreto di maneggiare con pari maestria le due forme di composizione letteraria e questo non nolo per virtù innata del suo genio ma perché avendo studiato profondamente la tecnica del suo mestiere, sapeva che una novella non è un romanzo breve e che un romanzo non è una novella allungata. Certamente Balzac riuscì a stabilire anche teoricamente la differenza tra le due forme. «Chi ha molto studiato Balzac, scrive il Bourget, riconosce che alla sua straordinaria facilità creativa s’accompagnava una facoltà critica non meno eccezionale». Un critico siffatto non può non aver ragionato attorno ai suoi procedimenti diversi nel suo diverso lavoro di romanziere e di novelliere. Per Balzac la novella non è solamente il «momento tagliato su la trama indefinita del tempo» o l’aneddoto comico o tragico, reale o fantastico, più o meno abilmente raccontato: la novella è pretesto allo studio dei costumi e del tempo, all’evocazione di quadri storici, a suggerire idee, problemi, discussioni morali o sociali. La novella è il genere letterario meno adatto a dimostrare, ma per la sua stessa brevità di sviluppo è il genere più indicato per suggerire. Quante questioni, quanti problemi, quante inquietudini, quanti punti interrogativi son chiusi, così, negli aneddoti delle novelle balzacchiane! «Balzac, dice il Bourget, ci lancia la cura di rintracciarli. La novella, compresa a questo modo, ci fa pensare a certi effetti che hanno, si direbbe, del tour de force e in cui si compiacquero anche celebri artisti del Rinascimento, il Mantegna tra gli altri. Coloro che a Milano hanno visitato la Galleria di Brera ricorderanno quel Cristo morto la cui minuziosa anatomia è chiusa in un mezzo metro quadrato di tela. Com’è piccola quella tela e come quel quadro è grande! E se l’arte, come disse lo stesso Balzac, altro non è che la natura concentrata, il suo capolavoro non è forse quello di creare di nuovo, come fa appunto la natura nei suoi fiori più piccoli e nei suoi più piccoli insetti, un mondo intero in un così stretto scorcio di spazio e di materia?».
Possiamo ripetere, una ad una, per Bourget novelliere le parole consacrate dal Bourget alle novelle balzacchiane. È su gli schemi balzacchiani che il Bourget ha studiato le architetture dei suoi romanzi e delle sue novelle. È nei volumi della Comédie humaine ch’erano compagni delle sue lontane e ardenti notti di studente e di poeta al Quartier Latino — quando il giovane scrittore si levava alle tre di notte, come Balzac, si faceva il suo caffè, come Balzac, per mettersi a lavorare avvolto in una tonaca da frate, come Balzac! — è nei volumi della Comédie humaine che il Bourget ha minutamente studiato quei procedimenti tecnici che poi dovevano servigli attraverso quindici romanzi e quindici volumi di novelle, da L’Irréparable a L’Envers du décor. È su Balzac e in Balzac che s’è fatto, non solo tecnicamente, il più tecnicamente balzacchiano dei grandi romanzieri francesi. E così anche nelle novelle del Bourget la novella non è fine a sè stessa, non è l’aneddoto ben raccontato, non è il «momento» della vita in movimento, il «momento» che l'autore cerca ed aspetta di niente altro preoccupato che di coglierlo. Anche la novella del Bourget, se non dimostra suggerisce e molte questioni, molte inquietudini, molti problemi, non chiusi nelle sue pagine pensose e ragionatrici. […].
L. Donati, Alfredo Oriani descritto in una lettera d’amore, «Ars et Labor. Musica e Musicisti. Rivista mensile illustrata», Milano, Anno 67.°, N. II, Novembre 1912, pp. 938-940.
p. 940. Per gettare se stessi in una pagina e per avere qualcosa di nuovo da dire bisogna aver provato il morso che strazia, la distrazione invincibile che disprezza l’esistenza effimera di chi vuol essere felice. Certo fu così per Omero e Dante, Shakespeare e Balzac, e non si può esser loro, o non si possono imitare, se non a patto di essere originali e sinceri, di essere sè stessi.
Giulio Doria, Balzac. Novella, «L’Iride. Rivista mensile critico – artistico – letteraria», Gravina, Anno III, Num. 11, 25 Novembre 1921, pp. 7-9.
Il buon Balzac, tanto sensuale e tanto cerebrale, pareva aver raggiunto il suo sogno, sprofondato in una comoda poltrona, i piedi poggiati sugli alari del camino, mentre andava stuzzicando il foco con l’attizzatoio, seguendo con l’occhio vivace il contorcersi, lo spasimare, il guizzare, il trepidare, l’innalzarsi delle fiamme, rosse nel focolaio, azzurrognole, livide come labbra di donna in un amplesso spasmodico, nei contorni ... e gli parevan, forse, tutte le traversie della sua vita tanto triste ed inceppata dalle crudeli pastoie della vita materiale, dalla povertà.
Indossava una bella veste da camera a fondo rosso cupo arabescato di nero, delle pantofole verde e oro ... pareva proprio il suo elegante eroe: Rastignac, non nel viso e nella persona, s’intende, ma soltanto nell'abbigliamento e nella indolente positura.
Lasciò l’attizzatoio e versò, dal gorgogliante samovar, in una capace tazza, il fùmido tè, che diffuse intorno un lieve aroma esilarante. Parve annusarlo lo dalle nari del grosso naso, sensualmente trepidanti, e l'occhio gli scintillò di più, quell’occhio bello in quel brutto viso: ma una ruga gli si scavò, di repente, profonda, nella fronte alta; ebbe un moto di rabbia che gli fece schizzar delle gocciole di té bollente sulla mano paffuta e pelosa, e allora sorrise: sorbì con la pacatezza d'un pingue abate la bibita d'oro, ma la ruga ricomparve.
Versò ancora del té, bevette ancora.
No, la bibita celebrale, non dava, quel giorno, al suo cervello apoplettico, la consueta lucidità ... Balzac, era, allora, nella pienezza di sua vita. 1837 Novembre. Trentotto anni. Aveva terminato “Cesare Birotteau” e lavorava a un nuovo romanzo. Il suo lavoro, tutto interiore, s’era arrestato per un grave intoppo: la scena d’un sequestro. Oh! la scena d’un sequestro, nei suoi particolari esteriori, la conosceva e la ricordava molto bene, ma non ricordava quali avrebbero dovuto essere le sensazioni del protagonista nel vedersi capitare fra capo e collo, mentre pensava alla amata amante, l’usciere.
La saisie. Il sequestro.
Eppure, nom de … Claparon, non aveva mai avuto bisogno di osservare e classificare tutti i successivi stati d’animo dei suoi disparati personaggi nelle più stravaganti contingenze della vita!
Una volta impostato un carattere, riscontrato nella vita reale, ne aveva potuto sempre ricostruir con verità e con logica, nel suo cervello, tutto il modo di sentire ed agire nel corso della sua vita fittizia.
Sorrise ancora.
Pensava che era buffo ed irritante il doversi arrestare innanzi ad una simile difficoltà, quando quel suo personaggio aveva il suo stesso temperamento e quando lui, Honoré de Balzac, aveva subiti tanti sequestri! Un momento. Quanti?
Erano già, dunque, tanto lontani i tempi dei sequestri? Temeva, ora, il ritorno di quei tempi. L’editore gli aveva pagato duemila lire il suo Cesare Birotteau, ma egli aveva speso, per il caro Cesare, tremila lire di correzione! Che dovesse arrivar proprio ad invidiare il mediocre ma economo Pietro Grassau? (sic).
– Ah, questo, no! – esclamò, scotendo la testa monacale. Che gl’importava, alla fine, dei sentimenti di quel suo figliuol prediletto? Poteva fare a meno di approfondire quella scena e arrivare all’altra, ch’era già tutta scolpita nella sua mente l’accoglienza fredda, dopo lunga assenza, dell’amata amante.
V’era una lacuna nel suo cervello. No, non una lacuna, chè, anzi, quel povero cervello era pieno, pieno zeppo, pieno da scoppiare; i moti di quell’animo, in quella contingenza, [anima simile alla sua, che aveva quindi dovuto avere gli stessi moti in simile occasione] se n’eran dovuti scappare da qualche ... fenditura, specie di valvola di sicurezza di quel povero cervello in continua ebullizione.
Sorrise ancora.
In quanto a lui, non ci teneva affatto a riprovare ancora una volta quelle sensazioni!
Guardò le fiamme che andavano abbassandosi, fece cadere, col piede, dei pezzi di legno ritti lungo le pareti del gran camino, li acconciò, servendosi dell’attizzatoio, ne sfocò la brace e le fiamme s’alzarono ancora alte. Ah! era pur bello star così, tranquillo, potersi abbandonare alla fantasia della propria mente, senza curarsi di renderle pubbliche: creare senza esporre.
Sognava d’avere un salotto degno di Silvayn (sic) Pons: una battaglia di Salvator Rosa e una di Meussionnier (sic), una festa rurale di Greuze e un ingenuo Botticelli, del Frakentale (sic) e del Sassonia, del Capodimonte e dei Sèvres. un cofanetto di Benvenuto Cellini sur un mobiluccio di Boule, un Hobema (sic) e un Metzu (sic), un fosco Rembrandt e un lezioso Watteau, un pettinato Corot e un pauroso Goya, un Durer e un possente Leonardo, l’amica del Giorgione e l’uomo dal guanto di Tiziano, un Mantegna e un Lippi, e là, là, in fondo, bene in luce, una cornice Luigi XIII, tutto solo, un soave volto di madonna, una madonna del suo Raffaello, del pittore che più d’ogni altro ha saputo trasfondere nelle sue donne, il suo Raffaello che ...
Comparve pallido, stravolto, più tremolante del solito il vecchio Orazio:
– Huissiers ... saisie ... huissiers - disse, con la vocetta piagnucolosa, profondamente addolorato di dover dare quel colpo al padrone adorato, proprio durante quel riposo fecondo, a lui sì caro. Balzac s’alzò di colpo, aprì, strappò quasi, con le mani fatte dure dal ritrarsi precipitoso del sangue, la veste e la camicia, un rossore violaceo gli salì sino alla fronte, come le fiamme di poc’anzi, scomparve, in parte, permanendo a chiazze agli zigomi, le labbra gli tremarono, si afflosciarono in un rilassamento pietoso ...
– Ancora ... ancora ,.. – disse.
Ma gli occhi, un momento spenti, gli riscintillarono, si sedette allo scrittoio, afferrò la penna con gesto violento, con voce calma disse: – Lascia entrare, mio vecchio Orazio.
– Avevo dimenticato quella brutta reincarnazione di Gobseck – pensò.
Prese a scrivere, velocemente, senza sollevare il capo. La mano, fatta dura, non poteva seguite il vertiginoso lavorio di quel cervello affocato dal sangue.
– Mi hanno spezzati i miei sogni di grandezza – mormorò – ma mi han rivelata la scena magistrale.
– Non tutto si può avere … soggiunse sorridendo tristemente.
E continuò a scrivere, a zaffate, come a colpi di vento, come uno statuario plasma la creta a colpi di pollice, spingendo con uno scatto secco del dito medio della mano destra, a una a una, al di là dello scrittoio, le cartelle piene di caratteri violenti, irregolari, grossi, bistorti, congestionati ...
Quelli entrarono, chiedendo permesso. Balzac continuò a scrivere ...
Carlo Dossi, Note azzurre (scelte e ordinate dalla vedova), Milano, Fratelli Treves, Editori, 1912.
Varie.
p. 264, (1220) Nell’universale libello Erasmiano [Stultitiae laus] si trovano i germi di tutte le satire umane che vennero scritte di poi. E tuttavia dice più Erasmo nelle sue poche pagine che non Balzac (p. es.) nella sua biblioteca di scene della Comedia Umana.
p. 325. (3211) Nessuno, neppure Balzac, conobbe le donne meglio di Richter.
Onorato Fava, Il Prodigio [di Pasquale De Luca], «Ars et Labor. Musica e Musicisti», Milano, Anno 67, Vol. II, Num. 10, 15 Ottobre 1912, p. 816.
La psicologia bisogna saperla trattare coi fatti, non con le parole, gli stati d’animo, i passaggi, le intime tempeste bisogna presentarli nell’azione dei personaggi, non nelle elucubrazioni dell’Autore. Balzac e Dickens informino, due maestri, che presentano i loro tipi e li fanno parlare e muovere lasciando ai lettori il compito di comprenderli, di seguirli, di compiangerli o di ammirarli.
Alberto Finzi, Nel regno del tabacco, «La Lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera», Milano, Anno XII, N. 12, Dicembre 1912, pp. 1111-1120.
p. 1120. Bacone scrisse dal canto suo: «E’ provato per esperienza che l’uso del tabacco scaccia la stanchezza, ristora e sostiene le forze, snoda le membra rattratte e ridesta a sollievo dell’animo l’assopito vigore».
Balzac contraddisse con un aforisma agrodolce: si le tabac endort le chagrin, engourdit infailliblement l’énergie.[4]
Antonio Fogazzaro, Discorsi. Nuova edizione, Milano, Casa editrice Baldini & Castoldi, 1912.
Un’opinione di Alessandro Manzoni.
p. 59. E non parlate mai più della conservazione della specie come supremo suo fine. Sulla opinione contraria io trovo il suggello imperiale della Morte. Sempre il grande amore, cette divine passion, scrive Balzac in una lettera dont chacun parle et que si peu ont connue, diventa più grande quando la specie umana non vi ha più interesse, quando uno degli amanti è portato via dalla morte”. (Cfr. 1887).
Giovanni Gambarin, I giornali letterari veneti nella prima metà dell’Ottocento, «Nuovo Archivio Veneto. Periodico storico trimestrale», Venezia, Nuova Serie, Anno XII, Tomo XXIV – Parte II, N. 88, Ottobre-Dicembre 1912, pp. 259-335.
p. 299. […] nel ’37 la censura concedeva all’editore del Gondoliere di associarsi al Figaro, nonostante che questo fosse un “giornale di opposizione”, perché potesse servirsene. “Quattro pagine poi di questo stesso giornale, soggiungeva il censore, servono a riportare alcuni brani dei romanzi più in voga nella capitale di Francia durante l’anno, […] quali sono per lo più quelli di Balzac, Janin, Dumas, Gautier ed altri”. […].
p. 304. Ancora a proposito del Gondoliere, l’A. osserva che, in esso, si ritrovano «alcuni articoli sulle “celebrità contemporanee”, fra cui Giorgio Sand, stimata dal critico una grande scrittrice, dallo stile meraviglioso, e il Balzac, “uno dei più notevoli scrittori della moderna letteratura francese”[5] […]. […].
pp. 308-309. Sul Vaglio.
Fanciulle deluse che si uccidono, o trovano la pace nella solitudine del chiostro, giovani in preda alla passione amorosa, i quali, non sapendo come spegnerla, si abbandonano al più tetro pessimismo; tipi di Carlotte goethiane, eroi ed eroine alla Victor Hugo, alla Balzac, alla Sand, monache perdute, scene tetre della vita medievale; questi sono i soggetti dei numerosi racconti e delle non meno numerose ballate, romanze, novelle in versi che, volendo imitare il tipo di quelle del Carrer, del Berchet, del Grossi, adornano o deturpano le pagine del nostro giornale. […].
[…] conviene anche ricordare che il Vaglio veniva pubblicando numerose traduzioni in prosa e in versi, direttamente o di seconda mano. Gli scrittori più tradotti erano certo i francesi: i racconti di Balzac, di Alfredo de Vigny, dello Scribe, del Dumas, le prose descrittive o critiche dello Chateaubriand, di Giulio Janin, di Giorgio Sand, e numerose prose di Lamartine e di Victor Hugo.
C. Ghiotti, G. Dogliani, Honoré de Balzac, in H. de Balzac, Une bourgeoise sans ambition … cit., p. 469.
Honoré de Balzac (1799-1850), romancier brillant et fécond, auteur de la Comédie humaine, série considérable de romans remarquables, malgré certaines imperfections de style et la minutie de quelques descriptions, par la verve pittoresque, la puissance d’observation, le sentiment saisissant de la réalité, la fécondité de l’imagination, la peinture fine et profonde des passions humaines ; les principaux de ses romans sont : Eugénie Grandet, Le Père Goriot, La Recherche de l’absolu, César Birotteau, La Cousine Bette, Le Cousin Pons, etc.
Balbino Giuliano, Ernesto Bovet, “Lyrisme, épopée, drame. Une loi de l’histoire expliquée par l’évolution générale”. – Parigi, Colin, 1911, «Rassegna bibliografica della letteratura italiana», Pisa, Tipografia Editrice del Cav. Francesco Mariotti, Anno XX, Nuova Serie, Vol. II, Num. 3, 31 Marzo 1912, pp. 69-77.
pp. 75-76. Per fortuna, è stato risparmiato il Balzac, perché le vaste proporzioni della Comédie humaine si prestano meglio a fare di lui il precursore del periodo epico che sopraggiunge.
Fr. Enotrio Ladenarda [Andrea Lo Forte Randi], Rastignac, in Feticisti Carduccini con lettere di Mario Rapisardi e Pierre Gauthiez, Palermo, G. Pedone Lauriel – Ed., 1912, pp. 23-25.
Certissima cosa è che Rastignac, «le beau Rastignac, jeune ambitieux, reconnut dans les souvenirs dont sa tante l’avait si souvent bercé, les éléments de plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi importantes que celles qu’il entreprenait à l’école de droit»[6].
Certissima cosa altresì è che Rastignac, sin da quando era ancor giovanotto, trovò in Vautrin il suo degno maestro, il quale gli insegnò molte utili cose in altrettanti aforismi:
«Non vi sono principî, ma fatti; non vi sono leggi, ma occasioni».
«L’uomo superiore (leggasi: superiore in astuzia, in ipocrisia, in bugia, in simulazione, in dissimulazione, in superbia, in sfacciataggine, in oltracotanza, ecc. ecc.) attira a sé i fatti e le occasioni per condurli e dirigerli ai suoi fini».
«Il successo è la ragione suprema di tutte le azioni, quali esse siano».
«Nella società bisogna sfondare come una palla di cannone o insinuarsi come una peste».
«L’onestà non serve a nulla».
«La corruzione è una forza: la forza dei mediocri».
Eccetera.
*
Sì, Rastignac, «pauvre, de famille noble, que l’ambition naissante poussait à l’étude et à l’intrigue», era giovanissimo allorchè cominciò a bere dalla bocca stessa di Vautrin gli insegnamenti del piacere e del male. Vautrin così parlò un giorno al giovanotto Rastignac:
«Una rapida fortuna è il problema che si propongono di risolvere in questo momento cinquantamila giovanotti come te. Tu sei un’unità in quel numero; pensa, dunque, quanti sforzi devi fare per riuscire. È necessario che vi mangiate gli uni gli altri, come i ragni in un barattolo. Che vuoi fare in questa condizione? L’uomo onesto? I tuoi bisogni e i tuoi nervi non te lo permettono. Ebbene, in questa condizione, quando si vuole arrivare, l’onestà non serve a nulla».
Che lezione! E Rastignac ne approfittò e fece rapida fortuna. Ma il più curioso a sapersi è che – da vero ingrato (vuol dire, da mano che traduce in pratica gli insegnamenti di Vautrin) allorchè, dopo di aver messo da parte ogni scrupolo, ebbe conquistata la ricchezza e la potenza, egli ebbe un giorno la faccia tosta di scrivere e stampare il seguente commento alla lezione fattagli dal maestro:
«Quante anime deboli, quanti spiriti incerti, quante intelligenze esquilibrate non si sono perdute sotto la suggestione – occulta o palese – di un Vautrin, persona o maschera, o di quel Vautrin diffuso, indeterminato, indefinito di tutta quella peste vittoriosa che si chiama l’esperienza della vita!»
Ma le intelligenze equilibrate e bene agguerrite contro gli scrupoli della coscienza, pur avvoltolandosi nel fango, riescono sempre (gloria al maestro Vautrin!) a tener salda sul viso la maschera di valentuomini.
E Rastignac [Vincenzo Morello] – quasi a scusare sé stesso – da degno allievo di un tanto maestro, così scrive del Balzac creatore del tipo Vautrin:
«Chi più del Balzac fu affascinato dal sogno della sùbita fortuna? Il gran sogno di Balzac fu il milione».
Ma Rastignac tace che il Balzac, non ostante questo suo château en Espagne, non prostituì mai la sua coscienza di grande scrittore. Balzac sciupò – sì – in speculazioni sbagliate gli onesti guadagni del suo genio, ma non asservì mai il suo genio a mezzi turpi per fare il milione. Sì, piuttosto che disonorarsi vendendo la sua penna, egli si rimetteva al lavoro come uno schiavo: in un anno, nel 1839, si sobbarcò perfino a scrivere sedici volumi e parecchie commedie, anziché – ripeto – vendere la sua penna!
Gli altri, che non sono eroi come Balzac, ma sono, invece, dei degni allievi del maestro Vautrin, cercano e raggiungono il milione ben diversamente, cioè, esercitando il bel mestiere di briganti della Stampa; in ogni caso, lo raggiungono vendendo – nuovi capitani di ventura – i loro tristi e venali servigî al maggiore offerente.
Mattia Limoncelli, “La fiaccola sotto il moggio” di G. D’Annunzio avanti il Tribunale di Roma, «La Scintilla ... giudiziaria-settimanale-illustrata», Napoli, Anno VII, N. 308, 16 Maggio 1912, s.i.p.
Ma vi è un’arte pensosa, squisitamente moderna, che può davvero dirsi in contrapposto di quella del racconto, ed è arte interiore, nostalgica, tormentata da ambizioni sconosciute, affrettata dalla intrepidezza, governata con la vigile coscienza del dolore. Arte tutta di temperanze e di atteggiamenti.
Che cosa è più il fatto per tale arte?
Domandatelo al Balzac che lo ha trascurato e talora bandito dai suoi romanzi, chiamandolo inutile e dandogli appena l’importanza di un pretesto.
Giuseppe Lipparini, Dal Carducci al Balzac della Terza Italia, «il Resto del Carlino – La Patria. Giornale di Bologna», Bologna, Anno XXVIII, N. 362, 30 dicembre 1912, p. 3.
[Su: G. Zuccarini, Schegge e sprazzi, cfr. più oltre].
In realtà, i nostri pochi, scarsi, svogliati romanzieri hanno altro da fare. Nessuno di loro, dal Manzoni e dal Nievo in poi, ha saputo essere qualche cosa di più che un narratore sontuoso o mistico o sentimentale. L’ombra di un Balzac o di uno Zola non li ha turbati. Eppure è lecito credere che in uno Zola o in un Balzac solamente potrebbe trovarsi la salvezza della letteratura italiana presente. La quale […] sta cadendo in una mediocrità ch’io non esito a dir paurosa. […]
Il che non toglie che noi non possiamo desiderare l’avvento di un altro Zarathustra: ma di quello vero, non di quello magnificamente rifoggiato per il suo ideale artistico da Gabriele D’Annunzio. Ora, questo Zarathustra non potrà, secondo l’opinione dello Zuccarini, essere altro che un nuovo Balzac. L’Italia ne ha bisogno, l’Italia lo aspetta. Così affermata, questa asserzione può sembrare ingenua. Ma il nostro autore la dimostra, facendo la storia del dramma intimo e della tragedia spirituale della nostra generazione. […]
«Il più grande filosofo (meglio, dico io, psicologo) è colui che ha l’ingegno più limpido, è colui che meglio ha studiato e compreso l’anima umana osservandola più da vicino, disvelandola in tutti i più oscuri viottoli». Non tanto importa lo studio speculativo e metodico dei fenomeni dello spirito o la costruzione di un nuovo sistema, quanto «l’analisi dei fatti interni che determinano le azioni esterne, o, viceversa, l’osservazione dei fatti esterni che svelano i moti interni e che caratterizzano i tipi». In questo senso, si potrà affermare «ciò che a molti sembrerà almeno un paradosso e un’eresia: cioè che il più grande filosofo moderno è Onorato di Balzac».
Il Balzac è senza dubbio il più grande scrittore europeo della seconda (sic!) metà del secolo XIX; ma l’opera di lui non ha mai avuto in Italia troppi caldi seguaci. Già il Mazzini e il Tommaseo avevano messo in guardia gli italiani contro di lui e contro il suo naturalismo che pareva pericoloso. Quando il grande romanziere venne in Italia, trovò pochi ammiratori; anzi, poiché si era mostrato franco ma non cieco ammiratore del Manzoni, fu vituperato e quasi odiato. Leggete ciò che intorno a questo argomento hanno scritto critici non sospetti di filisteismo, come il Mazzoni nell’Ottocento e il Barbiera nel Salotto della contessa Maffei.
«Non potremo noi sperare in questo romanziere che sveli la provincia alla città, la città alla provincia, che fotografi i diversi ambienti, che frughi in fondo all’anima dei diversi uomini; che si immedesimi del carattere delle diverse regioni e delle diverse razze cogliendone dovunque le più lievi sfumature psicologiche e le più varianti armonie; che ci mostri lo sfacelo prodotto nelle classi elevate dalla vanità, dalla corruzione, dalla lussuria, e che ci additi anche la vergine forza delle popolazioni campagnole che conservano ancora intatti gli istinti della nostra grande razza; che ci indichi anche i modesti e liberi esercizi dell’agricoltura, del commercio, dell’industria e tutte le vie aperte che conducono le famiglie al benessere; che ci esponga il dissidio tra padroni e servi, il contrasto tra uomo e uomo, tra uomo e donna, e tutte le tristezze e tutte le gioie e tutte le miserie e tutti i nobili e turpi amori; e il cozzo di tutte le passioni, di tutte le ambizioni, di tutti gli appetiti; che ci svolga anche le intricate matasse della vita artistica e politica, della disperata lotta, e delle viltà e degli affarismi e degli intrighi che spesso sorreggono il potere; che ci dia in fondo un’idea esatta e variata della realtà del tempo presente?»
Questo fece il Balzac della Comédie Humaine per l’età che fu sua, come l’aveva fatto il Boccaccio per l’Italia del Trecento. Ma questo potrebbe anche essere fatto, anziché da un grande romanziere, da un grande drammaturgo. Se il Carducci ha dato agli italiani il senso del passato, il suo successore, cioè quegli che darà loro il senso della realtà presente, dovrà essere un grande romanziere o un grande drammaturgo. Sintetizziamo dunque questi concetti nel nome di Onorato di Balzac.
Guido Marangoni, La villa di Balzac, «L’Italiano. Gazzetta del Popolo», Torino, Anno 65°, N. 155, 5 giugno 1912, p. 4.
Una seria ed autorevole rivista di architettura ha voluto in questi giorni pagare il suo tributo alla moda piuttosto burlesca ed abusata del «referendum»; ai collaboratori ed abbonati invia la solita circolare con la non meno solita domanda, naturalmente assai vaga ed imbarazzante...
«Quale fra le ville fabbricate per il soggiorno estivo voi preferite e per quali ragioni?».
Per rispondere con una certa coscienza occorrerebbe un lungo giro attraverso i colli, i laghi e le spiagge di mare ... Chi vorrà accingersi al magnifico pellegrinaggio per mettersi in grado di assolvere il proprio dovere verso il «referendum»?
Se fosse lecito scherzare con l’autorevole rivista e la sua grave iniziativa, io risponderei senza molte esitazioni e senza lunghe peregrinazioni, dando la palma alla ... villa di Balzac.
Se non altro aveva il pregio dell’originalità, quello che manca alle attuali palazzine e «chalets» eretti second, i canoni immutabili del «rinascimento», del «lombardo», dell’«impero» e magari dell’uggiosissimo «liberty». La villa costruita dall’autore di «Commedia Umana», non per il proprio riposo, ma per lavorare in pace, più intensamente, lungi dalle distrazioni parigine, rimane nella storia edilizia come un capolavoro di ... incomodità. Il grande romanziere scelse per elevarvi la costruzione il pendio più ripido dell’antica «Isola di Francia», alle Jardies. Nessun albero poteva allignare lungo il piano inclinato quasi a picco ed i giardinieri lavorarono per parecchi mesi — sotto la direzione del proprietario — a sistemare con sottilissima arte, a furia di pietre e di legname, una successione di piccoli pianori che dal basso assunsero l’aspetto d’una immensa gradinata. Nei periodi di buona stagione quel giardino sospeso nello spazio rinnovava l’incanto del giardino di Semiramide ... Ma alle prime pioggie d’autunno tutto si scombussolava come per un improvviso fenomeno tellurico!
Federico Lemaître dovette un giorno recarsi da Balzac per interpellarlo sui particolari di una «messa in scena». E recò a Parigi la comica descrizione della sua faticosissima ascesa alla villa famosa. Dovette munirsi di due grosse pietre per avvicendarle sotto i piedi prima di muovere ciascun passo. E, giunto alla sommità, avanti di affrontare l’argomento della messa in scena, fu duopo chiedere un cordiale e riposarsi un’oretta! Balzac rideva sonoramente delle fatiche degli slittamenti e dei non rari capitomboli degli ospiti. Per suo conto non si accorgeva di tanta perigliosità dell’ascensione ... Egli possedeva a un grado supremo la rarissima qualità di astrarre dalle cose e dagli avvenimenti circostanti ... Come ben disse Leone Gozlan, egli avrebbe sconcertato un colpo di fulmine!
Una invenzione di Balzac.
E appunto al Gozlan, ospite anche lui per brevi giorni della non imperiale dimora campagnuola di Balzac, l’originalissimo scrittore, spiegando i «perfezionamenti» da lui introdotti nell’arte di edificare e decorare, chiedeva se non si fosse accorto di una innovazione ingegnosissima della quale Balzac voleva chiedere il brevetto d’inventore.
Il Gozlan si guardò attorno trasecolato, ansioso di scoprire la meravigliosa riforma, rimproverandosi di non averla notata subito ...
Invano! Dovette rassegnarsi a rispondere all’interrogazione con ... una interrogazione:
— No, caro Balzac, non mi riesce di scoprire la vostra geniale, innovazione. Volete essere così cortese di spiegarmela?
— Ma guardatevi bene intorno. Che vedete voi?
— Quello che mi aveva colpito fin dall’arrivo: dei muri non profanati dall’impaccio volgare di un qualsiasi mobile che avrebbe nuociuto alla prospettiva. E, per servirmi di una frase sintetica e riassuntiva, dirò che nelle sale di questa vostra villa io vedo ... un bel nulla!
— Guardate meglio!
— Ecco fatto ... con lo stesso risultato.
— E’ per preconcetto ... per cattiva volontà di rendere omaggio alla mia sagacia di scopritore!
— Niente affatto, ve lo giuro!
— E allora, ecco ciò che costituisce una vera glorificazione della mia invenzione: la impossibilità in cui vi trovate di constatarla. Senza di ciò essa sarebbe riuscita imperfetta.
— Ma di che adunque si tratta?
— Non vi sembra odioso e stupido — rispose Balzac che da secoli si facciano correre dei fili di ferro lungo i muri e che a capo di questi fili si faccia pendere un indiscreto e odioso campanello? Esaminate, studiate il campanello ch’io ho scoperto per la gente intellettuale, per gli uomini che lavorano e non vogliono essere seccati ... Cercate. D’ora innanzi non si vedrà più un uomo a suonare così, come non lo si vede a pensare. Eugenio Scribe volle già entusiasticamente adottare il mio sistema. Ne è rimasto incantato. Ogni porta della mia villa ne possiede uno dei miracolosi campanelli. Venite a vedere se vi racconto delle frottole!
L’ospite constatò diffatti una grande abbondanza di campanelli nulla villa. L’invenzione consisteva in ciò: Balzac aveva soppresso i domestici affinchè non potessero rispondere ai richiami ... del mondo esteriore!
Contro i creditori.
L’invenzione si proponeva, naturalmente, lo scopo principale dii allontanare i creditori, gli eterni nemici del fecondo romanziere. E funzionava con maggior precisione in coincidenza coll’arrivo dei treni da Parigi. Soltanto un quarto d’ora dopo che il convoglio aveva levato i suoi muggiti di Bucintauro nel riprendere la corsa, eliminato ogni pericolo di minaccia alla villa, tutto rientrava allo stato normale. Ma al fischio del nuovo treno la vigilanza ricominciava e la manovra di difesa si rinnovava vigile ...
— Hanno suonato ... Ascoltiamo ... Non può essere che un creditore. Proprio ...
Il disgraziato visitatore, dopo aver minacciato di lasciare le braccia attaccate al grosso cordone, si placava all’ombra più vicina e si ostinava in una immobilità da statua. E dietro le persiane verdi Balzac ed i suoi ospiti ascoltavano con fremiti di riso le imprecazioni dell’infelice creditore che terminavano sempre con questa magnifica esclamazione:
— Ma son dunque morti tutti in questa casa?
Dopo la quale i creditori ripigliavano barcollando la pericolosa discesa, quando non arrivavano in fondo a ruzzoloni!
Il mobiglio ... ideale.
Quanto il Balzac progettava per l’ornamentazione della sua villa era straordinario, tale da far impallidire i fasti decorativi d Versailles ... Peccato che i progetti Balzac accontentasse di scriverli sui muri col carbone, proprio nel punto dove si riservava di collocare il mobile scolpito o lo stucco dorato.
Sulle nude pareti del vestibolo si leggeva a grandi caratteri: «Qui un rivestimento di marmo pario»; nella prima sala entrando: «Qui uno stilobate in legno di cedro»; a sommo del salotto la mano ond’era uscito il «Père Goriot» aveva tracciato questo augurio: «Qui un soffitto dipinto da Eugenio Delacroix»; più oltre: «Qui una tappezzeria d’Aubusson»; nel salone, all’ingresso: «Qui delle porte uso Trianon».
Erano permessi i commenti giocondi intorno a questa economica forma di arredamento e di decorazione.
Teofilo Gauthier (sic), dopo aver dormito una notte nel letto sgangherato messo a sua disposizione dal collega, lasciò scritto su la parete dirimpetto della camera: «Qui un quadro di Raffaello, senza prezzo, come non se ne sono mai visti!».
Una visita di Victor Hugo.
L’autore dei «Miserabili» si presentò un giorno alla villa e chiese una colazione a Balzac. Mentre si preparava l’asciolvere, il padrone di casa approfittò naturalmente dell’occasione per far ammirare la villa, in tutti i meandri, all’insigne visitatore. Ma costui con grande sorpresa dell’anfitrione— non si profuse in complimenti ed elogi ... Balzac aveva un bel spiegare e magnificare ... L’altro guardava impassibile e taceva ostinatamente: fece grazia soltanto ad una pianticella di viole del pensiero... Parve anzi, ad un certo punto, ch’egli facesse sforzi sovrumani per non ridere della strana idea del Balzac di far colare dell’asfalto sui ripidi e stretti sentieri del giardino, come per conferire loro una dignità di «boulevards». Senonchè un grosso albero di noce, presentandosi improvviso ad uno svolto, lo cavò d’impaccio e gli offrì modo di cambiare argomento del discorso ...
— Finalmente, ecco un albero! — esclamò l’autore di «Notre Dame», il quale fino allora non aveva veduto che dei tisici arbusti a fianco dei pretesi viali coperti di bitume. Balzac fu per svenire dalla gioia alla esclamazione. E si affrettò alla esegesi.
— Sicuro, ed un albero famoso! L’ho acquistato dal Comune pochi mesi or fanno! Sapete che cosa produce?
— E’ un noce... — rispose Victor Hugo — e produrrà molto probabilmente ... delle noci!
— Ooibò! Produce ... 1500 lire all’anno!
— Sta bene! 1500 lire ... di noci!
— Niente affatto ... D’argento!
— Allora è un noce incantato come quello di Benevento! rise allegramente l’Hugo.
— Press’a poco! Ma io vi debbo una piccola spiegazione. E Balzac riprese trionfalmente:
— Ecco! Il noce miracoloso, come vi ho detto, apparteneva al Comune ma io l’ho acquistato a carissimo prezzo. Perchè? Per questa semplice ragione: un vecchio uso locale obbliga tutti gli abitanti del luogo a depositare le loro immondizie ai piedi di quest’albero secolare ...
Victor Hugo ebbe un atto involontario di ritrarsi ...
— Rassicuratevi, amico. avvertì Balzac — il noce, da quando io lo possiedo, non ha ripreso le sue antiche funzioni. Ma nessun abitante può sottrarsi a questa servitù personale, sopravvivenza d’un antico diritto feudale. Ora, vedete quanta ricchezza di concime io vedrò fra poco accumularsi ai piedi di quest’albero vespasiano. E il concime municipale io lo farò coprire di paglia e di altri detriti vegetali ed alla fine d’ogni anno ne avrò una montagna da vendere ai coltivatori del paese. Insomma, io possiedo un piccolo Perù, poiché il mio concime sarà migliore del guano depositato dalle note miriadi di uccelli sulle isole solitarie del Pacifico ...
Nel racconto c’era tutto l’uomo e la sua ingenuità proverbiale negli affari. E Victor Hugo motteggiò arguto, colla sua flemma olimpica:
— Ho capito. Voi dite benissimo, caro Balzac: è del guano, ma del guano ... meno gli uccelli!
Precauzione ...misogina.
Dalla villa Balzac erano inesorabilmente bandite le donne. Il proprietario le riteneva pericolose ad un lavoratore costante e produttive come lui. E’ noto, a proposito, un dialogo fra Balzac e Gauthier. Poiché il primo enunciava per l’ennesima volta i principi della sua filosofia anti-femminista, il secondo interruppe un po’ seccato:
— Ma, insomma, queste benedette donne saranno pure create per qualche cosa! Qual genere di rapporti ci permettete con esse?
— Uno solo! — proruppe Balzac. — Noi dobbiamo limitarci a scrivere loro delle belle lettere amorose ... Ciò forma lo stile!
Ferdinando Martini, Nel centenario di Giuseppe Giusti, in Pagine raccolte, Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1912, pp. 33-60.
p. 53. Cfr. 1909.
La “Faustin” di Edmondo De Goncourt, pp. 491-502.
p. 501. Cfr. 1882.
Dal “Fra un sigaro e l’altro”. Cfr. 1876.
Il romanzo e la morale.
pp. 613-615.
Le Memorie di Paul De Kock.
pp. 687; 693.
Poeti e cani.
p. 726.
Pietro Massari, Pagine d’arte e storia. Un grande attore, nostro! [Alfredo de Sanctis], «La Democrazia politico – amministrativo – letterario – commerciale», Lecce, Anno XIII, N. 26, 27-28 Luglio 1912, p. 1.
Io vidi per la prima volta Alfredo De Santis (sic) nel «Colonnello Brindau» (sic) e da quella sera non l’ho più saputo dimenticare. […].
Nel «Colonnello Bridau» il De Sanctis è insuperabile. Se dico che ne fa una creazione, voglio essere, in tutta la estensione e sincerità della parola, creduto. Quando, leggendo l’immensa Commedia Umana, io vi incontrai la vera figura del Colonello, e la seguii a traverso tutte le sue bassure e le sue indegnità, così come l’ha foggiato quel gran Dio letterario che risponde al nome di Onorato De Balzac, io provai una delusione amatissima. Il Colonello interpretato dal De Sanctis era un altro, perfettamente un altro: una creatura diversa che l’autore della commedia pur derivandola dal Balzac, aveva appena abozzato, e che l’artista vivendola, aveva addirittura creato. Ed io rimasi e rimango ancora in dubbio, sulla scelta; se preferire il colonnello Bridau del Balzac, o quello del De Sanctis. L’uno certamente è degno dell’altro, e sotto un certo punto di vista, e per un certo senso, l’uno può essere il complemento dell’altro.
La superficie è eguale: fanfaronate, scetticismo, beffe alla Cirano: il fondo però è diverso: in quello del Balzac, detestabile, in quello del De Sanctis, perdonabile e quasi simpatico. Ma dicevo, provai una delusione, perché m’era talmente abituato a quella figura di Colonnello, la vedevo così naturale, così viva, che non avrei desiderato in alcun modo quella contrapposizione.
M’accorsi, così, subito, che la prima e più grande virtù del De Sanctis è l'originalità. Egli non copia da nessuno altro artista, come non copia da se medesimo.
[Pietro] Massari, “La Cattiva Francesca”, «La Democrazia. Politico – Amministrativo – Letterario – Commerciale», Lecce, Anno XIII, N. 29, 6-7 Settembre 1912, p. 1.
E bisogna dire che tutto ciò ha finalmente compreso il marito, il quale inaugura la seconda fase della luna di miele, componendo, in collaborazione di sua moglie, un’operetta. Il fantasma della Corte fluttua eternamente intorno al loro talamo borghese: ed egli, il maestro Toselli, deve rassegnarsi, per la felicità coniugale, a questa specie nuova di intimo adulterio retrospettivo, come lo definirebbe Onorato de Balzac.
Giuseppe Mazzini, Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini. Volume XII. (Epistolario – Vol. V), Imola, Cooperativa Tipografico-Editrice Paolo Galeati, 1912.
DCCCXII.
a Luigi Amedeo Melegari, a Losanna [pp. 60-62].[7]
[Soleure, … agosto 1836]
pp. 60-61.
Caro amico,
Eccoti la lettera – Gex riceverà i libri. – Fagli sia spiegato che essendo accaduto quel ch’è accaduto, i libri rimasti lontani da me, non s’è potuto trovar né indirizzo stampato, né insomma alcuno degli elementi che costituivano i suoi involti. […] Ma bisognerebbe ch’ei si rassegnasse a fare invii di quattro o cinque opere – e per questo, tre o quattro delle vecchie che nessuno dimanda – una più nuova. […] e del resto, tra’ nuovi lascio la scelta a te, ma se sono romanzi, non mandi, né di Masson, né di Balzac, né di nessuno.
Alfredo Oriani, La Rivolta ideale, Bologna, Libreria editrice Augusto Gherardi, 1912 [1908].
Citiamo dall’edizione delle Opere complete pubblicata dall’editore Licinio Cappelli nel 1943.
Parte Prima.
VI. Trionfo e degradazione industriale, pp. 49-67.
p. 64. Dopo Victor Hugo, retore sovrano e poeta re, sempre librato sulle tempeste, e coll’anima accesa da tutti i baleni del cielo e bagnata da tutte le lagrime della terra, non si vide più un grande poeta; accanto a lui Balzac aveva forse superato Shakespeare, Musset consumato dalla febbre di tutte le passioni sopravviveva in tutti i cuori dolenti […].
p. 67. La grande ascensione della borghesia liberale era precipitata col secondo impero napoleonico; da Hegel il pensiero discese sino a Spencer, il romanzo da Balzac a Zola, la poesia da Hugo a D’Annunzio, la musica da Wagner a nessuno […].
Parte Terza.
II. Femminismo, pp. 298-312.
pp. 303-304. Perché la donna non oltrepassa mai la mediocrità. […].
Quale donna si assiderà quinta fra Eschilo e Shakespeare, Dante e Balzac? […] George Sand, la più grande donna del secolo decimo nono, come è piccola tra Hugo e Wagner! […]
p. 308. Se adesso votano i giardinieri, ciò accade perché […] i suoi poeti si chiamano Hugo, i suoi romanzieri Balzac, i suoi eretici Lamennais, i suoi critici Strauss, i suoi musici Wagner, i suoi scettici Renan, i suoi atei Bule, i suoi eroi Garibaldi, i suoi generali Moltke, i suoi imperatori Napoleone.
IV. Gli spostati, pp. 320-331.
p. 327. […] nella preparazione del risorgimento, l’Italia aveva trovato Manzoni, e se ne vantò troppo: nella grande vittoria finale le mancò Balzac.
Raniero Paulucci di Calboli, I pregiudizi sessuali e l’elevazione della donna, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CLX – Della Raccolta CCXLIV, Fascicolo 976, 16 Agosto 1912, pp. 554-566.
pp. 560-561. Se il Balzac avea stupito mezzo secolo fa i suoi contemporanei, proclamando il diritto all’amore di una donna trentenne, oggigiorno questo diritto non lo si nega neppure a molte signore cinquantenni …
Amedeo Pescio, I nomi delle strade di Genova, Bologna, Arnaldo Forni editore, 1912.
p. 314.
SCIMMIA (vico della -). Prè, da piazza Bandiera alla via di Sant’Agnese.
E Balzac — scusate signore! —: Vi è sempre una gran scimmia nella più bella e angelica delle donne. — Scusate, ripeto ... ma De Maistre è della stessa opinione!
Avv. Calogero Picone-Chiodo, Onorato Balzac. Medaglioni, «L’Università Popolare», Milano, Anno XII, N. 6, 16 Marzo 1912, pp. 88-89.
Esempio mirabilissimo di pertinacia nello studio e di forza di volontà fu Onorato Balzac.
Nacque a Tours il 16 maggio 1799 il giorno di Saint Honoré (donde il suo nome di Onorato) e fece i primi studii nel collegio di Vendôme, dove divorò tutti i libri che gli cadevano nelle mani. Il penoso e incessante lavoro della sua mente per la organizzazione delle idee, lo rendeva, a 14 anni, così distratto che i genitori ne erano seriamente impressionati.
Essendosi, nel 1813, il padre trasferito a Parigi, Onorato fu costretto a recarsi in uno studio legale: ma la sua passione erano le lettere. «Voglio diventare un letterato», rispondeva il giovane nel 1820 al padre, il quale lo consigliava a sciegliere (sic) una carriera.
«Per morir di fame! esclamava la madre. Diventa notaio piuttosto, e ti farai ricco: nelle lettere è necessario essere re per non esser l’infimo».
«Ed io sarò re!».
I primi tentativi, però, nella letteratura furono poco fortunati, ma Balzac, fidente nel suo genio e ricco di robusta volontà, non si scoraggiò: ostinatamente perseverò nella sua via. A corto di mezzi, avendolo i genitori privato di aiuti per indurlo a cambiar carriera, si diede alle imprese industriali: fu editore e tipografo, ma non riuscì che a far debiti.
Purtroppo i bisogni dell’esistenza tentavano travolgerlo e il suo astro non si decideva a spuntare: ma Onorato lo attendeva e difatti, nel suo cielo tempestoso, spuntò bello e fulgido, irradiandolo dei fulgori della gloria.
La notorietà gli fu data dal volume: La physiologie du mariage – 1829 — che era stato preceduto da altri, quali: Le dernier chovan (sic) – 1827 — e Catherine de Médicis. Nella medesima epoca pubblicò: Gloire et Malheur, El Verdugo, La Maison du chat qui pelote, Le bal de Sceaux.
Completo successo ottenne nel 1830 con Le (sic) peau de chagrin, e assicurata così la fama dell’artista, la serie delle sue pubblicazioni continuò abbondante, fino al 1847 e tra gli altri lavori scrisse: La vendetta, L’elixir de longue vie, L’Auberge rouse (sic), un épisode dans la terreur — 1831 —, Le chef d’oeuvre inconnu, Les cent Contes dialetiques (sic) — 1832 — Eugénie Grandet, Les Employés — 1833 —, Le père Goriot, Un drame au bord de la mer — 1834 —, Le lis (sic) dans la vallée — 1835 —, César Biroteau (sic) — 1837 —, Mercadet — 1838 —, Vautrin — 1839 —, Splendeur et misère (sic) des courtisanes — 1843 —, Ce (sic) curé de village — 1845 —, Dernière incarnation de Voutrin (sic) — 1846. —, ecc.
Volle riunire tutti i suoi romanzi sotto il titolo di Commedia umana, divisi in serie determinate: studii di costumi, studii filosofici, studii analitici.
Balzac era pittore, pittore di costumi sopratutto e aveva un senso finissimo della vita privata, dei costumi borghesi, della realtà volgare dell’esistenza, delle scene intime, delle piccole miserie e volgarità: sotto questo aspetto la sua facoltà di osservazione e la sua tenace memoria gli fornirono effetti d’una meravigliosa realtà. Quando traccia un ritratto, si direbbe che il modello gli posa innanzi. Egli aveva il dono di vivere nei suoi personaggi e di incarnarsi in essi.
Fu, asserisce Lamartine, l’uomo che scrisse egli solo tutta una biblioteca del suo secolo, il Walter Scott della Francia, ma non il Walter Scott dei paesaggi e delle avventure, ma quello della vita umana, il Dante dei caratteri, il Molière della commedia scritta, meno perfetto, ma altrettanto fecondo e creatore, quanto quello della commedia recitata.
Egli va dritto alla meta e afferra, come dice Victor Hugo, pel corpo la società moderna strappando a tutti un brandello. Agli uni l’illusione, agli altri la speranza, a questo un grido, a quello una maschera; fruga il vizio, dissecca la passione, scruta, scandaglia l’uomo, l’anima, il cuore, le viscere, il cervello, l’abisso che ciascuno ha in sè. Era dei primi fra i grandi, dei più alti fra i migliori.
Eppure un grave professore dei Collegio di Francia, invitato dal padre d’Onorato a dare un giudizio sul figliuolo, non mancò di sentenziare, dopo trepidante lettura fatta da Balzac del suo Cromwell: «Questa tragedia, non dà indizio alcuno d’ingegno in colui che l’ha scritta!».
O giudizio umano, come spesso erri!
La sua attività fu prodigiosa. In sei anni pubblicò settanta volumi i quali prima di vedere la luce venivano da lui corretti e ricorretti, mutati, aumentati; ed è noto che, uno dei suoi romanzi, Pierrette, fu corretto da lui ventisette volte!
Morì il 18 agosto 1850, dopo 4 mesi di matrimonio colla contessa Evelina de Hanska —- innamorata del genio di Balzac — salutato da Victor Hugo colle celebri parole: «Dopo una vita di lotte e di stenti, abbandoni gli odii e le contese per entrare nell’ora stessa nella gloria e nel sepolcro».
E.[mile] Pouget, Il sabotaggio. [...]. Il sabotaggio e Balzac. [...], «La Battaglia. Periodico settimanale anarchico», San Paolo (Brasile), Anno VIII, Num. 338, 21 Gennaio 1912, p. 4.
Questa conseguenza ineluttabile del conflitto permanente che divide la società veniva messa in luce, tre quarti di secolo fa, da Balzac, nella Casa Nucingen, a proposito dei moti sanguinosi di Lione, del 1831. Egli ci ha dato una chiara ed incisiva definizione del sabotaggio:
«Ecco: - scrive Balzac — si è parlato molto dei moti di Lione, della repubblica cannoneggiata per le strade; ma nessuno ha detto la verità. La repubblica s’era impadronita del movimento come un insorto s’impadronisce del fucile.
Il commercio di Lione è un commercio senza coraggio: che non fabbrica una oncia di seta senza che essa sia domandata e che il pagamento sia fatto subito. Quando l’ordinazione si arresta, l’operaio muore di fame; quando lavora, egli guadagna appena che vivere. I galeotti sono più felici di lui.
Dopo la rivoluzione di luglio, la miseria è arrivata al punto che gli operai hanno inalberato il vessillo: Pane o morte! Un vessillo che il governo avrebbe dovuto considerare. Lione voleva costruire teatri per divenire una capitale: di qui, spese insensate.
I repubblicani hanno fiutato, attraverso la miseria, la rivolta, ed essi, hanno organizzato i filatori che si sono battuti in partita doppia. Lione ha avuto i suoi tre giorni. Poi tutto è rientrato nell’ordine ed il pezzente nel suo canile.
Il filatore che aveva, fino allora, trasformato in stoffa la seta che gli si pesava in bozzoli, ha messo alla porta la probità ed ha cominciato ad ungersi di olio le dita: egli ha reso con meticolosa scrupolosità il peso esatto, ma la seta era tutta chiazzata di olio, ed il commercio delle seterie è stato, così infestato di stoffe unte, ciò che avrebbe potuto cagionare la perdita di Lione ed una parte del commercio francese ...».
Balzac ha avuto cura di sottolineare che il sabotaggio dei filatori non fu che una rappresaglia di vittime. Ponendo dell’olio nelle tessiture, gli operai si vendicavano di fabbricanti feroci: di quei fabbricanti che avevano loro promesso baionette da mangiare invece di pane e che avevano saputo lautamente mantenere la propria promessa!
Del resto, quando un atto di sabotaggio non è l’equivalente di una sopraffazione subita? Forse che nell’origine o nelle cause d’ogni atto di sabotaggio non si rivela lo sfruttamento padronale che sa giungere sino alla crudeltà?
E questo sfruttamento, in qualsiasi condizione si manifesti, non deve provocare e legittimare anche un atteggiamento ed una azione di rivolta—qualunque essa sia?
Giovanni Rabizzani, I classici del ridere, «Il Marzocco», Firenze, Anno XVII, N. 49, 8 Dicembre 1912, p. 2.
Il Balzac dei Contes drôlatiques non si collega a Luciano o anche con lo stesso Rabelais, ma col Balzac della «Commedia umana» […]. La gaiezza di Balzac e quella di Shakespeare trovano il loro limite, la forma, il tono nella serietà che li circonda e che ha prodotto i personaggi amari e tragici dell’altra faccia.
Alfredo Rota, Variazioni: un convegno di dame, «Emporium. Rivista mensile illustrata d’arte – letteratura- scienze e varietà», Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Vol. XXXVI, N. 212, Agosto 1912, pp. 99-115.
p. 110. La mano, ha detto Balzac, non è mai supplita; la somma intera della nostra forza passa in lei.
Gerolamo Rovetta, Cinque minuti di riposo! Scritti varii raccolti da Paolo Arcari, Casa Editrice Baldini & Castoldi, 1912.
Paolo Arcari, Prefazione, pp. VII-XVI.
p. XV. Ci chiederemo sempre come mai non fossero alti i cuori degli italiani in un decennio nel quale l’Italia aveva meravigliosamente contemporanei, il Carducci, il D’Annunzio, il Fogazzaro; in cui, aggiungeremo, come non osò dire nessun italiano ma seppe scrivere un francese, Paolo Hazard, l’Italia aveva nel romanziere delle Lagrime del Prossimo, nel creatore di Pompeo Barbetta, il suo Balzac.
Il vero Tolstoi, pp. 119-126.
p. 123. Su questa via [«la volontà acre del soffrire, del patire»] era indirizzata l’opera di Balzac, ma la «sensibilità al dolore] era troppo sapientemente soggettiva ed individuale, e per ciò Balzac non è giunto ad abbracciare tutta quella pluralità di dolori umani che il suo genio avrebbe potuto intuire ed analizzare. Dopo di lui il suo più legittimo erede, Gustavo Flaubert nella Bovary, e più ancora nel suo libro giovanile Le memorie di un pazzo […]. Così Flaubert, come Balzac, non ha potuto amare il dolore nella virilità, quanto lo aveva amato nella prima giovinezza e non ha potuto farne l’unico ispiratore della sua arte. Balzac e Flaubert raramente si lasciarono vincere dal senso dell’indulgenza e della pietà; per questo, l’opera loro è potente, incisiva, ma desolata ed amara.
Enrico Ibsen, pp. 127-138.
p. 132. Ibsen rievocava Balzac, sotto forme opposte, di una terribilità nuova, veramente spaventevole per la sua verità, la sua calma, la sua logica.
Luigi Gualdo, pp. 217-234.
p. 244. [su: Decadenza]. È il libro che scriverebbe Balzac, se Balzac fosse vivo oggi.
Emilio De-Marchi, pp. 235-253.
p. 237. Questo Demetrio [Pianelli] è certamente una delle più belle figure del romanzo contemporaneo. È una figura degna del Balzac, ringiovanita coll’arte semplice e schietta del romanzo russo.
Vecchi e giovani, pp. 369-377.
[A proposito di: Raffaello Barbera, Il Salotto della contessa Maffei].
p. 372. Quante cose, per esempio, non abbiamo letto un po’ dappertutto di Onorato Balzac, della sua fecondità maravigliosa, de’ suoi debiti innumerevoli, de’ suoi malumori implacabili? Eppure, nulla di più curioso, di più gradito e di più interessante dell’incontrare l’autore della Commedia Umana, anche a Milano, ospite del principe Alfonso Serafino Porcia, che gli ha destinata una bella stanza verso il giardino, nel suo palazzo di porta Prientale, e di studiare il Balzac anche quale frequentatore assiduo del salotto della «petite Maffei» in formazione.
Filippo Salveraglio, Balzac (Onorato di), in Vocabolario italiano illustrato con le voci anche straniere attinenti a scienze, lettere, arti, commercio, industria, politica, vita pratica, arte militare, marina, tutti gli sports, locuzioni latine e italiane, proverbi ecc., Milano, Casa Editrice Bietti, 1912, p. 144.
Balzac (Onorato di), celebre romanziere francese, n. Angoulême (sic). Suoi principali romanzi: La ricerca dell’assoluto, Il Medico di Campagna, Eugenio (sic) Grandet, I genitori poveri.
Natale Scalia, Luigi Capuana, «Italia! Letture mensili», Roma-Torino, Anno I, Volume I, 1912, pp. 333-342.
p. 336, nota (1). Capuana stesso giustifica questo cambiamento radicale con il raccontarci che Telemaco Signorini e Carlo Levi lo spinsero, mentre si trovava a Firenze, a leggere i romanzi del Diderot e del Balzac: una rivelazione, dalla quale gli sarebbe derivato «il mortifero veleno del romanzo e della novella». Ma, come si vede, questa è una ragione accidentale, puramente esterna, troppo semplice per esser vera: la causa è molto più in là e molto più in fondo, poiché tutti abbiamo letto Balzac senza diventar ... Luigi Capuana, o, per lo meno, novellatori.
Scipio Sighele, Letteratura e sociologia. Le idee di Paul Bourget, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CLXII – Della Raccolta CCXLVI, Fascicolo 984, 16 dicembre 1912, pp. 552-569.
pp. 563-564. Paolo Bourget ripete trionfalmente contro i rivoluzionari dell’89 e contro i democratici d’oggi che sono i loro eredi, la frase di Balzac: «l’homme n’invente pas une force, il la dirige, et la science consiste à imiter la nature»[8]. E facendosi forte di questa frase che riassume innegabilmente il metodo scientifico, afferma che i rivoluzionari dell’89 e i democratici d’oggi l’hanno misconosciuta, perché essi non hanno imitato la natura ma l’hanno bestemmiata pretendendo di costruire d’emblée un nuovo ordine di cose invece di star attaccati, anche nel campo sociale e politico, a ciò che aveva una vita di secoli.
Amedeo Tosti, In difesa … di Giosue Carducci, «Il Convivio. Quindicinale di coltura», Lucera, Anno I, N. 4, 15 marzo 1912, p. 3.
Il Bellonci ha notato che «il Carducci non ha conosciuto il Balzac, non ha sospettato il Baudelaire e non ha saputo mai nulla della letteratura inglese». Curioso! mentre alcuni hanno rimproverato al Carducci una soverchia erudizione riflettentesi anche nella sua opera poetica, ora gli si rimprovera di averno avuta poca! Ma anzi tutto, prima del Carducci, chi in Italia, aveva avuto più di lui conoscenza delle letterature straniere, meno qualche specialista? Non destarono forse meraviglia le sue belle traduzioni dai poeti Tedeschi e la sua profonda conoscenza della storia e della letteratura Francese? Il Bellonci anche questa gli nega: ma bisognerebbe pensare che il Carducci non era uno di quelli cui, come giunge qualche eco lontana di un Kirkegaard o di un Bergson non par vero di farne sfoggio, sia pure in una parentesi o in una chiusa di articolo. Che il Carducci conoscesse Balzac è stato sufficientemente dimostrato dal Morello [cfr. V.[incenzo] Morello, Goffredo Bellonci, Una grande polemica. Anche un po’ di Balzac!, «Il Giornale d’Italia», Roma, Anno X, N. 357, 24 Dicembre 1910, p. 3.], con due citazioni dalle prose che il Bellonci dice «faticosamente assembrate» come se il Carducci che ha scritto di mille argomenti avesse dovuto necessariamente dedicare al Balzac un intero volume. Non sarebbe neppur difficile trovare nell’opera Carducciana un accenno al Baudelaire ch’egli certamente aveva letto e fors’anche imitato in qualche sua poesia; ma non sarebbe poi permesso a un uomo, che, come il Carducci, avesse fatto sua tutta la letteratura classica d’ignorare Baudelaire?
Alfredo Vinardi, Balzac uomo politico, «Corriere delle Puglie», Bari, Anno XXVI, N.° 194, 14 Luglio 1912, p. 4; «L’Italia Centrale. Quotidiano della democrazia di Reggio Emilia», Reggio Emilia, Anno L, N. 197, 17 Luglio 1912, p. 3.
Nei giorni di fiera o di mercato, certi librai ambulanti sogliono attraversare i piccoli paesi di provincia, dove manca ancora la ferrovia o le stazioni climatiche o balneari di secondo ordine, e spesso il privato – non so se mai vi occorse – trova a comprare buoni libri a prezzi ridottissimi, a fornirsi di pubblicazioni specialmente interessanti …
Per conto mio io chiedo sempre ai librai ambulanti, che vengono ad offrirmi la loro biblioteca perché io scelga qualche studio intorno al Balzac e mi trovo soddisfatto. Posseggo degli studi critici e biografici intorno all’autore della «Commedia Umana» che magari fanno a pugni tra di loro, ma che pure non mancano di qualche lato interessante.
Giorni sono, in Valle d’Aosta, tra Gaby ed Issime, mentre l’automobile mi portava verso Gressoney, sempre incantevole nei primi ardori dell’estate, ho ritrovato uno dei miei fornitori di libri balzachiani.
Un «alt» s’imponeva oltre lo sport in favore del sapere, e mi fermai.
Il brav’uomo mi riconobbe, e, senza più interrogazioni sui miei desideri, mi presentò in libro piuttosto sdruscito, un centinaio di pagine ingiallite e tenute insieme da una cucitura robusta, in copertina rosa pallida …
– Un nuovo Balzac? dissi io tosto prendendo con curiosità il libretto dalle mani del libraio …
– In fatti – replicò il mercante – il libro fu pubblicato a Tours, nel 1845, cinque anni prima della morte dello scrittore.
Era vero. Di ignoto autore, il libro era stato pubblicato a Tours, nel 1845. La copertina non recava altra indicazione oltre il titolo: «Honoré de Balzac politique».
Interessante senza dubbio e anche nuovo in certo senso, essendo il Balzac uomo politico quasi ignoto in confronto del letterato e del romanziere … Comprai il volumetto e lo lessi di un fiato.
Gressoney poteva aspettare: la politica, invece, talora, non ha gran fretta.
Lo credereste? Se la politica non ha avuto nella vita di Balzac la parte preponderante che ebbe in quella di Lamartine, ad esempio, e di Victor Hugo, pure le ambizioni politiche di Balzac, formano – secondo l’ignoto autore del vecchio libro – uno dei capitoli più piccanti della vita del gran romanziere.
Piccanti, perché?
Perché – e in ciò anche uno degli ultimissimi biografi di Balzac, Jules Bertaut, si trova d’accordo con l’anonimo di Tours – Onorato di Balzac non ha fatto nel campo politico, che cambiare le idee a seconda del suo vantaggio e della sua speranza di riuscire.
Decisamente, l’arrivismo è stato di tutte le età …
Ma, andiamo innanzi con ordine.
Nato da un padre aristocratico [?], se non realista, educato in una pensione che si modellava sulle idee dell’Antico Regime, Balzac fu dapprima naturalmente portato ad accettare le idee che avevano diretto la sua famiglia.
Del resto, egli non ebbe, durante tutta la sua vita, l’opportunità e il tempo di studiare a fondo le condizioni sociali della Francia. Piuttosto che un osservatore, egli poteva dirsi un veggente, un creatore di vite …
Così la prima volta che Balzac si portò candidato politico, proclamò di militare nelle file degli aristocratici. Così fu nel 1831.
La signora Carraud alimentava in lui le velleità di essere deputato, e Balzac, che era stato due anni a Rougères (sic), ospite del barone Pommerel (sic) pensò di porre la sua candidatura in questo collegio.
Ne diede subito avviso al barone, spedendogli quaranta copie di un suo opuscolo dal titolo: «Inchiesta sulla politica di due ministeri», dove lo scrittore saltava di palo in frasca, occupandosi un po’ di tutto, e non sempre chiaramente, di cose militari, di giornalismo, delle leggi elettorali, e criticando specialmente queste ultime.
Troppe idee – annotò l’anonimo – perché fossero veramente stabili!
La battaglia elettorale non avvenne, poiché fu risposto allo scrittore che il partito aveva già il suo candidato …
*
Ecco allora Balzac mutar programma!
Sceglie tosto i collegi di Cambrai ed Angoulême, dove aveva degli amici e dei parenti … inalberando un programma liberale e dichiarando di voler la separazione del clero francese da Roma, oltre alla distruzione dell’aristocrazia.
Battaglia perduta anche questa – Balzac fu attutissimo, raccogliendo ad Angoulême … dieci voti.
Un altro, al suo posto, si sarebbe perduto di coraggio: Balzac no.
Nel 1832 ripresenta la sua candidatura a Chinon, in piena Turenna, paese realista, e la «Quotidienne» annuncia che il signor De Balzac, «giovane scrittore pieno di ardore e di talento» vuol dedicarsi alla difesa dei principii su cui riposa la felicità della Francia …
La verità era che Balzac s’era legato con una duchessa, la duchessa De Castries, che lo guidava, come prima lo aveva guidato madame Carraud!
Ma, alla vigilia di mettersi in viaggio per cominciare la sua campagna elettorale, Balzac cadde da una vettura e si fece tanto male che dovette stare a letto per più giorni. Così lo scrittore non ebbe neanche la soddisfazione di vedersi nominato fra i candidati battuti.
Ciò però non gli impedì di ripresentare il suo nome alle elezioni del ’48.
In tale anno, Balzac aveva centomila lire di debiti; le cose andavano male per lui e per gli editori.
Egli, allora, pensò ancora di cambiare partito e di entrare nella democrazia. Scrisse infatti al «cittadino presidente del Club della fratellanza universale a Parigi», dichiarando di accettarne il mandato elettorale …
Ma, la tempesta rivoluzionaria si era scatenata, e nessuno si accorse di quella dichiarazione.
L’uomo politico era vinto, definitivamente finito, e Balzac prese una grande decisione: ritornò alla letteratura, e ricreò il mondo, sistematizzandolo e semplificandolo: riunì cioè un esercito di qualche migliaio d personaggi, e lo fece muovere a sua guisa, tanto che la conquista del mondo, realizzata nella «Commedia Umana», può dirsi un fatto così grande nella letteratura moderna, come lo fu nella storia l’epopea napoleonica.
Fanciullo, Onorato di Balzac, aveva sognato di conquistare il mondo, e il sogno era diventato una realtà trionfante …
A.[lfredo] V.[inardi], Le curiosità della storia, dell’arte e della scienza. L’uva di Balzac, «Corriere delle Puglie», Bari, Anno XXVI, N.° 273, 1 Ottobre 1912, p. 3.
Siamo d’autunno e in tempo di vendemmia, per cui il ricordo acquista anche più il pregio dell’attualità.
A Passy, presso Parigi, dove Balzac tanto lavorò, — non lungi dalla superba villa di Gioacchino Rossini — accanto alla casa del romanziere, in fondo al sobborgo., nella via Raynouard, c’è oggi ancora una piccola vigna.
Alcuni fedeli del grande scrittore hanno trasformato la casa in un museo, ed ogni autunno, in picciol numero, si recano a vendemmiare la vigna.
E’ un gruppo di letterati, d’artisti e di graziose dame che si portano appositamente da Parigi a Passy per spiccare dalla vigna di Balzac i grappoli rari.
La cerimonia è semplice e gentile.
Un cappellone di paglia basta a contenere tutta la raccolta e i gravi profumi dionisiaci che volteggiano sui ceppi della Gallia Narbonese non infastidiscono i visitatori della pacifica via Raynouard.
Un letterato francese, Leo Larguier, racconta di aver mangiato in questi giorni un grappolo d’uva della vigna di Balzac — dopo di aver assaporato quella fresca — conservato religiosamente dalla raccolta dell’altro anno e offertogli alla fine di un pranzo.
Quando fu giunto il momento del «dessert» fu presentato all’ospite il grappolo. e i dolci e le frutta ... senza storia sembrarono a lui ben poca cosa in confronto con quell’uva che pareva inviata in dono dal maestro stesso.
L’uva della vigna di Balzac!
Mangiarla non equivale a mangiare, per un egittologo fanatico, del pane fabbricato con frumento trovato nel sarcofago di una regina? E’ l’uva di Balzac creatore. Infatti, Balzac ha creato.
Egli non mentiva mai: ciò che affermava, esisteva veramente in lui.
Un giorno un amico entrò bruscamente nel suo studio e annunziò la «signora Marneffe», (la signora Marneffe del romanzo «Cousine Bette! ...).
Balzac. seriamente, si ravviò i capelli s’accomodò l’abito e. rispose tosto: «fatela entrare!»
Cenava lo scrittore, una sera, a casa di Madame De Girardin e, poiché si parlava a tavola di storia naturale, Balzac immaginò una bestia inventata di sana pianta e si mise a parlarne ...
Gli ospiti rimasero assai stupiti. Allora, il poeta Méry, ch’era tra i commenzali, capita la cosa, venne in soccorso del romanziere, e con la sua grande erudizione citò Plinio, Buffon, Cuvier, riuscendo ad interessare i convitati ai costumi dell’animale sconosciuto.
Méry raccontò storie di viaggi, di scienziati, di naturalisti, snocciolando citazioni cervellotiche.
Quando tutti si levarono da tavola. Balzac si avvicinò a Méry, e piano gli disse all’orecchio: «Ma davvero quell’animale esiste?’
«Perché no?» — rispose Méry.
Non esistono forse Rastignac, Papà Goriot, Eugénie Grandet e De Marlay? (sic)».
E questo fatto — scrive Leo Larguier – si ripete ogni anno di questi giorni, allorché in piccola brigata ci rechiamo a vendemmiare la vigna di Balzac.
Quei grappoli d’uva balzacchiana eccitano il nostro cervello, c’infiammano la fantasia, tanto che, durante la vendemmia, mentre discorriamo del maestro e dell’opera sua, ci sembra veramente di vedere tutti i personaggi della «Commedia Umana» muoversi attorno a noi, agitarsi, vivace, come esseri reali e visibili ...
Vitige, Fra libri vecchi e nuovi. S. Spaventa Filippi: “Carlo Dickens”. – A. F. Formiggini, Editore in Modena, «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XXII, Vol. XXXII, N. 10, 15 maggio 1912, pp. 469-470.
p. 470. Si potrebbe, come creatore di tipi umani, accostarlo al Balzac, ed ebbe rivale un compatriota e giusto estimatore nel Thackeray: ma se il primo lo superava nella grandiosità e nella universalità delle sue figurazioni, il secondo gli rimane inferiore nella comicità e nella pietà. Veramente all’opera di Dickens, presa tutta insieme, competerebbe pure, se non in pari grado con quella del Balzac, il titolo di Commedia umana, secondo che noi Italiani intendiamo la parola Commedia, guardando principalmente al nostro Goldoni: o almeno di Commedia inglese.
Giovanni Zuccarini, De sui ipsius et aliorum ignorantia. Dal Carducci dal Nietzsche al Balzac della terza Italia, in Schegge e sprazzi. Prose critiche e civili. De sui ipsius et aliorum ignorantia […], Ancona, Giovanni Puccini e Figli – Editori, MCMXII, pp. VII-LXXX.
pp. XLVI-IL. […] il più grande filosofo è colui che ha l’ingegno più limpido è colui che meglio ha studiato e compreso l’anima umana osservandola più da vicino, dissolvendola in tutti i più oscuri viottoli. Noi potremo ripetere ciò che a molti sembrerà per lo meno un paradosso e un’eresia: cioè che il più grande filosofo moderno è Onorato di Balzac.
A noi non interessa tanto lo studio speculativo e metodico dei fenomeni dello spirito o della ragione in loro stessi e della loro origine e della loro stasi e del loro svolgersi nello spazio e nel tempo e della loro conclusione morale e del loro nesso logico e della loro critica comparata; ma la semplice analisi dei fatti interni, che determinano le azioni esterne o viceversa l’osservazione dei fatti esterni che svelano i moti interni, e che caratterizzano i tipi. […] E se fu detto come sopra notammo che la filosofia del Hegel generò in Francia uno storico grande come Ippolito Taine vi fu anche chi osservò con più ragione che il Taine per indagare le origini della Francia contemporanea non fece che applicare in tutto e per tutto il metodo che Onorato di Balzac aveva applicato nell’arte e nella vita: cercò cioè di svelare i fatti più complessi della storia, studiando i caratteri fisici, psicologici, ereditari dei personaggi più eminenti e rovistando tra i documenti privati delle famiglie che maggiormente avevano preso parte agli avvenimenti[9]. […].
Di un uomo adunque della tempra e del cervello di Onorato di Balzac io credo che l’Italia abbia bisogno perché possa acquistare il senso esatto della realtà, che dopo il senso storico è indispensabile perché una nazione possa giungere a superare il suo destino. […].
pp. L-LII. Noi dobbiamo ancora svelare gli italiani all’Italia, l’Italia all’Europa.
Mentre in Francia fiorivano romanzieri giganteschi come Onorato di Balzac, Gustavo Flaubert, Guy de Moupassant (sic), Emilio Zola […], in Italia si prediligevano ancora per impulso patriottico i romanzi del Guerrazzi, del d’Azeglio, del Grossi, del Cantù, del Nievo […].
Dalla Francia uomini come il Mazzini e il Tommaseo avevano scritto contro Onorato di Balzac mettendo in guardia gli italiani dalla peste deleteria del suo naturalismo; e in vari punti della penisola il Guerrazzi, il Cantù ed altri fecero eco. E quando il grande romanziere venne in Italia trovò pochi ammiratori, e fu accolto nei salotti dell’alta Italia soltanto con una certa curiosità mista a diffidenza come fosse una bestia rara. Le signore e le signorine più colte, assuefatte alle romanticherie dell’Aleardi e del Prati, che sognavano forse il tipo del poeta di aspetto esile, pallido, azzimato, con gli occhi rivolti alla luna, trovarono prosaica la sua persona, che sforzava nei salotti le molle dei divani, e non potevano soffrire che egli parlasse con predilezione di affari e lo deridevano perché si firmava nei registri degli alberghi con la qualifica di possidente. Per aver egli espresso poi un giudizio franco e in parte giusto su i Promessi Sposi dicendo che come romanzo gli sembrava povero di ordito le antipatie si cangiarono presto in schietto odio e in vituperio.[10]
In simile ambiente e con tali criteri d’arte, poteva favorevolmente svolgersi e fiorire una sana e spregiudicata psicologia? […].
pp. LXII-LXIII. È mancato dunque all’Italia il suo Balzac e la Commedia umana italiana deve essere ancora scritta.
A tale opera immane non basterà di certo un semplice genio artistico: ma ci vuole un’anima agitata da tutte le passioni umane, letterarie e politiche, un’anima che abbia intensamente pensato e vissuto nel mondo storico del passato e specialmente nella realtà del presente e che abbia anche una visione limpida dell’avvenire. […].
p. LXV. Già che siamo dunque al tempo degli annunziatori e dei preparatori diciamo anche noi con la persuasione ingenua delle anime semplici: «Apprestiamo all’Italia il suo Balzac!».
Le scuole e un libro per le scuole di G. Pascoli, pp. 49-59.
p. 52. Tommaso Carlyle, nella meravigliosa Lettura dell’eroe quale letterato, dice che dopo la grande invenzione della stampa la migliore università è una bella collezione di libri; e se noi osserviamo la vita dei principali uomini illustri vedremo che essi si formarono al difuori delle scuole e delle accademie, da Dante a Gian Giacomo Rousseau a Onorato di Balzac […].
Le novità al teatro Argentina.
La “Flotta degli emigranti” di Vincenzo Morello, pp. 225-232.
p. 231. Sì che si può dire che di questo lavoro di Vincenzo Morello ciò che appare più perfetto e delineato è l’ambiente politico che inquadra il dramma psicologico. In esso vi si trova in vero l’unghia di Onorato di Balzac.
“I Figli del Sole” di Massimo Gorki al Teatro Valle, pp. 251-255.
p. 252. I suoi delinquenti abbruttiti mi fanno rimpiangere soltanto quelli più efficaci e scultorii di Vittor Hugo, di Onorato di Balzac […].
… Ridiculus mus. A proposito del “Carroccio”, pp. 271-279.
p. 275. Tutte le idee in buona fede sono rispettabili, tanto più quando sono professate con coraggio (chi vorrebbe ad esempio diminuire l’ammirazione e l’amore verso Onorato di Balzac che nel periodo più acceso della democrazia vittorhughiana si vantava di essere legittimista?) […].
La riotta de’ Proci.
Per l’integrità morale letteraria e politica di Giosue(sic) Carducci, pp. 293-326.
p. 297. Se n’è occupato [di G. Carducci] un giornalista vigoroso come Vincenzo Morello fino al punto di cadere in quisquiglie polemiche assai stupide come ad esempio la discussione se il Carducci avesse o non avesse letto il Balzac[11]. (1)
(1) Questo di voler pretendere dal Carducci chi sa che cosa, di volerlo far essere nello stesso tempo il Balzac e il Victor Hugo, il Goethe e il Tolstoi, il Voltaire e il Rousseau italiano è una cosa ebete quanto mai. Il Carducci fu il Carducci e non è poco e dovrebbe bastare! Il Balzac italiano, il grande ingegno osservatore che scruti a fondo l’anima umana di nostra gente deve ancora svelarsi. […]
p. 298, nota (I). Io ho avuto sempre una viva e quasi nostalgica simpatia per il genio balzacchiano di Alfredo Oriani e molto lo stimavo mentre lo si lasciava ingiustamente languire nel silenzio e nell’indifferenza. […]
p. 338, nota (2). [In polemica con B. Croce]. Tutti i grandi tragedi antichi e moderni non furono dunque che dei poltroni se si limitarono a copiare la storia! […] E che cosa fece Onorato di Balzac se non la storia privata del suo tempo?
Per “Alla Fonte della Vita” [1905]
(Il Marchio di Roma), pp. 365-371.
pp. 369-370. Cero scrivere un romanzo è cosa sì eccelsa che dovrebbe dar le vertigini non che a un giovane inesperto, ad un uomo maturo di anni e di studii. Onorato di Balzac, che scolpì i caratteri della sua Comedie (sic) Humaine nel granito, e con più forza, efficacia e tenacia forse che lo scalpello michelangiolesco di Augusto Rodin non v’abbia ritratta la di lui effigie gigantesca, ne enumerò le infinite difficoltà. Saggiamente egli ammoniva alle mezze coscienze e alle mezze intelligenze che a cuor leggero si accingono all’arduo lavoro: «– che è oltremodo difficile divenire buoni scrittori prima di dodici anni almeno di fatiche erculee intorno alla lingua; – che bisogna aver sfogliato pagina per pagina tutta la vita sociale prima di riuscire romanziere vero, visto e considerato che il romanzo contemporaneo non è che la storia privata delle nazioni; – che tutti i grandi narratori (Esopo, Luciano, il Boccaccio, il Rabelais, il Lafontaine (sic), il Lesage, lo Sterne, il Voltaire, Walter Scott, gli Arabi sconosciuti delle Mille e una notte) furono tutti uomini di genio e colossi di erudizione».
Adattamenti teatrali.
Veronica, commedia in tre atti di Gabriele Trarieux (dal romanzo di Balzac: Il Curato del villaggio), Napoli, Teatro Fiorentini, Compagnia Emma Gramatica, aprile 1912.
[1] Cfr. Joachim Merlant, Les variantes de Madame Hanska, «La Revue Bleue», Vol. L, 19 ; 26 Octobre 1912, pp. 498-502; 526-529.
[2] Cfr. «Revue hebdomadaire», 2 décembre.
[3] Cfr. «La Revue», 1er août.
[4] Citazione tratta da: La Muse du Département.
[5] Cfr. Leopoldo Crilanovich, Storia. Galleria di statuette di celebrità contemporanee. XI. Onorato di Balzac, «Il Gondoliere», Venezia, Anno XIV, N. 64, 31 Ottobre 1846; ora in R. de Cesare, La prima fortuna … cit., Vol. II, pp. 983-989.
[6] Citazione tratta, come le seguenti, da Le Père Goriot.
[7] Segnalato in R. de Cesare, La prima fortuna … cit., Vol. I, p. 253.
[8] Citazione tratta da La Peau de chagrin.
[9] Il Taine stesso venne a riconoscere questo fatto quando esaltò il metodo naturalistico di analisi e di osservazione psicologica dello Stendhal che fu il vero maestro ed ammiratore di Onorato di Balzac. [N. d. A.].
[10] Vedi – Il salotto della Contessa Maffei di Raffaello Barbiera. – Per contrario il Balzac tornò dall’Italia con un vivo culto per Dante, del cui poema a Roma il duca Michelangelo Caetani gli aveva svelato la formidabile intelaiatura (Vedi nella prefazione del Balzac ai due volumi – I parenti Poveri: Cugina Betta e Cugino Pons). [N. d. A.].
[11] Cfr. 1910.
Marco Stupazzoni














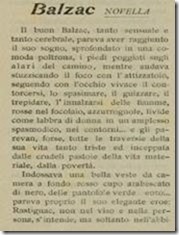

Nessun commento:
Posta un commento