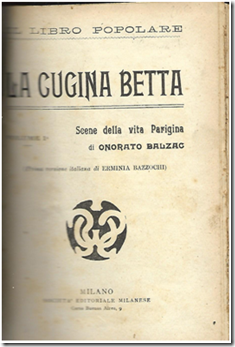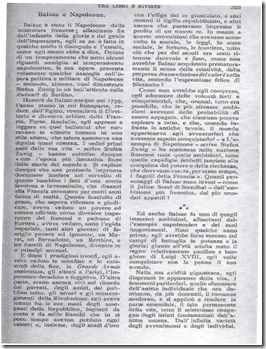1908
Traduzioni.
O. Balzac, I Capricci di Claudina con un giudizio sull’autore di Vittor Hugo, Napoli, Società Editrice Partenopea (Tipografia Giuseppe Canone), 1908 («Libro economico», 17), pp. 115.
Struttura dell’opera:
Onorato di Balzac, pp. 3-4;
I Capricci di Claudina, pp. 5-58;
Il Capolavoro Sconosciuto, Ibid., pp. 59-102;
In riva al mare, Ibid., pp. 103-115.
Con il titolo di: I Capricci di Claudina, è pubblicata la traduzione di Un prince de la bohème (prima edizione in volume messa in vendita nell’ottobre 1844 dall’editore de Potter): questo romanzo balzachiano, ebbe, come primo titolo, Les Fantaisies de Claudine e vide per la prima volta la luce nella «Revue Parisienne» del 25 agosto 1840.
Questa traduzione, anonima, dell’opera balzachiana pare fondarsi non sul testo dell’edizione definitiva Furne (1846), ma su un’edizione precedente[1]. Il testo è, infatti, suddiviso in due parti (La Bohème di Parigi; La famiglia di Claudine) che Balzac sopprimerà, insieme ai numerosi capitoli e sotto-capitoli di cui era costellato il testo dell’edizione originale del 1844, proprio nell’edizione Furne.
Nel complesso abbastanza corretta, questa versione italiana di Les Caprices de Claudine presenta alcuni difetti che si riferiscono tanto all’omissione di alcune sequenze testuali del modello originale quanto alla presenza di sviste, di errori di trascrizione, di interpretazioni piuttosto discutibili del testo francese nonché alla inopportuna intromissione del compilatore con interventi del tutto arbitrarî e fuori luogo:
p. 807[2]. Enfin vous et la marquise de Rochefide […] Allez! …j’écoute, non è tradotto. [Il corsivo è nostro].
p. 810. Mlle Laguerre […] une Capponi […].
p. 9. Madamigella Laguerra […] Copponi […].
p. 811. Cela n’existe pas […] Godin! Non è tradotto.
p. 812. […] le danger de ces fréquentations d’abord pleines de rêveries […].
p. 14. […] il pericolo di tali frequentazioni, che si annunziano piene di dolci incanti, di soavissimi sogni […].
p. 816. […] vous avez l’indélicatesse de me retenir une brosse à dents […].
p. 19. […] avete l’indelicatezza di ritenervi la mia spazzola da denti […].
Il Capolavoro Sconosciuto.
È riproposta, con qualche variante formale, la traduzione del racconto filosofico balzachiano pubblicata a Torino nel 1853 (e successivamente: Napoli, 1859, 1894 e 1899). Anche in questo testo, ritroviamo lo stesso grossolano errore di datazione cronologica presente all’inizio dell’opera: 1712 (sic) in luogo di 1612. È riportata la dedica ‘A un Lord’.
In riva al mare.
Siamo di fronte ad una versione alquanto ridotta e fortemente mutilata in molte (e diffuse) sue parti di Un drame au bord de la mer. Modello della traduzione di questo ‘estratto, è, per quanto ci è dato di capire, il testo dell’edizione Furne del 1846. Non è tradotta la dedica del racconto a ‘Madame la Princesse Caroline Gallitzin de Genthod’.
Onorato di Balzac, I Celibi II. Casa di Scapolo di Onorato di Balzac, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1908 («Biblioteca Amena», N. 738), pp. 287.
Nel complesso fedele e corretta, questa nuova traduzione italiana de La Rabouilleuse si fonda sul testo dell’edizione definitiva Furne pubblicata nel 1843. Non è presente la dedica a Charles Nodier.
Onorato di Balzac, I Parenti poveri. I. La cugina Betta di Onorato di Balzac. Traduzione di Galeazzo Falconi, con prefazione, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1908 («Biblioteca Amena», N. 744), pp. VIII-404.
Struttura dell’opera:
Prefazione del traduttore. Al Prof. Ugo Brilli (1908), pp. VII-VIII;
Prefazione dell’autore. A Don Michelangelo Caetani. Principe di Teano, pp. V-VI;
La cugina Betta, pp. 1-402;
Indice, pp. 403-404.
Questa traduzione, anonima, de La Cousine Bette presenta un impianto testuale strutturato in 38 capitoli secondo il modello dell’edizione del romanzo pubblicata ne «Le Constitutionnel» (8 ottobre-3 dicembre 1846). Tuttavia, in base all’esame delle varianti, il modello testuale di riferimento assunto dal compilatore è quello dell’edizione Furne (1848). La traduzione può considerarsi fedele e corretta e ci pare essere più aderente al costrutto francese rispetto a quella fornita da Erminia Bazzochi per i tipi della Società Editoriale Milanese (cfr. scheda successiva).
Onorato Balzac, La Cugina Betta. Scene della vita parigina di Onorato Balzac. (Prima versione italiana di Erminia Bazzochi), Milano, Società Editoriale Milanese (Stab. Tip. Lit. Romeo Longatti – Como; Tip. “Virgilio” - Milano), 1908 («Il Libro popolare», 13-14), Voll. I e II, pp. 302.
Nel complesso sufficientemente corretta, questa traduzione italiana de La Cousine Bette curata da Erminia Bazzochi si fonda sul testo dell’edizione Furne pubblicata nel 1846. Segnaliamo, tuttavia, alcuni grossolani errori di trascrizione e di interpretazione rispetto al modello francese in cui è incorsa la compilatrice:
p. 56 (Cfr. La Cousine Bette. Introduction de Anne-Marie Meininger, in La Comédie humaine … cit., Paris, ‘Nouvelle Pléiade’, t. VII, 1977).
Le capitaine remit son gant jaune […]. [Il corsivo è nostro].
p. 6. Il capitano calzò il guanto […].
p. 57. La mise de cette cousine eût au besoin expliqué ce sans-gêne.
p. 8. L’abbigliamento di questa cugina merita di essere descritto.
p. 60. […] il redoit deux cent soixante mille francs. […] je donne à ma fille une vingtaine de mille francs […].
p. 12. […] egli perde dunque centosessanta mila franchi … […] io devo dare a mia figlia un centinaio di mille franchi […].
p. 62. Presque tous les hommes affectionnent une posture […].
p. 15. Ogni uomo ha una postura […].
p. 65. […] de me prêcher le saint-simonisme en fait de femmes […].
p. 19. […] mi predicava il senza-rimorsi in fatto di donne […].
p. 73. «Est-ce au milieu de pareilles guenilles que devrait vivre la belle Mme Hulot?» dit-il.
p. 30. – E’ in mezzo a simili stracci che dovrebbe vivere la signora Hulot? – diss’egli.
Onorato Balzac, I Parenti Poveri. Il Cugino Pons. Scene della vita parigina di Onorato Balzac (Prima versione italiana di Erminia Bazzochi), Milano, Società Editoriale Milanese (Stab. Cromo-Tipogr. Pagani e C.), s. d. [1908] («Il Libro Popolare. La Biblioteca per tutti», 23-24), Voll. I e II, pp. 259; 250.
La traduzione si fonda sul testo dell’edizione Furne (1848) e ci pare lungi dal poter essere considerata esemplare per quel che riguarda la fedeltà al modello balzachiano sotto il profilo linguistico e stilistico. A questo proposito, forniamo alcuni esempî tratti dalle prime pagine del romanzo:
p. 483 (Cfr. Le Cousin Pons. Introduction d’André Lorant, in La Comédie humaine … cit., t. VI, 1977).
Vers trois heures de l’après-midi, dans le mois d’octobre de l’année 1844 […]. [Il corsivo è nostro].
p. 5. Verso le tre ore del pomeriggio, d’un giorno d’ottobre dell’anno 1844 […].
Ibid. […] exigent de hautes curiosités vivantes.
Ibid. […] esige delle vere curiosità, dei veri fenomeni viventi.
Ibid. […] et la raison du sourire qui se répétait come un écho dans tous les yeux.
p. 6. […] e la ragione del suo sorriso, che si riflettono come un’eco nei suoi occhi.
p. 484. Pour les observateurs […] précieuses, non è tradotto.
Ibid. […] mais il ne symbolisait l’Empire que pour ceux à qui cette magnifique et grandiose époque est connue, au moins de visu […].
p. 8. […] ma egli non simboleggiava l’Impero che per quanto di quest’epoca magnifica e grandiosa è conosciuto, almeno di vista …
p. 485. […] et semblait être attaqué de la lèpre, en dépit de la main qui le passait tous les matins.
p. 8. […] e sembrava attaccato dalla lebbra, o spellato dalla mano che tutte le mattine lo ripassava.
Ibid. […] ne pouvoir plaire.
p. 9. […] non poter piacere! non poter essere piacevoli! …
Onorato di Balzac, I Parenti Poveri II. Il Cugino Pons di Onorato di Balzac. Traduzione di Galeazzo Falconi, Milano, Fratelli Treves, Editori (Tip. Treves), 1908 («Biblioteca Amena», N. 745), pp. 311.
Come nel caso della traduzione de La Cousine Bette (cfr. supra), anche per quel che riguarda questa versione in lingua italiana del Cousin Pons curata da Galeazzo Falconi, l’opera è suddivisa in capitoli (trentuno) secondo il modello dell’edizione pre-originale del romanzo pubblicata ne «Le Constitutionnel» (marzo-maggio 1847). Al contrario, il testo della traduzione, che risulta, nel complesso, corretta, si fonda su quello dell’edizione definitiva Furne del 1848, nella quale Balzac soppresse ogni suddivisione in capitoli.
Alle pp. [I-III], è presente un saggio introduttivo: Balzac, a firma E. F., che trascriveremo integralmente all’interno della sezione dedicata agli studî e ai riferimenti critici.
O. di Balzac, Fisiologia del matrimonio o meditazioni di filosofia eclettica sulla felicità e la infelicità coniugale di O. Di Balzac, Milano, Società Editrice Sonzogno, 1908 («Biblioteca Universale», N° 64-65), pp. 268.
Struttura dell’opera:
E. F., Balzac, pp. 3-4;
Fisiologia del matrimonio, pp. 5-265;
Indice, pp. 267-268.
Cfr. 1883; 1885; 1888; 1890; 1892; 1897; 1902.
Onorato di Balzac, Mercadet l’affarista. Commedia in cinque atti. Il Lutto. Commedia in un atto di Onorato di Balzac, Milano, Società Editrice Sonzogno (Stab. della Società Editrice Sonzogno), 1908 («Biblioteca Amena», N. 13), pp. 91.
Struttura dell’opera:
Balzac, pp. 3-6;
Mercadet l’affarista, pp. 8-73;
Il Lutto, pp. 79-91.
Cfr. 1882; 1904.
Studî e riferimenti critici.
Onorato di Balzac, in O. Balzac, I Capricci di Claudina… cit., Napoli, Società editrice partenopea, 1908, pp. 3-4.
Onorato di Balzac nacque a Tours, nel 1799 e morì a Parigi il 19 (sic) agosto 1850. La vita del più grande e del più potente romanziere contemporaneo è essa stessa un romanzo. Al collegio di Vendôme, dove fece i suoi studii, lo si teneva in conto di scolare svogliato. Per la grande ambizione, che lo tormentava, scrisse giovanissimo, in un delirio febbrile, romanzi pei gabinetti di lettura, romanzi oggi completamente dimenticati e che egli firmava Orazio di Saint-Aubin, Viellerglé, Tom Rhoone (sic). Poi fece l’editore, lo stampatore. Sognò grandi intraprese industriali e finanziarie, che lo rovinarono. In seguito dovette trascorrere il resto della sua vita a scrivere per pagare i debiti contratti, e che non gli lasciarono un momento di pace. Lo si è perciò paragonato ad Onfale filando ai piedi dei suoi creditori. Il disgraziato grand’uomo dovette rappresentare parecchie volte la commedia di Mercadet prima di scriverla. Di danari non ne aveva mai abbastanza. I debiti, accresciuti dagl’interessi, aumentavano sempre. Fino all’ultimo la sua vita fu precaria. Sempre assediato dai creditori e con l’animo in trambusto, fece prodigi di lavoro. Si alzava a mezzanotte, beveva del caffè e lavorare dodici ore di fila, senza riposarsi un minuto!
Solo Vittor Hugo ha saputo caratterizzare il genio di Balzac, nel discorso che pronunziò sulla sua tomba, il 22 agosto 1850:
«Signori, il nome di Balzac sarà il faro della traccia luminosa che la nostra epoca lascerà nell’avvenire. Balzac era il primo fra i grandi, il più in alto fra i migliori. Tutti i suoi libri non formano che un sol libro; libro vivente, luminoso, profondo, dove si vede andare e venire, e camminare, e muoversi, con un non so che di agitato e di terribile, confuso al sogno, tutta la nostra civiltà contemporanea; libro meraviglioso che il poeta ha intitolato Commedia e che avrebbe potuto intitolare Storia, che assume tutte le forme e tutti gli stili, che sorpassa Tacito e va fino a Svetonio, che traversa Beaumarchais e va fino a Rabelais; libro che è l’osservazione e l’immaginazione; che prodiga il vero, l’intimo, il borghese, il triviale, il materiale, e che, a volte, fra tutte le realtà bruscamente e largamente strappate, lascia d’un tratto intravedere il più oscuro ed il più tragico ideale. A sua insaputa, volente o nolente, consenziente o non, l’autore di quest’opera immensa e strana appartiene alla forte razza degli scrittori rivoluzionarî».
Accanto alla Commedia Umana, che è un’immensa foresta d’alberi giganteschi, Balzac ha fatto germogliare nello stesso terreno d’osservazione della vita reale racconti meno estesi, che sono fiori rari e sontuosi, come quelli che qui pubblichiamo. [cfr. supra].
Bibliografia, “Chateaubriand, Victor Ugo (sic), H. de Balzac”. – Paris-Lyon, Vitte, 1907, 8°, 364 p. Fr. 3,50, «La Civiltà Cattolica», Roma, Anno 59°, Vol. I, 1908, p. 722.
Sono studi biografici e critici su tre grandi scrittori della Francia moderna. Lo Chateaubriand, Vittor Hugo e il Balzac chi non li conosce? Ma appunto perché variamente e universalmente discussi, non sarà mai fuor di luogo una raccolta di notizie e di giudizii sicuri sul loro conto, sul valore letterario, storico e filosofico. Tanto più che la loro vita e le loro opere così complesse offrono materia sempre nuova alla ricerca, e si vede nelle questioni qui trattate, non tutte ugualmente importanti e originali, ma utili sempre a farci conoscere meglio l’anima, l’indole, il pensiero di ciascuno, e a farcene discernere con retti criteri il prezioso dal vile. Si leggano ad es. i capitoli: «La sincèrité (sic) religieuse de Chateaubriand» ovvero «l’enfance de Victor Hugo» oppure «les prêtres dans les romans de Balzac». Non è poi da omettere il merito di una nitida edizione che rivela il buon gusto della casa editrice.
Maurizio Donnay all’Accademia, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXIII – Della Raccolta CCVII, Fascicolo 865, 1° gennaio 1908, pp. 140-146.
p. 145. [Su un giudizio di Paul Bourget].
Condamnons la littérature à thèse, genre essentiellement faux, distinguons-en la littérature à idées, genre légitime, genre nécessaire. Si nos romans et nos drames n’y aboutissent pas, nous ne serions que de amuseurs. Balzac, qui professait et pratiquait le culte passionné de la littérature à idées, a eu un mot terrible de dédain pour les conteurs sans philosophie. «Ils me font l’effet, disait-il, de l’homme le plus courageux signalé par Frédéric II après la bataille, ce (sic) trompette qui n’avait pas cessé de souffler le même air dans son petit turlututu». Vous n’avez pas eu, monsieur, comme l’auteur de la Comédie humaine, l’ambition d’être un docteur ès sciences sociales. Vous avez eu celle, après nous avoir follement amusés et délicieusement attendris, de nous faire un peu penser.
Notizie. Balzac e la monarchia, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 2, 12 Gennaio 1908, p. 6.
Negli anni che seguirono la morte di Balzac non si volle prendere sul serio il suo amore per la Monarchia e per il Cattolicismo, benché nella prefazione generale della Commedia Umana egli avesse proclamato: «Scrivo alla luce di due verità eterne: la Religione e la Monarchia». Si attribuirono ad amicizie femminili certe sue professioni di fede; ma invece Balzac fu monarchico e, naturalmente, cattolico per lunghe tradizioni familiari e per propria educazione, come oggi ricorda Félicien Pascal nel Figaro Littéraire[3]. Il padre di Balzac, benché dissimulasse un po’ le sue credenze, era amico di Bertrand de Malléville, ministro della marina sotto Luigi XVI, e Balzac fu educato nella pensione Lepitre, dopo sei anni passati presso gli Oratoriani a Pontevoy. Si conoscono i grandi servigi che il Lepitre rese alla monarchia e con quanto fanatismo fu legato ai Borboni. Barbey d’Aurevilly aveva ragione di salutare in Balzac morto, un cattolico ed un realista.
Silvio Benco alla Minerva, «Il Piccolo», Trieste, Anno XVII, N. 9504, 22 Gennaio 1908, pp. II-III.
In pieno romanticismo, Balzac vede il mondo con tutt’altri occhi che gli artisti suoi contemporanei. Si direbbe che egli comprenda la portata recondita della rivoluzione del 1830; l’avvento di una generazione di grandi banchieri, di grandi maneggiatori del denaro, di grandi speculatori; la generazione rappresentata da un Governo che getterà al paese un programma contenuto in una parola sola: Arricchitevi! – La formazione e l’evoluzione di questa società furono tutte nella mente di Balzac: anzi furono la sua vita. Amò il denaro anche lui, non platonicamente ma infelicemente. Le sue speculazioni andarono male; la sua prodigalità toccò all’insensatezza; lo scrittore si coperse di debiti; la sua vita divenne un dramma di contabilità. Allora si condannò al lavoro immane, che incominciava alla mezzanotte per finire talvolta al crepuscolo della sera successiva; voleva – si narrò – saldare con le proprie fatiche i suoi creditori e poi sposare la sua lontana amica, la signora de Hanska. La fatica erculea dello scrittore durò quindici anni; pochi mesi dopo le nozze egli era morto. Così la biografia romantica di Balzac. La biografia moderna narra le cose altrimenti: scoraggiato di venir a capo dei suoi debiti col proprio lavoro, avrebbe sposato la signora de Hanska per rimediare alla propria situazione finanziaria; abbandonato e tradito di lei all’indomani delle nozze, sarebbe morto in un’angoscia atroce, lasciando sei milioni di debiti. La leggenda romantica era più bella; era bella come un mito. Comunque, Balzac, vissuto negli affanni, e sempre per motivi di denaro, fu così tribolato, così accerchiato, così prigioniero della realtà della vita, che il suo cervello enorme dovette a viva forza rispecchiare cotesta realtà.
Egli non aveva programmi letterari; faceva il vero per un istinto; perché il vero preoccupava assiduo, con ogni sua forza, la fantasia dell’infaticabile scrittore di romanzi. I programmi letterari, le teorie, le conversazioni estetiche, i bei ragionari sull’arte di scrivere e su ciò che doveva essere scritto, furono invece molto amati dall’uomo che per un momento parve il successore letterario di Balzac: da Flaubert. [...]
Per
Balzac la verità è un istinto; per Flaubert è una finitezza; per Zola è
condizione di vita o di morte.
L’avvocato Bono alle Assise di Torino, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 38, 7 Febbraio 1908, p. 6.
Bracale P. C. fa istanza perché il presidente d’ufficio richieda il testamento del colonnello Bondi. Egli ricorda Balzac e una voce dice: – Si citi Balzac.
Idee sociali di Balzac, «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XVIII, Vol. XXVIII, N. 11, 23 febbraio 1908, p. 272.
Balzac fu uno di quegl’intelletti d’artista dalle varie concezioni. Non gli sfuggiva nessun dettaglio che valesse a dar vita ai suoi personaggi e si compiaceva anche d’intessere nella tela dei suoi romanzi teorie fantastiche.
Nel notomizzare le passioni umane e nel descrivere almeno una ventina di tipi di donne, tutti diversi e pieni di realtà, trovò il modo di esporre certe sue idee sulla proprietà, sull’economia sociale, sul matrimonio.
Le idee del grande scrittore non peccano davvero di rivoluzionarismo: è anzi difficile che, anche ai suoi tempi, ci fosse qualcuno più retrogrado di lui.
Faguet, nella Revue di Parigi, ricorda come egli abborrisse i contadini per le loro abitudini di grettezza e di risparmio, e specialmente le «calze di lana», in cui essi solevano conservare i frutti del loro lavoro e delle loro economie, nella lunghissima attesa di diventare proprietari, lasciando sempre infruttifero il danaro raccolto.
Nemico della piccola proprietà, Balzac predicava – in questo, socialista senza saperlo – la nazionalizzazione della terra. Ma era tutt’altro che un socialista! Stava per l’autorità costituita, preferibilmente monarchica. Intimamente aristocratico, sosteneva i diritti della primogenitura che impediva il frazionamento delle grandi proprietà. Ebbe a scrivere che le classi operaie sono appena un poco più progredite dei popoli barbari.
Non c’è dunque da sorprendersi di quello che Balzac pensava della donna e del matrimonio. La donna doveva restare, secondo lui, una specie di guardiana del focolare domestico, qualcosa di mezzo tra una schiava e una dea, ma una dea incatenata all’altare del suo culto.
Malgrado la pratica conoscenza di cui Balzac ha dato prova a proposito degl’incidenti relativi alla vita matrimoniale, è sempre rimasto un sostenitore intransigente dell’indissolubilità del matrimonio, nell’interesse dei figli, e per l’intangibilità dell’istituzione della famiglia, in qualsiasi evenienza. Egli scrisse che l’indissolubilità del matrimonio è indispensabile alla vita della società europea, e che l’instabilità degli affetti è ragion d’essere del matrimonio, il quale rappresenta una salvaguardia e una garanzia contro i capricci della passione.
Cronaca, «La Cultura», Roma, Anno XXVII, Serie Terza, n. 7, 1 Aprile 1908, p. 231.
Additiamo agli studiosi e ammiratori di Balzac due volumetti pubblicati dall’editore Sansot di Parigi: H. de Balzac, La Femme et l’Amour, pensées et observations recueillies et précédées d’une introduction par Jules Bertaut (più che la donna, ne sono oggetto le donne nella innumerevole varietà della realtà magistralmente osservata); e Jules Bertaut, Balzac anecdotique. Tutti sanno che bizzarro uomo fosse il gran romanziere; tutti possono quindi immaginare le curiosità accolte in questo volumetto.
Giornali e Riviste. Due voti per l’immortalità di Balzac, «L’Italiano. Gazzetta del Popolo», Torino, Anno 61°, N. 132, 13 maggio 1908, p. 3.
È generalmente noto come Balzac cercasse invano di far riuscire la sua candidatura all’Accademia di Francia. Egli, fra gli altri tentativi, cercò anche, secondo narra la «Revue Hebdomadaire», di officiare Victor Hugo a questo fine.
Il grande poeta discendeva in vettura la rue Saint-Honoré, quando Balzac, scorgendolosi precipita alla portiera esclamando:
— Maestro, venivo a farvi una visita.
— Vi porto in vettura, salite — aggiunge Hugo.
— Venivo appunto per farmi portare in un posto da voi.
— Dove?
— All’Accademia. Posso contare sul vostro voto?
— Ma certo! L’avrete.
Victor Hugo arriva alla seduta mentre si discuteva la candidatura di Vatont (sic). L’accademico Pongerville era accanto a Hugo e stava scrivendo il nome di Vatont sulla sua scheda.
— Vi prego — gli mormora Victor Hugo nell’orecchio — scrivete «Balzac».
E Pongerville prende un’altra scheda e scrive «Balzac»; ma poi, sul punto dii votare esita, una scheda in una mano ed una nell’altra: Balzac o Vatont? E non sa risolversi.
Allora Victor Hugo dà un colpetto sulla mano che teneva il nome di Vatont e la scheda cade a terra; così che Pongerville per non chinarsi a raccattarla si decide di mettere il nome di Balzac nell’urna.
Ed ecco come l’autore della «Commedia Umana» ebbe due voti per l’immortalità. E nonostante i continui sforzi Balzac non potè mai riuscire a far parte dell’Accademia francese, come Emilio Zola e molti altri veri immortali.
Notizie d’Arte. Lirica, «La Stampa. Gazzetta Piemontese», Torino, Anno XLII, Num. 137, 18 Maggio 1908, p. 3.
All’Opéra di Nizza è stato rappresentato per la prima volta un dramma lirico in un atto: La Marana, di cui la musica è dovuta ad un giovane ed esordiente compositore: Florencio Odero. Il libretto è tolto da una novella di Balzac. […].
Marginalia. La casa di Balzac, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 21, 24 Maggio 1908, p. 5.
Tutti i giornali francesi parlano d’una cerimonia che ha avuto luogo l’altro giorno in una piccola casa di Passy dove Balzac abitò per alcuni anni, dal 1841 al 1848. Più che una cerimonia, è stata una visita d’amore durante la quale un centinaio di ammiratrici e di studiosi del grande romanziere poteron rievocare la figura e l’opera di lui lontano dal tumulto di Parigi, nel calmo cerchio delle mura capitali che custodirono in un relativo silenzio il suo lavoro affannoso. La casa di Balzac a Passy è un po’ strana; bisogna accedervi per un’altra casa. Dal giardino, un piccolo giardino rettangolare, con alcuni alberi e molti fiori si può scorgere un palazzo storico, quello che abitò la signora di Lamballe. Balzac lavorava in una camera la cui finestra s’apriva sul giardino, come la porta; in una di quelle camere vaste e vuote dove ora si pensa di porre un museo a lui dedicato e dove già posson fare bella mostra una riproduzione del busto di David d’Angers e una riduzione della grande statua di Rodin. Fino ad oggi la casa era appartenuta ad una signora Barbier, che può fortunatamente raccontare ancora qualche aneddoto sullo scrittore che, bambina, la faceva saltare sulle sue ginocchia e la colmava di carezze. La signora Barbier ha ottantadue anni, ma la cerimonia dell’altro giorno l’ha fatta ringiovanire! Con sua madre ella preservava Balzac dalle visite importune … soprattutto dai creditori; lo aiutava a sfuggirli, nascondendosi. Quando qualcuno batteva alla porta la madre e la figlia andavano ad avvertire lo scrittore e appena il creditore si era … dichiarato, Balzac usciva di casa per una porta segreta che dà su un’altra strada, lasciando interrotta la pagina cui attendeva febbrilmente e che doveva permettergli forse di pagare il debito.
Ma i creditori fecero presto a scoprire la seconda uscita e guai se il povero grande uomo con l’aiuto delle signore Barbier non si fosse affrettato a trovarne un’altra che immetteva nel giardino e dal giardino lasciare libero l’adito sulla via. Quando i creditori infiniti lo lasciavano tranquillo – ha raccontato la superstite signora Barbier – Balzac lavorava fino alle cinque tutti i giorni; poi usciva per andare a consegnare all’editore i suoi manoscritti e le sue bozze. Rincasava dopo quella che egli era solito chiamare la sua passeggiata igienica, desinava, si coricava per alcune ore e poi si rialzava per lavorare durante la notte, fino al mattino. Balzac non s’occupava di nulla; fuorchè di scrivere e la sua governante doveva aver per lui tutte le cure possibili ed imaginabili. V’era però una cosa di cui Balzac s’occupava, anzi, si preoccupava: il caffè. Aveva dato alla signora Barbier l’indirizzo di tre negozianti che vendevano il caffè che a lui piaceva ed egli stesso mescolava minuziosamente il contenuto dei tre pacchetti quando gli venivano consegnati … Quanto tempo è passato da allora! Ormai dalla casa di Balzac è svanito per sempre anche il profumo di questo caffè che fu necessario … per non dormire!
Riviste e giornali, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 144, 25 Maggio 1908, p. 2.
E’ ancora circondata dalla curiosità degli ammiratori la casa di Balzac a Passy – una piccola casa ch’egli abitò dal 19841 al 1848 e che è appartenuta sinora a una signora Barbier, la quale si ricorda di quando, bambina, il grande scrittore la faceva saltare sulle sue ginocchia ed ella e sua madre lo proteggevano dalla folla dei creditori. Quando si udiva picchiare alla porta, la madre o la figlia avvertivano immediatamente lo scrittore: se si trattava veramente d’un creditore, Balzac se ne usciva di casa per una porta segreta che dà su un’altra strada. Ma i creditori vennero a conoscenza di quella uscita di soccorso, e lo scampo divenne più difficile. Fortunatamente la signora Barbier gliene trovò un’altra, che dava in giardino e dal giardino si poteva arrivare in istrada. Quando i creditori lo lasciavano un po’ tranquillo, Balzac – leggiamo nel Marzocco [cfr. supra] – lavorava tutti i giorni fino alle cinque del pomeriggio; poi usciva, faceva una passeggiata, rincasava, pranzava e si coricava, per alzarsi in piena notte e rimettersi a lavorare fino alla mattina. Egli non s’occupava di nulla e la sua governante doveva pensare a tutto, come se si fosse trattato d’un bambino. D’una sola cosa si preoccupava e curava personalmente – del caffè. Egli aveva dato alla signora Barbier l’indirizzo di tre negozianti che vendevano il caffè da lui preferito: mandava a prenderne un pacchetto da ciascuno e li mescolava egli stesso accuratamente per averne l’ideale sinfonia aromatica.
Notiziario. Letteratura, «Rassegna Contemporanea», Roma, Anno I, Fasc. 6, Giugno 1908, pp. 674-677.
p. 677. Una visita d’amore, più che una cerimonia, è stata quella che un centinaio di ammiratori e di studiosi di Balzac hanno fatta di recente ad una piccola casa di Passy, dove il grande romanziere abitò per alcuni anni dal 1841 al 1848. In una di quelle camere vaste e vuote si pensa ora di porre un museo balzachiano; e già vi figurano una riproduzione del busto di David D’Angers ed una riduzione della grande statua di Rodin. La casa appartiene alla signora Barbier, la quale conobbe lo scrittore quand’era bambina ed ha ancora la fortuna di poterne raccontare molti aneddoti curiosi.
Il giro del mondo in un mese. Maggio, «Ars et Labor. Musica e Musicisti», Milano, Anno 63, Vol. I, 15 Giugno 1908, pp. 512-515.
p. 513. A Passy viene inaugurato il Museo Balzac. La sede del Museo è nella casa abitata dall'autore della Commedia umana nel periodo più turbato della sua vita. Assiste alla cerimonia la nipote di Balzac, signora Viold, e la proprietaria della casa, che aveva ospitato l’illustre scrittore. Nel Museo vi è tra l’altro un’opera di Rodin.
Giornali e Riviste. Come Balzac eludeva i creditori, «L’Italiano. Gazzetta del Popolo», Torino, Anno 61°, N. 167, 17 giugno 1908, p. 3.
Alcuni giorni or sono una piccola casi di Passy, dove il grande romani; ere abito per alcuni anni dal 1841 al 1848, fu meta di una visita d’amore durante la quale un centinaio di ammiratori e di studiosi di Balzac poterono, come si esprime il «Marzocco», rievocare la figura e l’opera di lui lontano dal tumulto di Parigi, nel calmo cerchio delle mura ospitali che custodirono in un relativo silenzio il suo lavoro affannoso.
La casa di. Balzac a Passy e un po’ strana; bisogna accedervi per un’altra casa. Dal giardino, piccolo e rettangolare con alcuni alberi e molti fiori, si può scorgere un palazzo storico, quello che abitò la signora di Lamballe. Balzac lavorava in una camera la cui finestra s’apriva sul giardino, come la porta, e dove ora si pensa di porre un museo a lui dedicato e dove già posson fare bella mostra una riproduzione del busto di David d’Angers e una riduzione della grande statua di Rodin. Fino ad oggi la casa era appartenuta ad una signora Barbier, che può fortunatamente raccontare ancora qualche aneddoto sullo scrittore, il quale la faceva saltare bambina sulle sue ginocchia e la colmava di carezze. La signora Barbier ha ora ottantadue anni e ha ricordato come con sua madre preservasse Balzac dalle visite importune, sopratutto dei creditori; anzi le due donne si divertivano un mondo ad aiutarlo ad eluderli.
Quando, qualcuno batteva alla porta la madre e la figlia andavano ad avvertire lo scrittore ed appena il creditore si era dichiarato Balzac usciva di casa per una porta segreta che dava su un’altra strada, lasciando interrotta la pagina cui attendeva febbrilmente.
Ma i creditori ben presto scopersero il giuoco e piantonarono la porta d’uscita, ma il povero grande uomo coll’aiuto delle signore Barbier ne uso un’altra che metteva nel giardino e dal giardino sulla via.
Quando i creditori infiniti lo lasciavano tranquillo Balzac lavorava tutti i giorni fino alle cinque, poi usciva per andar a consegnare all’editore i suoi manoscritti e le sue bozze. Rincasava dopo quella, ch’egli chiamava sua passeggiata igienica, desinava, si coricava per alcune ore e poi si rialzava per lavorare tutta la notte fino al mattino.
Balzac non si occupava di nulla fuorchè di scrivere e la sua governante, doveva aver per lui tutte le cure possibili e indispensabili. V’era pero una cosa di cui Balzac si occupava, anzi si preoccupava: il caffè. Aveva dato alla signora Barbier l’indirizzo dei tre negozianti che vendevano il caffe che a lui piaceva ed egli stesso mescolava minutamente il contenuto dei tre pacchi subito quando gli venivano consegnati. Gli è che il caffe era necessario a Balzac per non dormire!
Marginalia. La gloria e l’appetito, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 23, 21 Giugno 1908, p. 3.
Teofilo Gautier diceva che gli scrittori debbono mangiare molto e infatti si può affermare con l’esempio suo e di molti suoi colleghi in letteratura che la gloria e l’appetito si sono sempre fatti ottima compagnia. Balzac faceva pranzi interminabili, da vero ghiottone qual era; […].
Asterischi e Parentesi, «Giornale di Udine», Udine, Anno XLII, N. 151, 26 Giugno 1908, p. 1.
— Balzac e i creditori.
Alcuni giorni or sono una piccola casa di Passy, dove il grande romanziere abitò per alcuni anni dal 1841 al 1848, fu meta di una visita d’amore durante la quale un centinaio di ammiratori e di studiosi di Balzac poterono, come si esprime il “Marzocco” rievocare la figura e l’opera di lui lontano dal tumulto di Parigi, nel calmo cerchio delle mura ospitali che custodirono in un relativo silenzio il suo lavoro affannoso.
La casa di Balzac a Passy è un po’ strana; bisogna accedervi per un’altra casa dal giardino, piccolo e rettangolare con alcuni alberi e molti fiori, si può scorgere un palazzo storico, quello che abitò la signora di Lamballe. Balzac lavorava in una camera la cui finestra si apriva sul giardino, come la porta, e dove ora si pensa di porre un museo a lui dedicato e dove già posson fare bella mostra una riproduzione del busto di David d’Angers e una riduzione della grande statua di Rodin. Fino ad oggi la casa era appartenuta ad una signora Barbier, che può fortunatamente raccontare ancora qualche aneddoto sullo scrittore, il quale la faceva saltare bambina sulle sue ginocchia e la colmava di carezze. La signora Barbier ha ora ottantadue anni e ha ricordato come con sua madre preservasse Balzac dalle visite importune, sopratutto dei creditori; anzi le due donne si divertivano un mondo ad aiutarlo ad eluderli.
Quando qualcuno batteva alla porta la madre e la figlia andavano ad avvertire lo scrittore ed appena il creditore si era dichiarato Balzac usciva di casa per una porta segreta che dava su un’altra strada, lasciando interrotta la pagina cui attendeva febbrilmente.
Ma i creditori ben presto scopersero il giuoco e piantonarono la porta d’uscita, ma il povero grande uomo coll’aiuto delle signore Barbier ne usò un’altra che metteva nel giardino e dal giardino sulla via.
Quando i creditori infiniti lo lasciavano tranquillo Balzac lavorava tutti i giorni fino alle cinque, poi usciva per andare a consegnare all’editore i suoi manoscritti e le sue bozze. Rincasava dopo quella che egli chiamava sua passeggiata igienica, desinava, si caricava per alcune ore e poi si rialzava per lavorare tutta la notte fino al mattino.
Balzac non si occupava di nulla fuorché di scrivere e la sua governante doveva aver per lui tutte le cure possibili e indispensabili. V’era però una cosa di cui Balzac si occupava, anzi si preoccupava: il caffè. Aveva dato alla signora Barbier l’indirizzo dei tre negozianti che vendevano il caffè che a lui piaceva ed egli stesso mescolava minutamente il contenuto dei tre pacchi subito quando gli venivano consegnati. Gli è che il caffè era necessario a Balzac per non dormire!
Marginalia. Il misticismo della voluttà in Balzac, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 29, 19 Luglio 1908, p. 3.
– Balzac ha non solo interpretato e rappresentato tutto quello che costituiva la sua epoca; ma in certe cose è stato assolutamente un precursore. Chi lo conosce bene nelle sue opere e sopratutto nei suoi «Studi filosofici» sa, per esempio, quante previsioni sulla subliminal life il grande romanziere abbia espresse o fatte in qualche modo comprendere. Egli è veramente il più grande agitatore d’idee del suo secolo; ma quel che lo fa superiore ad ogni altro è la filosofia che può trarsi dal suo culto della volontà. «La mia volontà, egli diceva, può veramente dirsi sorella della volontà di Napoleone». In Balzac la volontà appare come una forza agente il cui motore è la passione nella sua più vasta comprensione di affetti, di istinti, di desideri, di ideali. Balzac – afferma G. Pères (sic) nel Mercure de France[4] – ha messo in azione la verità apparsa allo Schopenhauer cui lo legano punti insospettati di somiglianza! Tra il pensatore pel quale tutta la volontà è forza e tutta la forza è volontà e lo scrittore la cui opera sintetizza tutte le manifestazioni della forza volontaria il paragone è infatti necessario … Per Balzac ogni essere deve agire in qualche modo, deve voler vincere il tempo e lo spazio e «distendervisi» colla dominazione, con l’azione, con la persecuzione; la volontà è la forza che regge la condotta esteriore ed interiore verso l’adempimento del proprio fine. I suoi personaggi rappresentano ciascuno un tipo di volontà e Balzac stesso, colui che «pareva creare il tempo», è la volontà personificata. Si comprende, quindi, come per un uomo simile dovesse aver dignità e culto la vita intima dello spirito e lo sforzo per far uscire l’uomo interiore dalla sua prigione di carne e di ossa, lo sforzo causato dalle circostanze contrarie, dai fatti avversi che respingono, diminuiscono, indeboliscono il volere. Ed ecco che Balzac è naturalmente portato a credere alla volontà come spirito personificato, e darle una realtà nel senso fisico della parola, a materializzarla e sensualizzarla. Per lui il culto della volontà è uno di quelli che hanno le loro mitologie e le loro esagerazioni e le loro superstizioni. Egli torna di frequente sull’ideale del magnetismo della volontà. Consulta uno stregone. Progetta di avere una sonnambula ai suoi servigi; s’incammina verso la patologia della volontà movendosi dalla certezza che ogni manifestazione superiore delle nostre doti è inseparabile da effetti fisici soprannaturali. Balzac, oltre a tutto, conosceva molto bene il galvanismo e sapeva di Swedenborg, di Mesmer, se non altro avendone subito l’influenza a traverso Maine de Biran. Anch’egli ha, si può dire, lavorato il pensiero, educando e coltivando la sua personalità stessa, non dimenticando sotto l’accumulazione enorme dei fatti della vita, i diritti del sogno e dell’ideale fino a diventare egli stesso «una potenza volontaria» e a venerare come un mistico la forza della volontà.
Cronaca, «La Cultura», Roma, Anno XXVII, Serie Terza, n. 16, 15 Agosto 1908, p. 527.
Mercure de France, 1.er juillet 1908: J. Pèrès, Le Mysticisme de la volonté
chez H. de Balzac. [La filosofia di Balzac, quale appare dall’intera opera
e dalla filosofia dell’uomo, è una dottrina della volontà, conformemente alle
tendenze volontariste del tempo, da Maine de Brian (sic) e Fichte a
Schopenhauer. La volontà appare presso B. sopratutto come forza d’agire mossa da
una passione, di qualunque genere essa sia. Il P. esamina le influenze che hanno
determinata questa concezione di Balzac).
Marginalia. Balzac contro Sainte-Beuve, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N.34, 23 Agosto 1908, p. 4.
Gli echi di certe polemiche letterarie che agitarono gli animi dei giganti della letteratura appassionano anche se vengono da molto lontano. Ma si può ripensare con indifferenza alla polemica che Balzac, ad esempio, ebbe col Sainte-Beuve dopo che questi ebbe pubblicato il suo formidabile Port-Royal? Balzac, nel 1840, aveva fondato la sua piccola Revue Parisienne di cui era il direttore e l’unico redattore e in cui si proponeva di dare «la cronaca reale degli affari pubblici, districandola dalle nuvole nelle quali l’avviluppa la fraseologia ipocrita dei dibattiti quotidiani» e voler restaurare la sincerità nella critica letteraria. Nella sua rivista il Balzac cominciò subito a correggere gli errori di grammatica e i non sensi di Victor Hugo, ma attaccò poi, nel secondo numero, appunto il Sainte-Beuve. «In un’epoca, in cui ogni spirito prende un atteggiamento vivo e deliberato e, per agire su i suoi contemporanei ogni autore drammatizza il suo soggetto e il suo stile; in cui si cerca di imitare l’azione vigorosa che Napoleone ha impresso al suo secolo, il signor Sainte-Beuve ha avuto l’idea pietrificante di rinnovare il genere noioso!» Ma questo è nulla. Ecco che Balzac paragona il Sainte-Beuve – ci ricorda un articolo del Figaro littéraire – ad uno di quei molluschi «che non hanno né sangue, né cuore, né vita violenta e il cui pensiero, se ne hanno uno, si nasconde in un involucro biancastro e molliccio». La noia che Sainte-Beuve procura cade sopra i cervelli come una pioggia e attrista le intelligenze sottoposte a quel «francese umidoso». Tagliando il primo volume di Port-Royal Balzac credeva di tagliare … della noia col coltello! È crudele! Il grande romanziere si scaglia pure contro il de Remusat che ha nominato il Sainte-Beuve conservatore alla Biblioteca Mazarino. Si affretta però a soggiungere che probabilmente il ministro avrà fatto una cosa spiritosa se il Sainte-Beuve, chiuso in biblioteca come un topo nel suo formaggio, prenderà la deliberazione di non scrivere più nulla. Balzac avrebbe scritto un ben diverso Port-Royal, un Port-Royal degno del secolo che aveva subito la scossa napoleonica. Egli vi avrebbe innanzi tutto messo in mostra la sua teoria: che due governi soltanto sono accettabili: la monarchia assoluta e la vera repubblica: o il popolo, o Dio. Balzac preferiva Dio; ma, in ogni modo, meglio la repubblica che «gli ignobili governi bastardi, senza azione, immorali, senza basi, senza principî, che scatenano tutte le passioni senza trar partito d’alcuna …» I signori di Port-Royal non avevano fatto altro, secondo Balzac, che rappresentare un simil genere di governi! E Sainte-Beuve non ha scritto certo un’opera napoleonica guardandoli con un microscopio e cadendo in errori madornali. Ecco Balzac alla ricerca degli sbagli di grammatica e di storia commessi dal gran critico e correre in armi contro la poesia e i pensieri di lui. Si trattava davvero di un odio implacabile. Sainte-Beuve, non era per Balzac come per la signora D’Abrantès che «Sainte-Bévue»! …
L’evoluzione dell’adulterio, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 233, 23 Agosto 1908, p. 3.
Se poi si volesse — vi sono dei lettori incontentabili — oltre alla constatazione di questa forma evolutiva dell’adulterio, anche la morale, la morale — ahimè! — non evolve ed è sempre quella vecchia, l’eterno tema sul quale Onorato di Balzac ha fatto delle notevoli variazioni: procurino i mariti di conoscere il gusto delle loro signore.
Coi tempi che corrono, una tale scienza gioverà almeno a ... guardarsi dai cani.
Punti, appunti e … puntini, «Corriere Meridionale», Lecce, Anno XIX, Numero 36, 24 Settembre 1908. p. 1.
I nostri scrittori.
Dal nostro concittadino Anton Menotti Buia ricevo un nuovo libretto. E’ un melodramma in quattro atti dal titolo Olga, tratto da un racconto del Balzac, ed è stato musicato dal maestro Edoardo Granelli.
Il melodramma non manca di interesse. E’ la storia triste d’un giovano artista che muore vittima dell’amore. Olga, una ballerina bellissima, la sirena che ha ammaliato col suo fascino possente Enrico, e poi, avida di lusso e di piaceri, lo ha abbandonato, cede al rimorso, e mentre passa il funebre corteo che accompagna Enrico al cimitero, si precipita dal balcone nella via. I versi sono di buona fattura e armoniosi; la sceneggiatura è abilmente condotta.
L’opera sarà data a Odessa nel prossimo inverno.
Augurii di lusinghiero successo all’autore del libretto ed al maestro.
Riviste e Giornali. La sociologia di Balzac, «Gazzetta di Venezia», Venezia, Anno CLXVI, N. 277, 6 Ottobre 1908, p. 2.
Il grande romanziere, nel descrivere realisticamente i suoi personaggi e nel combinar romanzescamente le avventure dei suoi romanzi, espose spesso le sue teorie sociali. E contrariamente alla veemenza rivoluzionaria del genio si può dire che al suo tempo non vi è un retrogrado più reazionario di lui.
Questo è il giudizio che ha espresso il Faguet nella Revue, ricordando come Balzac odiasse le abitudini di lenti risparmio dei contadini intesi a divenire da un giorno all’altro proprietari; poiché egli si diceva nemico della piccola proprietà e come tale predicava la nazionalizzazione della terra; senza pensare che il frazionamento della proprietà era un passo verso detta nazionalizzazione. E infatti poi egli sosteneva lo stretto principio aristocratico della primogenitura che impediva il frazionamento delle grandi proprietà.
Stava per l’autorità costituita preferibilmente monarchica; ed era tanto aristocratico da aggiungere al suo nome borghese la particella nobiliare: infatti formava sempre De Balzac! E poi metteva in ridicolo le manie nobiliari dei suoi personaggi borghesi.
Oh la logica di certi scrittori!
La passione del giuoco, «Il Paese. Giornale della democrazia friulana», Udine, Anno XIII, N. 269, 8 Ottobre 1908, pp. 1-2.
p. 2. I Borboni ritornati, mantennero l’appalto del gioco; ma Parigi e la Francia formicolarono di camerini da gioco indipendenti. Quelli del Palais Royal entrarono nella letteratura, per la porta immortale dell’opera balzacchiana. E’ in quell’inferno che Balzac mandava Rastignac a rifornirsi di denaro per soddisfare ai costosi capricci di Madama Nucingen.
Riviste e giornali, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 293, 21 Ottobre 1908, p. 3.
Le vittime delle gare elettorali, i candidati violentemente bocciati, gli uomini di buona volontà rimasti sempre con le loro speranze in aria e il loro nome in fondo all’urna, sono in buona compagnia, nella storia. Per non citarne molti altri, basta Balzac per tutti. Il glorioso autore della «Commedia umana» si presentò tre volte come candidato alla deputazione e tre volte fu atrocemente bocciato. La prima volta tentò la sorte in tre collegi. Sotto l’ispirazione della signora Carraud, egli, di tendenze monarchiche, liberaleggiava nel 1831. In un suo opuscolo d’allora, domandava tra l’altro la libertà della stampa, convinto che il giornale a un soldo sarebbe stato un gran segno di progresso. «Fate gridare — invocava — a un soldo per le vie di Parigi tutti i giorni, la pubblica opinione!» Domandava anche la separazione della Chiesa dallo Stato. Ma a Fougères, in Bretagna, la sua candidatura non fu neanche posta, poiché l’amico a cui si era rivolto lo assicurò della inevitabile disfatta. A Cambrai e ad Angoulême le cose andarono più oltre, ma non per ciò andarono meglio. Ad Angoulême il suo nome, non figurò neanche sul processo verbale dello scrutinio: a Cambrai ebbe meno di dieci voti! L’anno seguente nuovo tentativo. La sua ispiratrice era allora la duchessa di Castries, e il suo programma fu più rigorosamente monarchico. Si presentò a Chinon, nella Turenna. Il risultato fu: Girod, voti 260, eletto: Tasibereau, 90: dispersi 10. Del candidato Balzac non si fa il minimo cenno. Pareva che, dopo onesti saggi poco lusinghieri della sua popolarità, egli avesse rinunciato definitivamente a entrare in Parlamento: ma nel 1848, dopo la rivoluzione, si ripresentò nuovamente a Parigi con programma liberale, come le circostanze esigevano. E il 1 maggio 1848 il nome insigne di Onorato di Balzac — ricorda Jules Bertaut nella Revue du Mois — [cfr. Jules Bertaut, Balzac homme politique, «Revue du Mois», vol. VI, 10 Octobre 1908, pp. 440-456] non raccolse che poche centinaia di voti […]. Ma di questi scacchi gli ammiratori di Balzac non si dolgono: si deve a essi se la politica non deviò la prodigiosa attività del più grande romanziere del secolo XIX.
Marginalia. Balzac uomo politico, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 44, 1° Novembre 1908, p. 3.
Se la politica non ha avuto nella vita di Balzac la parte preponderante ch’ebbe in quella di Lamartine e di Victor Hugo, pure le ambizioni politiche di Balzac formano – secondo Jules Bertaut che ne parla nella Revue du Mois[5] – uno dei capitoli più piccanti della vita del gran romanziere. Piccanti perché Balzac non ha fatto, in questo campo, che cambiar d’idee a seconda del suo vantaggio e della sua speranza di riuscire. Nato da un padre aristocratico, se non realista, educato in una pensione che si modellava sulle idee dell’Antico Regime, Balzac fu dapprima naturalmente portato ad accettare le idee che avevano diretto la sua famiglia. Del resto, egli non ebbe, durante tutta la vita, l’opportunità e il tempo di studiar veramente e sul serio le condizioni sociali della Francia. Non era un osservatore, ma un veggente; creava i suoi personaggi più tosto che toglierli dalla vita. Così la prima volta che Balzac si portò candidato politico proclamò di militare nelle file degli aristocratici. Fu nel 1831. La signora Carraud alimentava in lui le velleità d’essere deputato. Balzac che era stato due anni a Fougères, ospite del barone di Pommerol (sic), pensò di porre la sua candidatura in questo collegio. Ne dette subito avviso al barone spedendogli quaranta copie d’un suo opuscolo «Inchiesta sulla politica di due ministeri», dove saltava di palo in frasca occupandosi di cose militari, di giornalismo e criticando le leggi elettorali. Troppe idee perché fossero veramente stabili! Gli fu risposto che il partito aveva già il suo candidato. Balzac sceglie allora i collegi di Cambrai ed Angoulême dove aveva degli amici e dei parenti … inalberando un programma liberale e dichiarando di voler la separazione del clero francese da Roma, la distruzione della aristocrazia etc. Fu battutissimo. Ad Angoulême ebbe dieci voti! Altri si sarebbero scoraggiati. Balzac no. Nel 1832 ripresenta la candidatura a Chinon, in piena Turenna, paese realista e la Quotidienne annuncia che il signor De Balzac «giovane scrittore pieno di ardore e di talento» vuol dedicarsi alla difesa dei principî su cui riposa la felicità della Francia … La verità era che Balzac s’era legato con una duchessa, la duchessa de Castries che lo guidava, come prima l’aveva guidato M.me Carraud! Ma alla vigilia di mettersi in viaggio per cominciare la sua campagna elettorale Balzac cadde da una vettura e si fece tanto male che dovette stare a letto per parecchi giorni. Così ancora una volta il grande scrittore non ebbe neppure la soddisfazione di vedersi nominato fra i candidati battuti. Questo non gli impedì di presentare ancora il suo nome alle elezioni del ’48. In quest’anno Balzac aveva 100 mila lire di debiti. Le cose andavano male per lui e per gli editori. Egli pensò bene di cambiar di partito e di entrare nella democrazia. Scrisse allora al «cittadino presidente del Club della fratellanza universale a Parigi» dichiarando di accettarne il mandato elettorale! Nessuno però s’accorse della sua dichiarazione nella tempesta rivoluzionaria che s’era scatenata; «Balzac … tornò alla letteratura»!
I doveri della Nobiltà. Ancora il Referendum del «Figaro», «Vita Umbra. Periodico settimanale», Perugia, Anno I, Num. 91, 21 Novembre 1908, p. 1.
[...] il conte Alberto De Mun, l’illustre leader dei cattolici francesi, ha inviato al giornale parigino un articolo di grande interesse.
In esso il De Mun ricorda le parole che
Balzac, il grande veggente sociale, ha scritto della nobiltà, la quale
«invece di gettare le insegne che davano ombra al popolo e di conservare la
forza, s’è lasciata sfuggire la forza stringendosi alle insegne
vane».
Marginalia. Balzac autore drammatico, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 49, 6 Dicembre 1908, p. 4.
Il teatro, pare impossibile, ha attirato sempre non solo i piccoli, ma anche i grandi autori, i dominatori del romanzo e insieme della società dalla quale traevano le loro favole verosimili. Fra questi grandi autori fu Balzac. Al «Teatro Sarah Bernhardt» giorni sono, si è data una rappresentazione di gala organizzata dal Comitato per la «Casa di Balzac» e lo spettacolo era interamente composto di frammenti d’opere drammatiche di Balzac o di adattazioni già rappresentate al teatro. Il teatro – scrive a questo proposito il Journal des Débats – fu sempre il sogno di Balzac. Fin dall’età di venti anni egli aveva scritto una tragedia su Cromwell. A trent’anni abbozzava un dramma storico: Maria Touchet. A quaranta, scrive Vautrin, Balzac voleva ad ogni costo riuscire nella carriera drammatica, che gli sembrava più produttiva di quella libraria. Ma il successo non venne. Ad ogni tentativo scenico, si rimandava l’autore ai suoi libri. Vautrin fu interdetto – senza che l’interdizione riuscisse a fargli avere più successo. – Le risorse di Quinola caddero all’Odéon; Mercadet fu rifiutato per dieci anni di seguito da tutti i teatri di Parigi; la Marâtre passò sotto silenzio, inavvertita, al Teatro Storico. Le speranze di Balzac andavano in fumo. Sopratutto non tornavano i conti del suo bilancio. Ma egli sperava sempre. Pochi mesi prima della sua morte scriveva ad un amico: «Potrò essere a Parigi nel prossimo febbraio con la ferma e necessaria voglia di lavorare come membro della Società degli autori drammatici …, ho trovato una piccola California da sfruttare. Pensa che una scena scritta ogni giorno fa trecentosessantacinque scene all’anno, cioè dieci lavori drammatici. Anche se cadono cinque, e tre non abbiano che un successo mediocre, ne rimangono sempre due; due successi che darebbero un bel risultato. Sì, coraggio, pur che la salute mi ritorni ed io m’imbarcherò arditamente sulla galera drammatica con dei buoni soggetti!»[6] Povero Balzac! Il suo talento teatrale doveva essere riconosciuto – e non troppo – soltanto dopo la sua morte.
Balzac e il teatro, «Il Teatro illustrato», Milano, Anno IV, N. 21-22, 15 Dicembre 1908, p. 15.
Al teatro Sarah Bernhardt giorni sono si è data una rappresentazione di gala organizzata dal Comitato per la «Casa di Balzac», e lo spettacolo era interamente composto di frammenti d’opere drammatiche di Balzac o di adattazioni già rappresentate a teatro. Il teatro – scrive a questo proposito il Journal des Débats – fu sempre il sogno di Balzac. Fin dall’età di vent’anni egli aveva scritto una tragedia su Cromwell. A trent’anni sbozzava un dramma storico: Maria Trouchet. A quaranta scrive Vautrin. Balzac voleva ad ogni costo riuscire nella carriera drammatica, che gli sembrava più produttiva di quella libraria. Ma il successo non venne. Ad ogni tentativo scenico si rimandava l’autore ai suoi libri. Vautrin fu interdetto; Le risorse di Quinola caddero all’Odéon; Mercadet fu rifiutato per dieci anni di seguito da tutti i teatri di Parigi; la Marâtre passò sotto silenzio, inavvertita, al teatro Storico. Ma egli sperava sempre. Pochi mesi prima della sua morte scriveva ad un amico: «Potrò essere a Parigi nel prossimo febbraio con la ferma e necessaria voglia di lavorare come membro della Società degli autori drammatici ... Ho trovato una piccola California teatrale da sfruttare. Pensa che una scena scritta ogni giorno fa trecentosessantacinque scene all’anno, cioè dieci lavori drammatici. Anche se ne cadono cinque, e tre non abbiano che un successo mediocre, ne rimangono sempre due; due successi che darebbero un bel risultato. Sì, coraggio, pur che la saluti mi ritorni ed io mi imbarcherò arditamente sulla galera drammatica con dei buoni soggetti!».
Attraverso le arti sorelle. Letteratura, «Ars et Labor. Musica e Musicisti», Milano, Anno 63, Vol. II, 15 Dicembre 1908, pp. 990-991.
p. 991. E’ stata scoperta, annunzia il giornale Comoedia, una commedia di Balzac di cui si ignorava l’esistenza. Essa si intitola l’Ecole de menage e contiene scene squisite sulla educazione coniugale. È probabile che tale commedia sia quest’inverno rappresentata a Parigi.
Corriere Milanese. Matrimoni milanesi, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 359, 27 Dicembre 1908, p. 5.
Possiamo dunque chiamare Milano la città santa del matrimonio. Balzac la chiamerebbe la Mecca del celibato …
Antimusicista, Mentre si processa il fulmine. Perché difendo Cifariello, «La Bohème», Trani, Anno V, Num. 14, 13 dicembre 1908, pp. 2-3.
p. 2. Ricercare se Cifariello seppe educare la moglie, secondo la recente pedagogia coniugale, sia pure informata alla «Phisiologie (sic) du Mariage» del Balzac, è una trovata da lasciarsi ai berretti frigi e ai blasoni loici dell’Accusa […].
Jules Arren, Sua Maestà la «Réclame» (1), «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XIX, Vol. XXIX, N. 2, 27 dicembre 1908, pp. 25-27.
(1) Da un articolo di Jules Arren, in Le Correspondant, 19 dicembre.
Un precursore.
p. 25. Balzac, nel suo César Birotteau, narra come Popinot, fabbricante dell’«olio cefalico2, diffondesse il nome di quel preparato: la casa Popinot trionfa nell’opinione pubblica grazie ai richiami pubblicati in ogni giornale. Immensa rivoluzione, scrive Balzac, e tale fu veramente: ma a quei tempi si tratta ancora di metodi primitivi, di giornalisti che cedono alle insistenze, ai complimenti, al piccolo dono, al biglietto di teatro, all’invito a cena; oggi un grande giornale non nomina altre che le case di commercio con le quali ha un contratto, evita di citare il loro nome se non nell’avviso a pagamento, poiché né la vendita, né gli abbonamenti possono assicurar la vita di un periodico, la pubblicità è l’unica fonte di salute, ed è sacra. Sulla porta del tempio vigila l’amministratore.
Tempi primitivi quelli di Balzac, certamente; ma egli già scriveva, con singolare acume: «… Avevano avuto il genio divinatore per comprendere l’influenza del giornalismo e l’effetto prodotto sul pubblico da un colpo di grancassa».
Giuseppe Baffico, Anton Giulio Barrili, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVII – Della Raccolta CCXXI, Fascicolo 883, 1° ottobre 1908, pp. 465-471.
p. 469. La sua anima di novelliere vario e giocondo è insofferente di freni: – egli si esalta parlando dell’opera del vecchio Dumas, mentre parla con reverenza, ma senza inneggiare, del Balzac.
Raffaello Barbiera, Di nuovo il Sardou. – E. Pailleron, in Polvere di palcoscenico (Note drammatiche). Vol. II. – Teatro straniero, Catania, Cav. Niccolò Giannotta, Editore, 1908 («Sempreverdi. Biblioteca popolare contemporanea», pp. 59-72. [1882].
p. 59. Abbiamo visto passare sulle scene del Teatro Manzoni una serie di commedie in parte vecchia che, come il Mercadet del Balzac parevano nuove, e in parte nuove che, come la Crisi di Ottavio Feullet (sic), erano vecchie. […].
pp. 65-67. Il Mercadet del Balzac, nuovo pel teatro Manzoni, non andò a’ versi del pubblico, già avvezzo alle commedie bene architettate, ricche di sorprese e curate anche nei particolari. Il lavoro drammatico del Balzac, è un capolavoro che non morrà; ma, per il pubblico, è del vecchio stampo. Il Balzac il profondo psicologo, curò solamente e sommamente il carattere del suo protagonista, ch’era quello che gli premeva; e trascurò il resto. Che importava a lui degli altri personaggi secondarii? Gli bastava sbozzarli, farne delle macchiette. Qual valore aveva per quell’alta severa mente d’artista l’effetto scenico? Gli sarebbe parsa volgarità il ricercarlo. Il Balzac gettò sulla scena vivo, vero, il cosidetto affarista. Lo mostrò in tutti i suoi lati, ne svolse tutte le pieghe, ne palesò i pensieri più reconditi, ne seguì i più obliqui avvolgimenti del cervello. Il suo Mercadet è una creazione al modo del Misantropo di Molière, pure rappresentato nei giorni scorsi sulle stesse scene; è una creazione isolata, è una figura, una grande figura, artisticamente parlando; ma il pubblico moderno non sa che farne delle grandi figure solitarie, preferendo le figurette, i figurini, purchè agiscano tutti, purchè ballino magari tutti insieme, come gli automi dei suonatori girovaghi. […].
p. 71. Lo [Giovanni Emanuel] abbiamo salutato grande nel Mercadet, nell’Odette, e nella più antipatica produzione, che siasi mai vista: nel Bastardo. […].
Emilio Zola, pp. 96-105.
p. 104. Già Onorato di Balzac, nel Mercadet, tratta quell’arte [l’arte del teatro] e persino quel tipo d’affarista che innamorano lo Zola; e il Mercadet non fu coronato di gloria; eppure, a mano a mano che si reciterà, acquisterà ammiratori.
Raffaello Barbiera, Figure e Figurine del secolo XIX. Con notizie inedite d’Archivi Segreti di Stato. Nuova edizione ritoccata, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1908.
[Su Stendhal e Balzac, pp. 42; 64-65]. Cfr. 1899: Figure e figurine del secolo che muore.
Eraclide Bartoli, Idee critiche, «La Romagna. Rivista mensile di storia e di lettere», Jesi, Anno V, Fasc. II – Serie II, Febbraio 1908, pp. 138-142.
p.
139. Ben altra ricchezza nella Comédie humaine e nei
Rougon-Macquart; ma nessuno ha pensato mai di chiamar poeti Balzac e
Zola, chè la fantasia è un elemento della poesia, non tutto
quanto.
V.[ito] A.[ntonio] Berardi, Allucinazione e suggestione, in Giudici e testimoni. Studio di psicologia giudiziaria, Napoli, Libreria Dekten & Rocholl, 1908, pp. 104-130.
p. 111. L’artista, per esempio, man mano che procede nella vita, si va sempre più appartando dal consorzio della vita dei suoi simili, per ridursi spesso solitario tra le creature della sua fantasia. Sono certamente allucinazioni le conversazioni, che Torquato Tasso teneva con i personaggi della sua Gerusalemme; le orgie solitarie di Carlo Baudelaire; le prolungate distrazioni do Onorato de Balzac; e gli sdoppiamenti di personalità, che avvenivano in Edgardo Poë ed in Hoffmann.
Bergeret, Color locale, «La Stampa. Gazzetta Piemontese», Torino, Anno XLII, Num. 19, 19 Gennaio 1908, p. 3.
Da Balzac e da Dumas padre a Bourget e a Jean Lorrain, l’italiano è un personaggio affascinante e pericoloso, seduttore e traditore, fatale e ridicolo, più geloso di Otello e più menzognero di Jago.
Albert de Bersaucourt, Balzac e la sua «Revue Parisienne» (1), «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XVIII, Vol. XXVIII, N. 18, 12 aprile 1908, pp. 428-430.
(1) Da un articolo di Albert de Bersaucourt, in Mercure de France, n. 257, 1° e 16 marzo [Vol. LXXII, pp. 45-68; 212-232].
Balzac concepì i progetti più varî e tentò le più diverse imprese per la conquista della fortuna e della gloria, ma fra tutti il desiderio più vivo fu quello di possedere un giornale o una rivista sua, dove esprimere apertamente e interamente le sue idee e combattere i suoi nemici. Anche riteneva che un periodico pubblicato sotto la sua direzione sarebbe stato un ottimo affare commerciale, e sperava di poterne trarre guadagni tali da pagare i suoi debiti. Ond’è che più volte rinnovò il tentativo: nel 1830 fondava con Emile de Girardin, Varaigne, Hyppolite Augier e altri un settimanale Feuilleton des journaux politiques, poi, con Gavarni, il Journal des gens du Monde, più tardi, con Jules Sandeau, Gustave Planche, Charles de Bernard e Théophile Gautier, la Chronique de Paris che visse nove mesi, e finalmente la Revue Parisienne che cominciò nel luglio del 1840 ed ebbe tre numeri.
In due fascicoli del Mercure de France Albert de Bersaucourt narra la storia di questa novità che contiene qualcuna fra le più belle pagine di Balzac romanziere e critico, e la illustra con documenti assai interessanti e con numerosi brani della vivace prosa del grande scrittore.
I vani tentativi precedenti, dai quali Balzac aveva tratto sol debiti e guai, non lo avevano scoraggiato: la sua fiducia nell’avvenire era incrollabile. In quei giorni les Guêpes d’Alphonse Karr avevan raggiunto la tiratura mensile di 20,000 copie e les Nouvelles à la main di Roqueplan trovavan larghissimo favore nel pubblico: perché mai una rivista letteraria e politica di 160 pagine in-32, cioè tripla delle altre, diretta da Balzac e venduta a un franco, non avrebbe dovuto aver fortuna? Balzac fece i suoi conti e concluse che la sua Rivista si sarebbe diffusa a centinaia di migliaia di copie, gli avrebbe reso trentamila franchi al mese, e avrebbe diretto la politica della Francia e rinnovato la critica letteraria.
E poi bisognava difendersi dai nemici ogni dì più audaci: Balzac che lavorava incessantemente e produceva con mirabile fecondità, dava ombra ai letterati francesi, e tutta la stampa e tutta la critica, capitanata da Sainte-Beuve, gli eran fieramente avverse. Bisognava difendersi. E Balzac s’apparecchiò all’audace impresa con giovanile entusiasmo. La rivista ebbe appena tre numeri, ma quei tre fascicoli sono un maraviglioso esempio della potenza di lavoro e dell’universalità di attitudini ch’egli ebbe.
Il primo fascicolo.
Il primo fascicolo (luglio 1840) contiene una introduzione, una novella, una epistola sull’inaugurazione della statua di Gutenberg, una lettera su la letteratura, i teatri e le arti, e le lettere russe.
La novella ha per titolo Z. Marcas. Il nome del protagonista e il titolo fu trovato dopo una lunga passeggiata per le vie di Parigi e un accurato esame delle inscrizioni e delle insegne dei negozi. Finalmente parve a Balzac che il nome di Marcas bene s’addicesse al personaggio ch’egli aveva concepito. Che cosa egli trovasse nel nome di quel povero sarto che aveva la sua insegna in rue de la Jussienne, lo scrittore ci dice in una vivace pagina di osservazioni curiose; al nome pose innanzi una Z. che veramente sull’insegna non c’era, pensando che quest’ultima lettera dell’alfabeto avrebbe significato «un non so che di fatale»: un presagio di martirio, un simbolo nel suo zigzag, di vita tormentata e fantastica.
Le sette lettere nel nome del nostro personaggio assumono nella fantasia dello scrittore straordinarie significazioni, ma l’importanza della novella e del suo eroe sono ben maggiori di questa osservazione capricciosa. Marcas è una grandiosa figura d’uomo di genio che vive incompreso e maltrattato, che serve per necessità uomini di stato che lo pagano d’ingratitudine, e che infine, tradito e abbandonato, muore respingendo le proposte di un avversario politico. Fu detto, più tardi, che Balzac aveva descritto, prima che sorgesse, la figura di Gambetta, in quell’uomo immaginario che muore di lavoro, di nobile ambizione e di patriottismo. Certo la novella è interessante perché mostra nell’autore delle aspirazioni democratiche e sociali non prima trovate in un autore che si dava vanto d’esser cattolico e realista.
A questa novella segue un articolo di critica. Balzac, dopo aver lamentato le tristi condizioni della critica letteraria del suo tempo, esamina e condanna un romanzo melodrammatico di Latouche, Léo. L’opera, piena di ingenuità e di delitti, farraginosa e scritta male, non meritava miglior trattamento; inoltre Balzac non sapeva soffrire le arie di critico protettore che il Latouche soleva darsi, né il suo fervente amore per la repubblica, né le sue conversazioni brillanti, tanto più che il grande scrittore della Commedia Umana non era (almeno così dice la Sand) un parlatore vivace come il Latouche, e forse il suo accanimento si spiega con qualche piccola offesa d’amor proprio.
Balzac e Sue.
La critica di Balzac verso Eugène Sue è addirittura crudele. Nell’analisi del romanzo storico Jean Cavalier trova errata la linea generale dell’opera, rileva anacronismi, disapprova l’abuso delle note: «Le note di un romanziere son la parola d’onore d’un guascone. L’autore diviene impertinente a forza di note, perché dà dell’ignorante al suo lettore». Quanto allo stile, dice che il Sue scrive come mangia e beve, «per meccanismo naturale» e quel che soprattutto irrita Balzac è il modo come è trattato Luigi XIV nel romanzo del Sue. Del resto, il lavoratore solitario e semplice, incurante di ogni eleganza personale e motteggiatore della ricercatezza altrui, non poteva tollerare in Eugène Sue il dandy tutto preoccupato delle sue cravatte e dei suoi vestiti, delle sue eleganze e delle sue raffinatezze. «Eugène Sue è un giovanotto simpatico fanfaron de vices, assai dolente di chiamarsi soltanto Sue, che fa del lusso per sembrare un signore, ma in fondo migliore dei suoi libri». Che cosa avrebbe detto il grande critico se avesse scritto il suo articolo dopo la pubblicazione dei Misteri di Parigi, allorchè tutti lodavano la filantropia, la generosità, la grandezza d’animo dell’elegantissimo conquistatore?
Una frase è degna di nota in quest’articolo: «Il dialogo, diciamolo pur schietto, è l’ultima e la più facile delle forme letterarie». E torna a mente l’aneddoto e il suo dialogo col direttore del Siècle, quando chiese di esser pagato più degli altri perché le sue pagine eran più fitte e meno esuberanti di «a capo» …
Balzac e Hugo.
Invece, egli ammira apertamente Victor Hugo, e l’ammirazione va fino al segno che lo scrittore realista può difender anche l’Hugo come uomo politico repubblicano. L’amicizia fra i due grandi uomini continuò fino alla morte, e Balzac nel 1839 ritirò la sua candidatura all’Accademia per cederla all’Hugo, e questi descrisse in una pagina ammirevole l’ultima sua visita a Balzac moribondo e pronunciò sulla sua tomba un discorso bellissimo.
Il primo fascicolo termina con le Lettere russe nelle quali si espone la situazione politica e si aggredisce il Thiers con straordinaria violenza, con offese personali e con vivacissimi epiteti.
Il fascicolo secondo.
Il secondo fascicolo della Revue Parisienne contiene una novella, una sestina, le cronache di letteratura, le cronache della stampa e le lettere russe.
Le fantasie di Claudina sono una novella romantica un po’ falsa e comune. Claudina è un tipo straordinario che non rifugge da nulla per piacere al suo amante e da piccola borghese modesta diviene elegante e mondana, abbandona il marito, si getta sul teatro e si crea un mondo brillante e splendido per esser degna del suo nobile amante. Il quale è un tipo di quella bohême aristocratica che precedette di qualche anno quella letteraria, di cui Murger narrò la storia, bohême di eleganze e di follie, di prodigalità e di mode, che il solitario Balzac non poteva certo vedere con occhio amichevole.
La sestina è del Conte di Grammont, e Balzac si limita a una nota che esamina la struttura e la difficoltà di questa forma lirica che solo il Petrarca seppe superare. La Lettera sulla letteratura il teatro e le arti, che segue, contiene la celebre critica sul Port-Royal di Sainte-Beuve, piena di rabbia e di insulti. L’uno sorride, l’altro rugge, quello critica, questo morde: fou, halluciné, sot, charlatan, salope, crapule; lo vorrebbe morto, se potesse. E fino alla morte serbò l’odio e l’acredine e non mancò di manifestarlo con insinuazioni e con cattiverie.
La Chronique de la Presse violentemente deplora la poca tolleranza dei giornali verso il cattolicismo, l’inferiorità dell’armata, l’insufficienza della cavalleria, e il carattere ufficioso dell’agenzia Havas: cose di tutti i giorni, anche di oggi.
L’ultimo fascicolo.
Il sommario del terzo fascicolo reca uno studio sul Beyle, la solita lettera sulla letteratura, uno studio sugli operai. L’articolo di Balzac su La Chartreuse de Parme è stato anch’esso famoso: il critico saluta con entusiasmo l’opera nuova che ritiene un capolavoro della letteratura d’idee del suo tempo, una cosa straordinaria dove il sublime risplende in ogni capitolo e che può esser apprezzato solamente dalle anime elette. Egli trova, è vero, alcuni difetti di stile in questo volume di Stendhal in cui «l’Italia rivive», ma l’articolo rimase pur sempre il più vivo elogio che si sia mai fatto di Stendhal vivente. E fu anche un atto di probità letteraria richiamar l’attenzione su questo libro, fin’allora così poco conosciuto.
Stendhal ne fu profondamente commosso, e scrisse a Balzac ringraziando e giustificandosi delle osservazioni mosse al suo stile.
La critica letteraria è dedicata, e non benevolmente, a Edoardo Ourliac, per una sua pubblicazione recente, e a un volume di novelle di Alfredo De-Musset del quale si fanno grandi elogi.
Per quali motivi il genialissimo scrittore sospendesse dopo questo numero la pubblicazione, non sappiamo: probabilmente le difficoltà materiali dovettero togliergli il coraggio di continuare. Ma in questo tentativo appariscono a chiara luce le qualità del più grande scrittore e del lavoratore più tenace che la Francia abbia avuto, e la sua potenza creatrice, la sua probità e la profondità delle sue osservazioni sugli uomini e sulle cose.
Umberto Boccioni, Terzo taccuino, Milano, 16 marzo 1908, ora in Taccuini futuristi (1907-1915), Roma, Mancosu, 1993 e 2004.
Per questo l’artista, lo scrittore, il poeta, il musicista, il prete, il soldato, l’uomo politico l’avventuriero il brigante ecc. tutti gli uomini cioè che nella vita prendono un posto di combattimento avranno sempre la simpatia della donna anche se fisicamente e moralmente legata a un impiegato a un salumaio o a quegli uomini che sottostanno ad una gerarchia prestabilita. Ed anche in questo vi possono essere eccezioni se questi uomini hanno nel loro intimo qualità di dominatori. Questo naturalmente con sfumature infinite.
Balzac aveva perfettamente ragione. E Schopenhauer è stato troppo unilaterale da quel pessimista nato che era come giustamente fu detto. F. Nietzsche poi ha parlato della donna con un’aria così corrucciata indegna d’un eroe sorridente.
Balzac dice che gli artisti hanno
minori probabilità ad essere cornificati degli altri ed è vero quantunque io
tema terribilmente per me ... La donna, a parità di valore, ha sempre una
superiorità indiscutibile nel senso artistico su
l’uomo.
Giuseppe Bortone, Fra il voto e l’amore. Note critiche sul “Monaco” del Lewis, sul “Templaro” dello Scott, sull’”Arcidiacono” dell’Hugo, sull’”Abate” dello Zola, sullo “Scorpione” del Prévost ecc., Napoli, Libreria Editrice Internazionale Detken & Rocholl, 1908.
p. 10.
Lo stesso Balzac nella sua «Honorine» ne fece lodevole menzione, e in una
storia della letteratura inglese, pubblicata nel 1834, al Lewis è dedicato un
intero capitolo.
Jacopo Caponi, Letterati dei due paesi, in Ricordi di Folchetto (Jacopo Caponi), Torino, Società Tipografico-Editrice Nazionale (già Roux e Viarengo), 1908, pp. 339-362.
pp. 339-340. Pochi ormai leggono Balzac; mentre sovente si parla della sua personalità, della sua corrispondenza, specialmente con quella contessa Rezwuska, che non potè sposare che poco prima della sua morte.
Giovanni Castellano, Il moto del pensiero moderno nell’opera di Benedetto Croce, «Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti (Nuova Serie)», Trani-Bari, Vol. XXIV, Num. 8-9-10-11-12, Agosto-Dicembre 1908, pp. 239-248.
p. 248. Onorato di Balzac diceva enfaticamente di se stesso: Porto una società nel mio cervello.
Benedetto Croce, alla fine della Filosofia della Pratica, porge il suo lavoro modestamente ai ben disposti come strumento di lavoro.
G. A. Cesareo, Storia della letteratura italiana a uso delle scuole, Messina, Vincenzo Muglia-Editore, 1908.
I Minori, pp. 383-393.
p. 391. […] scrittori ignoti o mal noti [tradussero] i romanzi di Walter Scott, di Vittor Hugo, di Giorgio Sand, d’Onorato di Balzac.
O. Cipriani, Dalle Riviste e Varietà. Sardou medium scrivente, «La Lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera», Milano, Anno VIII, N. 12, Dicembre 1908, pp. pp. 1027-1030.
p. 1027. Il grande Balzac fu occultista e si disse discepolo di Swedenborg; saturi di spiritismo, di veggenza, di teorie occultiste sono tra i suoi lavori Louis Lambert, Seraphitus Seraphita (sic), Ursule Mirouet, Les proscrits, Peau de Chagrin e La recherche de l’Absolu.
Giulio Claretie, Appendice del Corriere delle Puglie (04). “Noris”. Prima traduzione italiana (Proprietà della Casa Editrice Treves), «Corriere delle Puglie», Bari, Anno XXII, Num. 212, 1. Agosto 1908, p. 2.
La vita! non era troppo più allegra di questo! Egli era
adesso quasi costretto a riconoscerlo, il povero idealista, e il pessimismo di
Balzac non era forse del tutto sbagliato. Ah! li conosceva Balzac quei
manipolatori di danaro, e non era lui, il grosso furbacchione, che si sarebbe
lasciato menare per il naso e trascinare a Mazas da un furfante come quel
Verignon!
Gaetano Contursi-Lisi, Il diritto del maschio, «Il Messaggero Salentino», Lecce, Anno XII, Num. 3, 7 Luglio 1908, pp. 1-2.
p. 1. Balzac — uno dei più acuti studiosi dell’anima umana — intorno al corpo meraviglioso della signora Marneffe (La cugina Betta) vi mette quattro uomini, tra i quali l’insuperabile Hulot, studiato anche dal Nordau (Degenerazione): ebbene neanche questo pervertito dal senso, quando la femina lo scaccia, concepisce il delitto per nessuna ragione!
Enrico Corradini, L’epilessia di Napoleone, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 12, 23 Marzo 1908, p. 1.
[Su: Cesare Lombroso, Genio e degenerazione].
Di dove il Lombroso ha tolto la notizia che anche a Napoleone si possa, com’egli afferma (capitolo su Zola), applicare quella sua legge che «l’età matura dei parenti provoca la degenerazione dei figli»? Napoleone ebbe un padre «maturo e vecchio», come Balzac, Schopenhauer, Federico II, Zola e altri genii?
Pietro Croci, La chimera, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 92, 1 Aprile 1908, p. 3.
[Sull’affaire Rochette].
— Che bella fibra di uomo d’affari! — dicono gli uni. E gli altri aggiungono: — E’ un personaggio degno di Balzac.
Il sommo romanziere della «Commedia umana» ha creato con una evidente compiacenza il personaggio dell’avventuriere moderno, fertile di progetti grandiosi, senza scrupoli, senza sentimentalismi, e affatto privo di quella avarizia che rende di solito antipatici gli accumulatori di ricchezze.
Doctor Cajus, Il medico e la morte, «Il Policlinico. Periodico di medicina, chirurgia e igiene. Sezione Pratica», Roma, Anno V, Fasc. 11, 15 marzo 1908, pp. 345-347.
p. 345. Certamente non si troverà oggi un medico che preferisca tenere la condotta che Octave Mirbeau attribuisce al medico di Balzac. Secondo Mirbeau, la mattina della morte di Balzac il suo medico, Nacquart, restò più di un’ora al capezzale del suo amico.
L’autore della Commedia umana soffocava, e tuttavia trovò il modo di domandare a Nacquart: «ditemi la verità … a che punto siamo?». Il medico esitò, poi gli rispose: «Voi avete l’animo forte … io vi dirò la verità … voi siete perduto». Balzac ebbe un leggiero fremito sulla faccia, le sue dita strisciarono sulla tela del lenzuolo, e disse semplicemente: «ah!», poi, un poco dopo: «Quando debbo morire?» Con gli occhi pieni di lacrime il medico rispose: «Non passerete forse la notte», e tacquero entrambi.
Ad un tratto Balzac guardò lungamente Nacquart e disse: «Ah! Io comprendo, mi ci vorrebbe Bianchon; Bianchon mi salverebbe».
Una delle creazioni del suo genio di romanziere era divenuto in quel momento per lui una realtà vivente.
Henry Duvernois, Popote, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 261, 19 Settembre 1908, p. 8.
Forse da quel momento la pietà è entrata nel mio cuore. E la pietà è l’avversaria dell’amore, secondo Balzac.
Egla, Note mondane. A proposito di esami, «Il Risorgimento. Organo degli interessi pugliesi», Lecce, Anno XXIII, Numero 27, 22 Luglio 1908, p. 1.
Si è detto che l’ortografia è la scienza degl’ignoranti: ciò non vuol dire però che sia sempre la virtù dogli scienziati e dei letterati. È noto che Giorgio Sand aveva un’ortografia un po’ ... fantastica; che non sempre i manoscritti di Balzac e di Dumas erano di una correttezza estrema.
E.[sic?; lege: G. (aleazzo)?] F.[alconi?], Balzac, in Onorato Balzac, Il Cugino Pons … cit., pp. [I-III].
Onorato di Balzac nacque a Tours il 16 (sic) maggio (allora si diceva il 27 floreale) 1799, il giorno del santo di cui ebbe il nome. La sua aristocrazia non andava oltre le sue pretese e la particella nobiliare ch’egli cominciò a premettere al suo nome solo nel 1836, poiché suo padre, nato da umili lavoratori manuali, veniva dalle campagne del Tarn e fu il primo a mutare il suo oscurissimo casato di Balsa in quello più sonoro di Balzac.
Onorato si trasferì giovane a Parigi e vi condusse fino a trent’anni una vita singolarmente avventurosa e disorientata, avviandosi successivamente per molte e diverse direzioni, senza pervenire in nessuna a qualche risultato.
Dal 1822 al 1828, abitando in un’orrida catapecchia della grande metropoli, si diede a scrivere volumi su volumi, ora in collaborazione con Le Poitevin Saint-Alme, ora solo, con i pseudonimi di Horace de Saint-Aubin e di Lord Rhoone, non scoraggiandosi mai, nutrendo un’indistruttibile fiducia nelle proprie forze, persistendo ostinatamente sulla via che era veramente sua, e nella quale avrebbe finalmente trovato uno scopo alla sua vita.
Aveva tentato inutilmente l’industria: editore, tipografo, fonditore di caratteri, ogni forma di attività di ordine pratico gli era costata nuove delusioni e debiti in quantità. Una fibra meno resistente della sua avrebbe finito per spezzarsi e abbandonarsi alla deriva del caso. Ma Balzac era una tempra di lavoratore formidabile, e quand’ebbe trovato il lavoro che si addiceva alle sue attitudini, non ebbe più riposo, né pace.
La serie delle opere, che dal 1827 egli cominciò a firmare col suo nome (sic), costituisce forse il più poderoso travaglio uscito da cervello umano. La mole di quest’opera è immensa e stupisce chi la conosce intera. In venti anni di prodigiosa attività, non si contano i volumi usciti dalla sua penna. Da Le dernier Chouan (1827 [sic]), a Le cousin Pons (1847), egli produsse ininterrottamente, regolarmente, accanitamente due, tre, cinque e persino sette volumi all’anno, come nel 1832, in cui uscirono, un dopo l’altro, Le chef d’oeuvre inconnu; Le Colonel Chabert; Le Curé de Tours; Louis Lambert; La femme abandonnée; L’illustre Gaudissart e i primi dodici Contes drolatiques, a tacere delle cose minori.
La physiologie du mariage cominciò nel 1829 a conciliargli l’attenzione del pubblico, ma la vera e propria rinomanza non gli sorrise che l’anno di poi, con la pubblicazione di Peau de chagrin. Il periodo più felice della sua ispirazione, la fioritura più splendida del suo genio coincise con la serie di novelle e romanzi che, nel grande ciclo della sua Comédie humaine, egli classificò poi come Scènes de la vie privée e Scènes de la vie de province, e s’intitolano: La femme abandonnée; La femme de trente an (sic); La Grenadière; Les Celibataires (sic); Le lis (sic) dans la vallée; La vieille fille, ecc., con Eugénie Grandet innanzi a tutti.
Balzac è specialmente grande come pittore di costumi. La sua potenza di osservazione e la sua memoria dei particolari gli permettevano di ricostruire la vita con una esattezza e una verità impressionanti. Si direbbe che abbia conosciuto gli ambienti e i tipi che egli descrive.
Il danaro ha una parte notevole nell’intreccio de’ suoi romanzi, come motore dei personaggi che vi agiscono: poiché l’oro fu la sua passione dominante, per i godimenti sfrenati che ad esso domandava, e gli eroi prediletti della sua arte non hanno altro Dio che l’oro, altra religione che il senso, altro culto che il piacere.
Del mondo delle donne egli ebbe una conoscenza profonda, nella sua investigazione della vita femminile egli ha del confessore e del medico insieme. E le donne gli son grate della sensazione di nuova giovinezza ch’egli riesce a dar loro quando declinano, allontanandole indefinitamente col pensiero dall’istante terribile in cui cessarono di piacere e di amare.
Quel che sembra miracoloso in Balzac è che la sua potenza di osservazione ebbe poco campo di esercitarsi nella realtà. Oppresso da un lavoro senza tregua, non ebbe tempo di studiare cose ed uomini dal vero. Nella creazione dei tipi e delle scene, nella ricostruzione della vita, egli si affidava all’intuizione: gli bastava un tratto caratteristico per ricostruire un carattere. L’immensa folla de’ suoi personaggi è figlia della sua fantasia, e non per questo il suo mondo immaginario è meno vivo e meno vero del mondo reale.
Giuseppe Fanciulli, L’Incosciente e l’arte (Note), «La Cultura Filosofica. Rivista mensile», Firenze, Stabilimento Tipografico Collini & C., Anno II, N. 3, 15 Marzo 1908, pp. 138-144.
p. 139. Si è tentato è vero da molti di raggiungere il fine desiderato – la provocazione dell’attività incosciente – ricorrendo a mezzi indiretti, facendo largo uso cioè di eccitanti […]. Balzac aveva composto la ricetta di un terribile breuvage: ma probabilmente nessuno, dopo di lui, trovò in quella bevanda l’energia necessaria a creare romanzi come Le Père Goriot ed Eugénie Grandet. L’efficacia di questi stimolanti fisici è affatto dubbia e i casi affermativi si spiegano, probabilmente, come tanti casi di abitudine: quello che prima era voluto diventa necessario: l’artista non sa più produrre se non si trova in certe condizioni fisiologiche.
Arturo Farinelli, L’”umanità” di Herder e il concetto della “razza” nella storia evolutiva dello spirito. Prolusione tenuta all’Università di Torino il 13 dicembre 1907, Catania, R. Tipografia Cav. N. Giannotta, 1908.
p. 13. Che ancor non esistesse una scienza delle razze, parve deplorare un dì il Taine. […]. E se dall’umana commedia del Balzac, ammiratissima, il Taine tolse alimento alle sue naturalistiche teorie, sulla teoria sua rifoggiaron altri l’arte loro [Zola, Gobineau].
Giustino L. Ferri, La Camminante. Romanzo. Parte Quinta, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXV – Della Raccolta CCXIX, Fascicolo 876, 16 giugno 1908, pp. 613-656.
p. 614. Il grosso Portuali più di tutti, inasprito per l’ingiusto oblio in cui erano cadute le sue Satire borghesi, lo [Andrea] chiamava: il nostro Balzac di redazione; e i giovani della rivista ridevano come se avesse detto una facezia spiritosissima.
Giustino L. Ferri, Rassegna drammatica. Vittoriano Sardou, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVIII – Della Raccolta CCXXII, Fascicolo 888, 16 dicembre 1908, pp. 656-660.
pp. 656-657. Col mestiere non si crea certo un drammaturgo quando non c’è; ma se c’è, la conoscenza del mestiere non è inutile, non foss’altro a evitare le ingenuità e le ostentazioni di tecnicismo fuori di luogo per cui, al teatro, uomini di genio come don Miguel Cervantes de Saavedra e Onorato de Balzac, – meno che nel Mercadet, – fanno l’effetto di scolaretti inesperti, impacciati e presuntuosi. […].
p. 259. Rabagas e Margherita Gauthier sono due figure che l’arte ha colte dalla vita e il consenso dei contemporanei ha tipificate in personaggi rappresentativi di un’epoca intermedia fra Balzac e Zola, in un paese che è ancora il centro del movimento europeo. Rabagas più di Margherita Gauthier, perché la letteratura francese aveva già avuto ed ebbe poi altre sorelle in maddalenismo della povera amante di Armando Duval: Manon Lescaut, Marion Delorme, l’Esther di Luciano de Rubempré e tante altre […].
Alberto Finzi, Le singolarità del genio e dell’ingegno, «La Lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera», Milano, Anno VIII, N. 2, Febbraio 1908, pp. 137-144.
p. 141. Balzac aveva una ben alta idea di se medesimo e non ne faceva mistero. Un giorno ad un pranzo – è l’erudito D. R. Segré che ne reca l’aneddoto – un giovine scrittore avendo detto: «Noialtri letterati …», Balzac si mise a ridere omericamente ed esclamò: «Voi, o signore, voi osate dire di essere un letterato! La vostra è una strana pretesa ed una pazza presunzione. Voi osate paragonarvi a noi, Evvia! Ignorate, o signore, che avete l’onore di pranzare con i marescialli della letteratura! …»
Ancora, Balzac pretendeva di discendere dalla grande famiglia dei Balzac d’Entragues, imparentati con sangue reale di Francia.
Questa sua pretensione fu combattuta con tale acerbità che alla fine il grand’uomo perdette la pazienza: «Ah! – esclamò egli – voi sostenete che io non discendo dai Balzac d’Entragues! … Ebbene, tanto peggio per loro!!».
Gaio, Uomini e vita di ieri l’altro. Due mostre retrospettive a Parigi, «Il Marzocco», Firenze, Anno XIII, N. 26, 28 Giugno 1908, pp. 1-2.
p. 2. Ma la letteratura del passato, anche di un passato prossimo, è il riflesso di una vita che non conoscemmo o conoscemmo soltanto attraverso la letteratura. […] Perché la vita reale non fu diversa da quella della finzione artistica o letteraria; e Parigi degli autori romantici è anche Parigi degli eroi romantici? […] Non abbiamo più bisogno di immaginare una casa, una bottega, un raddotto per i Nucingen e i Du Tillet, per il père Goriot o per César Birotteau, per la «cousine Bette» o per Lucien de Rubempré: ci stanno sott’occhio. […] Ecco il ritorno degli affaristi, dei giocatori, degli sfaccendati, il Palais Royal di Balzac, fervido di vita, così come oggi par sacro alla morte. […].
Gli ingegnosi organizzatori della mostra retrospettiva hanno pensato a tutto […]. Ecco in folla i ricordi strettamente letterari: ritratti rari di Hugo e di Balzac, di Lamartine e di De Vigny; le case di Chateaubriand, di Sainte-Beuve e di Balzac. E Balzac, che meritatamente impera da sovrano nella mostra come colui che di questa vita «romantica» fu l’interprete più fedele e più infaticabile – ecco un cimelio assai malinconico: la partecipazione funebre.
Alfredo Galletti, Critica letteraria e critica scientifica in Francia nella seconda metà del sec. XIX, «Studi di Filologia Moderna», Catania, Anno I, Fascicolo 3-4, Luglio-Dicembre 1908, pp. 186-244.
p. 197. Se l’uomo è un automa, ogni attività dell’intelletto si riduce ad un problema di meccanica interiore, di cui si può e si deve scoprire la formula; e perciò basta scrutare la vita dello spirito col metodo e col principio delle scienze naturali. Il comico si è che primo ad affermare la necessità di applicare il metodo della zoologia alla conoscenza dell’uomo è stato quel cervello possente ma torbido del Balzac, il quale si credeva e si vantava spiritualista. Geoffroy Saint-Hilaire ha detto: “Non esiste che un animale. Il creatore si è servito di un solo ed identico modello per lutti gli esseri organizzati. L’animale non è che un principio, il quale prende la sua forma esterna, o per dir meglio, le differenze della sua forma nei diversi ambienti nei quali è costretto a svolgersi. Le specie zoologiche risultano da tali differenze. Io vidi, osserva il Balzac, che a questo riguardo la Società somiglia alla natura. La società non fa essa dell’uomo, secondo gli ambienti ove si esercita la sua azione, tanti uomini diversi quante sono le varietà zoologiche? (2)„ E così appunto egli ideò e ritrasse i personaggi dei suoi romanzi: sintesi di appetiti e di energie primordiali, in cui i casi della vita svolgono ed acuiscono fino alla passione, fino all’eroismo e al delitto questo o quell’istinto.
(2) Cfr. H. de Balzac, La Comédie humaine, Préface générale, Vol. I. delle Œuvres complètes in 24 vol., edizione Calman (sic)-Lévy.
p. 219. «[…] la violenza o la torpidezza dell’immaginazione, l’ingegno lirico od oratorio, quando apparisca in un punto, deve estendere la sua azione anche sul resto. Con un ragionamento continuato egli ridurrà così le diverse inclinazioni dell’uomo di cui si occupa sotto un piccolo numero di inclinazioni predominanti, da cui quelle si possono dedurre e da cui sono esplicate e avrà così lo spettacolo delle mirabili necessità che stringono insieme i fili innumerevoli, variamente colorati e intrecciati, di ogni essere umano» (1). Il Taine riprende qui l’osservazione del Balzac: l’uomo è una forza, un fascio di istinti dominati da un istinto più forte e imperioso, che le circostanze esteriori atteggiano e indirizzano in vario modo senza però trasformarlo.
(1) Cfr. Essais de critique et d’histoire,
Paris, Hachette, 8a ediz. Préface. (La Prefazione ha la data del
1866.).
G. Gallois, La Fine del romanzo (1), «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XVIII, Vol. XXVIII, N. 46, 1° novembre 1908, pp. 1097-1099.
(1) Da un articolo di G. Gallois, in La Revue, 5 ottobre.
pp. 1098-1099. Così avviene che anche coloro che fanno acquisto di libri e che posseggono una biblioteca, preferiscono le opere di storia, di critica, di viaggi e d’arte, o i romanzi già celebri di Balzac, di Stendhal, di Flaubert, di Maupassant. Ma quanti altri, proclamati un giorno «immortali», sono di già caduti nell’oblio! […].
Del resto, i giornali non hanno nemmeno bisogno di far questa spesa: la proprietà letteraria, in Francia, dura cinquant’anni, e opere di dominio pubblico ce n’è quante se ne vuole, da Stendhal a Balzac, dalla signora Emile de Girardin ad Alfred de Musset, a Eugène Sue, a cento altri.
Margherita Grassini Scarfatti, Rudyard Kipling, «La Lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera», Milano, Anno VIII, N. 2, Febbraio 1908, pp. 129-136.
p. 133. Non si può dire dei suoi eroi come di quelli del Balzac che sono «armi cariche di volontà sino alla gola», perché non hanno la fede e l’ardore a tutta prova nell’inseguire la meta prefissa che distingue i personaggi della Commedia Umana.
Angelo de Gubernatis, Annuario letterario e artistico del mondo latino (organo della Società Elleno-Latina di Roma) pubblicato per cura di Angelo de Gubernatis, Roma, 1908.
Felice D’Onufrio: La Famiglia Rondani, romanzo. – Torino, Società Tipografico- editrice nazionale, 1908, pp. 233-234.
p. 234. Vi è sovrabbondanza di particolari minimi; altri scrittori cadono in questo difetto; e primo forse di tutti ma con una rara potenza descrittiva e rappresentativa, aveva dato l’esempio il Balzac in Francia.
Il Bibliofilo, Uomini e Cose, «Rivista di Roma», Roma, Anno XII, Fascicolo XXI, 10 di novembre del 1908, pp. 667-668.
Per i vecchi edifizi non ebber culto solo i romantici, perdutamente innamorati del passato, ma gli stessi precursori del romano moderno, ed alla loro testa fu il Balzac, «le prodigieux visionnaire humain». I tipi creati dal Balzac, dai più nobili ai più vili, da Valentina a Colin (sic), da Rastignac al Père Goriot, vissero tutti nelle case screpolate della vecchia Parigi. Ricordate la «Pension Vauquier (sic)», l’umile edificio dalla scritta «Pension bourgeoise pour deux sexes» ove il Père Goriot visse gli ultimi giorni, martire dell’amore paterno, ed ove Rastignac conobbe la perfidia degli uomini e l’odio implacabile, e la febbre di giungere primo ad ogni costo? Il piccone ha compiuto inesorabilmente il suo lavoro. I ricordi son muti per gli uomini d’affari, ed indarno il Pilon manda il grido: «Imitiamo i Fiamminghi! rispettiamo le vecchie case che ci ricordano lunghi anni guerre cruente, trionfi, persecuzioni e cavalcate!».
Tutti han dimenticato quel motto del Renan: «Ce qu'il y a de meilleur en nous, vient d’avant nous!»...
Il conte Azzurro, In Alto! Escursioni artistico-letterarie sentimentali. Un piccolo volo nel vasto campo della Moda, «Natura ed Arte. Rassegna quindicinale illustrata italiana e straniera di Scienze, Lettere ed Arti», Milano, Fascicolo XVII, 1908-1909, pp. 33-34.
Sorvolando dal periodo ben conosciuto che va dal 1818 al ‘50, ci fermeremo un momento intorno alla trasformazione delle fogge dell’abito muliebre causata dai due più celebri scrittori del tempo, il Balzac e George Sand.
«Una donna fragile e delicata — scriveva il grande Onorato ne La fausse maîtresse— porta il suo duro e smagliante fardello di fiori e di diamanti, di seta e di acciaio, dalle nove di sera alle due e spesso per parecchie ore del mattino. Mangia poco per attirare gli sguardi sopra una figura fine; fa tacere la fame che la sorprende durante la serata, con tazze di thè debilitanti, con dolciami, con gelati che le guastano lo stomaco, o con fette pesanti di pasticcio. Lo stomaco deve piegarsi agli ordini della civetteria. Quando si avvede del male fatto, è troppo tardi. Ha agito contrariamente alle leggi della natura e la natura non ha pietà per essa».
Index, La tristezza del genio, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, 27 Marzo 1908, p. 3.
[Su Dostojewski].
Se i paragoni non fossero sempre, per un verso o per l’altro, manchevoli e pericolosi, e se certi nomi supremi non imponessero irresistibilmente silenzio ai confronti, si potrebbe dire che dopo Guglielmo Shakespeare nessun creatore d’uomini — se non forse il Balzac — ha saputo come il grande e infelice scrittore russo tagliar nella pietra di questa nostra vita misteriosamente profonda e diversa più forti e più aspre figure di verità singolare […].
Ma è giovane, innamorato della letteratura, e alle sue amarezze alterna ferventi giudizi letterari. Balzac lo esalta, «Balzac è grande! I suoi caratteri sono il prodotto dell'intelligenza dell’universo! Non è lo spirito del tempo; migliaia d’anni di lotta sono riusciti a produrre questo risultato in un cuore umano». E intanto il futuro Balzac russo esclama sconsolato: «Oh, fratello, com’è triste vivere senza speranza [...]».
Index, La Santa Ghigliottina, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 258, 16 Settembre 1908, p. 3.
Secondo quindi la leggenda – e il Balzac ne fece una novella – che Sanson avesse assistito più tardi, segretamente, a una messa per l’anima del Re morto e al prete avesse fatto dono d’un fazzoletto di tela finissima segnato con la corona reale e macchiato di sudore.
Ettore Janni, L’arte di essere ingiusti, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 238, 28 Agosto 1908, p. 3.
[Su Barbey d’Aurevilly].
Di Balzac dice che ha in sé qualche cosa di Dante, d’un Dante romanzesco e moderno, «il Dante del nostro tempo che ha storpiato ogni grandezza». E aggiunge: «Ciò che ha dominato, iperdominato il suo talento, è il malcontento di ciò che intorno a lui si faceva e il desiderio di rifarlo, per mostrare ciò che si poteva trarre da tutti quegl’ideali mancati».
Ettore Janni, Gli ottanta anni di Leone Tolstoi, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 254, 12 Settembre 1908, p. 3.
Ricordiamo — così, in generale, senza attardarci ad esempi —: quanti sono nei romanzi e nelle novelle di Leone Tolstoi gli atti più semplici e più consueti di personaggi che ci sorpresero come per una significazione nuova alla nostra esperienza comune, come per la rivelazione d’una importanza, e sopra tutto di una potenzialità, che ci era sfuggita e che riscoprimmo in lui e ci parve d’aver verificata, lì per lì, in un sùbito spontaneo irresistibile confronto? Innumerevoli. Forse, in questo, neanche Balzac ci pare così prodigioso: e Balzac e Tolstoi, da un capo all’altro del secolo decimonono, sono gl’interpreti giganti di quella che il primo dantescamente chiamò umana commedia.
H. Klino, Beethoven et le Baron de Trémont, «Rivista Musicale Italiana», Torino, Fratelli Bocca Editori, Volume XV, Anno 1908, pp. 275-294.
[Da: Mémoires du Baron de Trémont, né en 1799, mort en 1852. 5 volumes manuscrits, déposés à la Bibliothèque Nationale de Paris, nota (1), p. 276].
p. 279. Les sièges presque toutes de paille étaient couverts d’assiettes avec les restes du souper de la veille, et de vêtements. Un Balzac ou Dickens continueraient cette description pendant deux pages et en employeraient (sic) autant à vous décrire le signalement et le costume de l’illustre compositeur; mais, comme je ne suis ni Balzac, ni Dickens, je me borne à ceci: j’étais chez Beethoven!
Fernand Laudet, Brillat-Savarin (1), «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XVIII, Vol. XXVIII, N. 38, 6 settembre 1908, pp. 904-906.
(1) Da un articolo di Fernand Laudet, in Revue hebdomadaire, 25 luglio.
p. 905. «E’ stato uno dei primi – diceva Balzac – che abbia saputo notar l’influenza del palato sui destini degli uomini».
Gian Pietro Lucini, Ragion Poetica e Programma del Verso Libero. Grammatica, Ricordi e Confidenze per servire alla Storia delle Lettere contemporanee, Milano, Edizione di “Poesia”, MCMVIII.[7]
Libro primo.
Divagazioni ed incorse per la Critica l’Arte e la Vita.
II., pp. 48-121.
Dove con qualche premessa e qualche digressione, si incomincia una storia che risale al secolo scorso.
p. 88. Ciò che in Francia fu una seconda Bohème, non quella del Balzac, che diede le giornate di Luglio e che fu ricompensata così malamente da Filippo Uguaglianza; ma l’altra del Champfleury, scampato a pena dalla fine del disastro del 1870; quella che si rivoltò contro il romanticismo opportunista e turiferario […]; quella, in Italia, si chiamò Scapigliatura. […].
pp. 93 e 95. A poco, a poco, via Vivajo e via Rossini, via Borghetto venivano fabbricate, si delineavano; la città [Milano] prendeva possesso di quelle ortaglie, di quei giardini, di quei parchi, in uno dei quali Balzac aveva potuto vedere la bimba di Cristina Belgiojoso, e dedicarle una sua novella, quando venne a Milano, fu presentato dall’Azeglio a Manzoni con grande scandalo dei bigotti ed a dispetto del Tommaseo, astioso e diffamatore per carattere. […].
Col naturalismo non si ammirano i cattivi maestri immortali come li contò il romanticismo. [...]. I cattivi maestri sono altrove. Di solito, questo epiteto, che fa onore nell’arte, gratifica quei letterati che escon fuori dalla ordinanza classica, che tornano a rivedere la natura e l’uomo sotto quell’angolo visuale loro proprio, che scoprono od invertono i valori morali. Sono Stendhal e Balzac, Barbey d’Aurevilly e Baudelaire; concedetemi che sieno in Italia, anche Leopardi e Foscolo; sono i poeti che non danno ascolto al dogma, ma alla natura. […].
p. 97, nota (1). [il naturalismo] chiamò la materia organica a rappresentare la energia (1); […].
(1) «[…] S’imponevano i metodi scientifici; li eroi pallidi lasciavano il posto alle creazioni reali; in ogni luogo l’analisi rimpiazzava l’imaginazione; Balzac, da quel momento, era chiamato ad usare potentemente di questo strumento. – Uccideva le menzogne delle vecchie scuole, incominciava l’avvenire». Zola, Balzac. Les romanciers naturalistes.
III., pp. 122-289.
Anticipazioni. – Verità rafferme e fresche.
p. 155. Più tosto, con etichetta naturalista s’importavano i romanzi della Rachilde, l’A Rebours dell’Huysmans, i primi volumi dell’Etopée, La Décadence latine del Péladan, raccomandatoci per un deciso continuatore di Balzac. […]
p. 259, nota (1). La Scapigliatura, torniamone a parlare; fu qualche cosa come una Bohème nostrana, tra quella del Balzac e l’altra più nota del Murger […]. Eroi d’amore, sempre, comunque, li scapigliati. «Imanginatevi Lovelace, Enrico IV, il Reggente, Werther, Saint-Preux, René, il maresciallo di Richelieu in un solo uomo e voi avrete un’idea dell’amore di questi giovanotti» (Balzac, Un Prince de la Bohème).
IV.
In cui si disegnano le competenze, i motivi e la premessa della nostra “Ragion Poetica”, pp. 290-417.
pp. 339-340, nota (2); p. 340. Balzac, anch’egli, per altra ragione, istitutore romanziere di un ordine politico basato sulla autorità, il genio e la gerarchia religiosa (tradizione e rinnovamento) aveva compreso tutto il valore della frase del Ginevrino [J.-J. Rousseau, Discours sur l’Inégalité: «Cessato il bisogno, egli dice, ch’io ho della sua assistenza, nessun dovere mi lega a mio padre, come nessun diritto ha reciprocamente il sovrano, secondo l’ordine di natura, sopra di me […]», citato precedentemente], inscrivendo in Mémoires de deux Jeunes mariés (sic): «Col tagliar la testa a Luigi XVI, la Rivoluzione l’ha tagliata a tutti i padri di famiglia».
p. 393. [Nuova Inquisizione luterana]. – Il tribunale di Manchester manda a distruggere novemila esemplari della traduzione di Contes drolatiques di Balzac; […].
V.
Dove si va parlando, con molte allusioni personali, di: “Scuola”, e “Ricordi” e si passa in parata una “Rassegna”, pp. 418-518.
pp. 423-424. Già, in su le prime, noi avevamo deviato dalle antiche regole di successione estetica, differenziandoci. – Infatti, subito che hanno potuto balbettare i romantici contro i classici, invocarono sé essere scuola; e similmente i naturalisti, cioè dei romantici che si erano serviti più abbondantemente di termini esatti e scientifici e che s’industriavano a lucidare con vernice moderna i soggetti de’ nostri classici, vollero pretendersi scuola anche loro. Il processo era guelfo, per quanto, a volta a volta, rivoluzionario o positivista, romantico o naturalista; psicologi e parnassiani, tutti, invocavano la disciplina del Balzac, uomo guelfo, a loro patrocinio: «La voce loro così netta, così ampia e distinta nella letteratura (la voce ed il dettato dei sistemi) questa vivente espressione della società, oggi – lamentava il plasmatore della Comédie humaine – non si ode più quasi non fosse mai stata. Ora, quando una letteratura non ha sistema generale, non può ricomporsi in un essere organico e si discioglie col suo secolo». Anarchia? Balzac temeva di crederlo; per noi la parola risponde senza paure; sia anarchia, federazione di libere e complesse unità operanti, determinate ad un unico lavoro di bellezza […].
p. 463 e nota (1). Penultima ingiuria: dopo che furono persuasi della realtà delle nostre dipinture, della onestà del nostro processo estetico, della forza della nostra critica, della necessità dell’arte nostra, ci venne la taccia d’immorali. Li ringraziamo ancora, perché tutti coloro (1) che avevano innovato scienza, filosofia, letteratura lo furono del pari, al giudizio delli oziosi e delli schiavi, essendo i disturbatori della pubblica quiete, secondo l’opinione di quelli che vivono sui fondi secreti.
(1)«Il rimprovero d’immoralità, che non mancò mai allo scrittore coraggioso, è l’ultimo, del resto, che egli si rivolge quando gli si sono esaurite in contro tutte le altre accuse. Se voi siete veritiero nelle dipinture; se con lungo lavoro notturno e diurno avete terminato col saper scrivere la lingua più difficile del mondo, allora vi si getta la parola immorale in faccia. Socrate fu immorale, e Cristo: e tutti e due furono sentenziati e morti in nome della società che rovesciavano e riformavano. Quando si vuol uccidere Tizio, lo si accusa d’immoralità. Questo mezzuccio è famigliare alle sette ed ai partiti, ma diviene la vergogna di tutti quanti l’impiegano. Lutero, Calvino sapevano egregiamente ciò che facevano, servendosi delli interessi materiali feriti come di un gran palvese; moralizzarono. Così, vissero tutta la loro vita grettissimi impostori». Balzac, Avant-propos à La Maison du Chat-qui-pelote (sic).
Aldobrandino Malvezzi, Henri de Régnier e Gérard d’Houville, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXIII – Della Raccolta CCXVII, Fascicolo 867, 1° febbraio 1908, pp. 449-462.
p. 454. Nel Traité de la Vie élégante, il Balzac scrisse di Lorenzo Sterne che egli era un finissimo e acuto osservatore per cui le idee di un uomo sbarbificato sono diverse da quelle d’un uomo barbuto, e si ferma a descrivere la piega di un abito, la forma d’un bottone, e a notare l’influsso del tempo e dell’ora sopra lo svolgersi d’un dialogo e i gesti più minuti e sfuggevoli del suo eroe; ora l’ingegno di Henri de Régnier pare essere disposto naturalmente a cogliere queste differenze, e la sua arte essersi affinata fino a poter mettere in rilievo con grandiosa facilità così tenui circostanze.
Giuseppe Manacorda, Il vero, l’ideale, il simbolo nell’arte. Letture. Zola, “Le Roman Expérimental” – nell’opera dallo stesso titolo – Paris, Charpentier, 1880, pag. 7-12, in Lingua, Stile, Principi d’estetica. Manuale ad uso delle Scuole, Cremona, Stab. Cromo- Tipo- Litografico Ditta Pietro Fezzi, 1908, pp. 321-325.
In questo estratto, sono trascritte le riflessioni di Zola sulla figura del barone Hulot nella Cousine Bette.
Ferdinando Martini, Paolo Giacometti (1816-1882), in Polvere di palcoscenico (Note drammatiche). Vol. I. – Teatro italiano, Catania, Cav. Niccolò Giannotta, Editore, 1908 («”Semprevivi”. Biblioteca popolare contemporanea»), pp. 3-15.
p. 5. Il Balzac scriveva alla sorella che voleva farsi dramma vivente: il Giacometti […] non aveva bisogno di domandare alla storia soggetti di dramma: pur troppo, divenne un giorno dramma egli stesso.
Pietro Cossa (1834-1881), pp. 42-57.
p. 46. Vittor Hugo è romantico, e quali accenti più umani di quelli delle sue Contemplations? Balzac è naturalista, e quanto umani i suoi tipi!
Fernand Mazade, Il sonno (1), «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XVIII, Vol. XXVIII, N. 47, 8 novembre 1908, pp. 1115-1117.
(1) Da un articolo di Fernand Mazade, pubblicato in La Revue, 15 ottobre.
p. 1116. Se Balzac avesse dormito di più avrebbe dato un’opera meno diluita, più profonda e più duratura …
Dora Melegari, Artefici di pene e artefici di gioie, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1908.
p. 118.
Capitolo VI.
Pene sentimentali.
Una parola, uno sguardo
possono cancellare degli anni d’affetto.
Balzac.
Mercadet, Ai Signori Azionisti della Società Idroelettrica Italiana, «La Nuova Commedia Umana. Giornale settimanale», Milano, Anno I, N. 12, 2 Aprile 1908, pp. 22-26.
p. 22. Si parlava della mia grande idea di radunare i paurosi del danaro e i golosi degli alti dividendi intorno a una Banca di speculazioni industriali, che desse loro con la tranquillità un interesse invariabile e perpetuo — vale a dire che i loro capitali depositati non subissero i su e giù, o l’altalena degli affari. Il mio amico mi parlava di un altro progetto, ma non lo ascoltavo. Io non sentivo che me stesso. Io vedevo la mia fortuna, come Saccard vedeva la sua. Impadronirmi delle acque di tutti i fiumi, di tutte le correnti, di tutte le cascate e sottometterle, e piegarle, e avviarle, e incanalarle nei letti delle mie imprese, e farle diventare danaro, del denaro sonante, del denaro che ha dato tanti tripudi solitarî al mio indimenticabile personaggio Gobseck, dal naso grêlé o butterato, dagli occhi piccoli e pieni d’odi come quelli della faina.
L. R. Montecchi, Le “Prime” in Italia. “Vita pubblica”. Commedia in 4 atti di Emile Fabre, rappresentata per la prima volta in Italia al teatro “Argentina” di Roma dalla Compagnia Stabile, la sera del 17 febbraio, «La Maschera. Cronaca del teatro», Napoli, Anno IV, N. 8, 23 Febbraio 1908, pp. 6-7.
p. 6. Qualche nobile e isolato esempio di pura trattazione di politica e di affari in teatro, anche per il passato, non manca, basterebbe ricordare Il cittadino di Gand, dramma essenzialmente politico e nel quale anzi non partecipa alcuna donna, l’amico del popolo di Ibsen, il Mercadet di Balzac.
Nemi [La Redazione], Tra libri e riviste. Dostoievski e la Francia, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXIII – Della Raccolta CCXVII, Fascicolo 868, 16 febbraio 1908, pp. 732-733.
p. 733. Questa borghesia sciocca, che ritroviamo quasi intatta nelle opere di Balzac e di Villiers de L’Isle Adam, non ha – secondo Dostoievski – nemico alcuno.
Nemi, Tra libri e riviste. Lettere di Zola a Flaubert, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXIII – Della Raccolta CCXVII, Fascicolo 872, 16 aprile 1908, pp. 738-739.
p. 738. Lo Zola aveva dato all’Odéon nel 1874 un lavoro teatrale che aveva incontrato un insuccesso: in una lettera del 11 ottobre si lagna dei critici, che lo maltrattavano, mentre il pubblico non si dimostrava invece troppo scontento di lui:
«[…] Ils ont tous parlé de Balzac, et ils m’ont comblé d’éloges, à propos de livres qu’ils avaient éreintés jusqu’ici. C’est odieux, le dégoût me monte à la gorge ; il y a chez ces gens-là autant de bêtise que de méchanceté».
Nemi, Hugo, Balzac e l’Accademia francese, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXIII – Della Raccolta CCXVII, Fascicolo 873, 1° maggio 1908, p. 181.
È noto generalmente come Balzac cercasse invano di fare riuscir la sua candidatura all’Accademia di Francia. Egli cercò anche, come ci narra la Revue Hebdomadaire, d’officiare Victor Hugo a questo fine.
Il grande poeta discendeva in vettura la rue Saint-Honoré, quando Balzac, scorgendolo, si precipita alla portiera:
– Maestro, venivo a farvi una visita.
– Vi porto in vettura; salite.
– Venivo appunto per farmi portare in un posto da voi: all’Accademia. Osavo contare sul vostro voto.
– Ma certo! l’avrete.
Victor Hugo arriva alla seduta mentre si discuteva la candidatura di Vatout. Pongerville era accanto a lui, e scriveva il nome di Vatout sulla sua scheda.
– Vi prego – gli mormora Victor Hugo all’orecchio – scrivete «Balzac».
Pongerville scrive «Balzac», ma poi, sul punto di votare, esita, una scheda in una mano ed una nell’altra: Balzac o Vatout? e non sa risolversi.
Victor Hugo dà un colpetto sulla mano che teneva il nome di Vatout, e la scheda cade a terra. Pongerville si affretta a mettere il nome di Balzac nell’urna.
Ecco come l’autore della Comédie Humaine ebbe due voti all’Accademia francese, della quale, d’altronde, non fece mai parte. […].
Nemi, Tra libri e riviste. Carlo Del Balzo, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVI – Della Raccolta CCXX, Fascicolo 877, 1° luglio 1908, pp. 167-169.
p. 168. Sull’esempio, che era una gloriosa memoria, del Balzac e su quello vivente dello Zola, vagheggiò una specie di Commedia umana italiana, una serie di volumi sui nostri costumi contemporanei.
Nemi, Tra libri e riviste. Chopin e la sua Marcia Funebre, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVI – Della Raccolta CCXX, Fascicolo 878, 16 luglio 1908, p. 333.
Mi ricordo ancora, mi pare di vederle adesso, le faccie di coloro che udivano la musica sublime; su quella di Alfred de Musset le piccole rughe della fronte si scavavano in solchi profondi; quella di Balzac, esaltata e serena; quella di George Sand bianca come un cencio, la bocca semiaperta, i grandi occhi vividi come stelle […].
Nemi, Tra libri e riviste. Balzac e Napoleone, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVIII – Della Raccolta CCXXII, Fascicolo 886, 16 novembre 1908, pp. pp. 323-324.
Balzac è stato il Napoleone della letteratura francese; affascinato fin dall’infanzia dalla gloria e dal genio dell’imperatore, egli se ne è fatto in qualche modo il discepolo e l’emulo, come egli stesso ebbe a dire. Dotato di un temperamento che sotto alcuni riguardi somiglia al temperamento napoleonico, la sua opera presenta veramente qualche analogia coll’opera politica e militare di Napoleone – secondo, almeno, vuol dimostrare Stefan Zweig in un bell’articolo sulla Zukunft di Berlino.[8]
Honoré de Balzac nacque nel 1799, l’anno stesso in cui Bonaparte, reduce dall’Egitto, rovesciava il Direttorio e diveniva arbitro della Francia. Forse, fanciullo, egli apprese a leggere in quei bollettini che narravano le vittorie lontane in uno stile altero, che talora assumeva una dignità quasi romana. I sedici primi anni della sua vita – scrive Stefan Zweig – hanno coinciso dunque «con l’epoca più fantastica forse della storia del mondo». Si capisce dunque che una profonda impronta dovessero lasciare sul cervello di questo bambino i fatti d’una storia favolosa e inverosimile, che dinanzi alla Francia assunsero per molti anni forma di realtà. Questo fanciullo di genio, che sapeva riflettere e giudicare, aveva veduto un povero e oscuro ufficiale còrso divenire imperatore dei francesi e padrone di Europa; aveva veduto, sotto l’egida imperiale, tanti altri giovani di famiglie povere ed ignorate, un Murat, un Bernadotte, un Berthier, e tre fratelli di Napoleone, divenire re o principi sovrani.
E dopo i prodigiosi trionfi, egli aveva veduto le sconfitte e le catastrofi della fine, la Grande Armée annientata, gli alleati a Parigi, l’Imperatore decaduto e fuggitivo. D’altra parte, erano ancora vivi nel ricordo dei parenti, degli amici, del pubblico tutto gli orrori e gli sconvolgimenti della Rivoluzione: egli aveva tenuto fra le sue mani degli assegnati della Repubblica, biglietti da cento e da mille franchi che in sì poco tempo avevan perduto ogni valore; e, insieme, degli scudi d’oro con l’effige del re giustiziato, e altri recanti il sigillo repubblicano, e altri ancora che portavano impresso il profilo di un nuovo re. In mezzo a queste convulsioni che avevano sconvolto la morale, le leggi, lo stato sociale, le fortune, le frontiere, tutto ciò che per dei secoli era stato ritenuto durevole e fisso, come non avrebbe Balzac acquistato prematuramente il senso della relatività, della perpetua trasmutazione dei valori nella vita, secondo l’espressione felice di Nietzsche?
Come non avrebbe egli compreso, egli adoratore delle volontà forti e conquistatrici, che, oramai, tutto era possibile, che le più sfrenate ambizioni avevano delle probabilità di essere appagate, che ciascuno poteva aspirare a tutto, e che, essendo infrante le antiche tavole, il mondo apparteneva agli avventurieri che avessero saputo conquistarlo? – «L’esempio di Napoleone – scrive Stefan Zweig – ha scatenato nella nazione francese tutte quelle ambizioni, tutte quelle cupidigie febbrili lanciate alla conquista del potere e della ricchezza, che dovevano restare, per tanto tempo, i flagelli della Francia». Quanti personaggi di Balzac sono invasi – come il Julien Sorel di Stendhal – dall’ambizione più frenetica, dai più smodati appetiti?
***
Ed anche Balzac fu uno di quegli immensi ambiziosi, affascinati dall’esempio napoleonico e dei suoi luogotenenti. Nato qualche anno prima, egli avrebbe forse cercato sui campi di battaglia la potenza e la gloria; giunto all’età adulta sotto il regno relativamente pacifico e borghese di Luigi XVIII, egli volle conquistare con la penna il suo mondo.
Nella sua avidità gigantesca, egli disprezzò le apparenze della vita, i fenomeni particolari, quelle sfumature dell’anima individuale che ora dominano, da più decenni, il romanzo moderno, e si applicò a rendere la parte essenziale, il lato permanente della vita, tutto il misterioso congegno degli istinti fondamentali dell’anima umana. Dall’infinità varietà degli avvenimenti e degli individui, egli non volle estrarre che gli elementi essenziali e primordiali. «Egli volle fare entrare il mondo intero nel suo lambicco – dice il critico tedesco – per ricomporlo, ricrearlo in iscorcio, e animarlo col proprio soffio vivificatore».
***
Per realizzare un così smisurato disegno, bisognava che egli comprimesse le realtà umane per costringerle nella sua opera; togliesse loro ogni eccessiva complessità, le riducesse agli elementi del loro essere, in una parola, secondo l’espressione dello Zweig, che semplificasse e sistematizzasse il mondo.
Perciò tutti i suoi personaggi sono dei tipi; ciascuno di essi riassume, in alcuni tratti fortemente caratteristici, un numeroso gruppo d’individui. Le passioni essenziali sono le molle profonde della Comédie humaine; i tipi puri ne sono i personaggi, ed il mondo semplificato ne forma lo scenario e le quinte. Balzac applica alla letteratura il sistema di accentramento governativo che Napoleone aveva creato. Come l’imperatore, egli fa entrare tutta l’Europa nei limiti della Francia, e le dà Parigi per centro. Egli aggruppa l’umanità in un certo numero di mestieri, di professioni, di condizioni sociali, e riassume ciascuna di queste categorie in alcuni tipi molto caratterizzati, come il banchiere Nucingen, l’usuraio Gobseck, il medico Blanchon (sic), la principessa di Cadignan, e tanti altri. Egli non vuol conoscere tipi intermediarî; il suo mondo è più povero del mondo reale, ma esso guadagna in intensità ciò che perde in ricchezza.
È perciò che, pur ammirando l’opera titanica di lui, noi sentiamo talora un artificio nell’arte sua, le cui creazioni non ci commuovono, per esempio, come quelle di Flaubert o di Maupassant. Questi scrittori, direi, prendono un uomo singolo, con tutte le sue contradizioni, le sue particolarità, spesso disarmoniche fra loro, e cercano di ritrarlo così; Balzac invece plasma quest’uomo secondo una classe di uomini, secondo un tipo convenzionale. «Si potrebbe dire, mi sembra, che il tipo di Balzac, per usare il linguaggio della logica, è più vicino alla categoria che al concetto, e perde troppo di «comprensione», per quel che guadagna in «estensione». Infine, è un po’ troppo astratto per commuoverci».
Come Napoleone, Balzac conquista dapprima Parigi, poi stende la dominazione su tutte le provincie francesi (che son tutte rappresentate nella sua opera); quindi spinge gli eserciti vittoriosi attraverso l’Europa, dalla Spagna «(El Verdugo)» alla Norvegia «(Séraphitus)».
Per intermezzo, come Napoleone, fra due campagne, creava il «Codice civile» o formava il decreto di Mosca, Balzac ci dava il codice morale dell’amore e del matrimonio, e ci divertiva coi bellissimi «Contes drôlatiques».
Egli percorre il mondo, penetra ovunque, nella capanna e nella reggia, sui campi di battaglia e nelle Borse, e non v’è angolo della società del suo tempo che non sia stato rischiarato dalla torcia fiammeggiante dell’arte sua.
«Questa conquista del mondo realizzata nella «Comédie humaine», è un fatto – scrive lo Zweig – tanto «comico» nella letteratura moderna, quanto fu comica nella storia moderna l’epopea napoleonica. Balzac fanciullo aveva sognato di conquistare il mondo: il suo sogno divenne trionfante realtà. Egli aveva avuto ragione di scrivere sotto un ritratto di Napoleone: «Ce qu’il n’a pu achever par l’épée, je l’accomplirai par la plume».
La Nuova Commedia Umana [Paolo Valera], [L’autore della nostra copertina], «La Nuova Commedia Umana. Giornale illustrato», Milano, Anno I, Num. 1, 16 Gennaio 1908, p. 1.
[Su Rodin].
L’autore della nostra copertina è un caposcuola, un novatore, un plasmatore d’argilla balzachiano, un modernista che ha sbarazzato il marmo delle idee canute per trasfondergli la personalità umana. […].
Ecco Balzac. Guardatelo bene. E’ sulla copertina. Il vecchio scultore gli avrebbe dato un’aria domenicale. Lo avrebbe mandato in pubblico in redingote come Gambetta o in sortout come Manzoni, o in frocoat come Gladstone, magari con una penna o un libro in mano.
Volgetevi un’altra volta al Balzac di Rodin. Egli è vivo, è in azione, è tutto saturo di forza naturista. E’ nella sua veste di burro come un domenicano, nella sua atmosfera, nella sua officina, in piena concezione.
Le maître della letteratura naturalista si è appena mosso dal tavolo, ha fatto qualche passo ed è trattenuto dal pensiero che continua il capitolo della pagina che andrà a riprendere. Egli freme della sua vita intellettuale e rende a noi tangibili i suoi sentimenti impalpabili.
La Nuova Commedia Umana [Paolo Valera], La presentazione del grand’uomo che mi ha dato il titolo, «La Nuova Commedia Umana. Giornale illustrato», Milano, Anno I, Num. 1, 16 Gennaio 1908, pp. 5-10; ill.
Il mio è un sogno. Non si può condensare Balzac. E’ come riassumere l’esistenza di un popolo.
Perché l’autore della «Commedia Umana» non è un uomo. E’ un’epoca, un’opera vasta, immensa, ciclica, è un secolo di vita vissuta da parecchie generazioni, è tutta la storia del suo tempo.
Più lo si studia e più sfugge al compendio. I suoi volumi riproducono la nazione nei suoi commerci, nelle sue industrie, nelle sue manifestazioni intellettuali e sociali. C’è in essi la vita privata, la vita di provincia, la vita politica, la vita militare, la vita parigina con i tumulti, con le conflagrazioni, con gli attriti, con gli affetti, con i vizii, con le virtù, con le tragedie delle classi di una stessa atmosfera che si cono contesi il benessere e la felicità con gli adulterii, con i giochi di borsa, con i prestiti usuratizii, con la volontà, con l’inerzia, con la scaltrezza, con l’inganno, con la furberia, con la spensieratezza, con la prodigalità e con l’ingegno di tutti i tempi.
Nella testa di Balzac si è come in una enciclopedia. Se da un incendio non si fosse salvata che la biblioteca balzachiana noi tutti avremmo potuto ricostruire la Francia del XIX secolo, senza perdere una figura, un mobile, un edificio, un abito, un intingolo, un veicolo, una pettinatura, una camicia da notte, una moda, un vocabolo per ambientarlo.
E come non è possibile epitomizzare il gigante che ha avviato il romanzo sullo stradone del verismo che diminuendolo, così non è possibile plasmare o profilare intellettualmente l’uomo dalla testa piena di anomalie geniali che penetrando nella sua grandiosa concezione.
Sinora l’artista non è venuto – l’artista che sappia capire il lavoratore formidabile che ha riversata la vita di tutto un popolo nell’argilla modellata con le sue mani, colorita con la sua tavolozza, portata sulla piattaforma con le sue braccia, drammatizzata e fusa nel bronzo dei suoi pensieri. Tranne la statua di Rodin, non abbiamo avuto che aborti.
La testa del Balzac era una testa possente, tutta ammantata di bellezza intellettuale, con una capigliatura voluminosa e nera come il carbone, mescolata di fili bianchi che traducevano le sue notti di composizione, con il suo faccione rotondo, carnoso, pieno, illuminato da pupille più nere dei capelli, violentato dai colori che si succedevano passando dal giallo puro al rosso acceso, con le sue labbra sensuali e sature di sangue vivo, con i peli disseminati per le guance che gli davano un’aria di cignale giocando, con le sue spalle da pugilatore nel saio di panno bianco che lo lasciava credere a tavolino un personaggio di monastero. Tra lui e gli altri c’era la differenza che passa tra il nano e il colosso.
Balzac torreggiava, signoreggiava, ingigantiva dappertutto.
La sua voce si faceva udire in ogni sala, fosse dai Roschild (sic) o al Vèry (sic), il restaurant degli eleganti della Parigi di Luigi Filippo. Le sue risate che prorompevano clamorose gli caricavano il collo di salute e gli scoprivano i denti solidi, come se avessero voluto partecipare anch’essi, con la loro bianchezza, alle sue eruzioni convulsionarie. Bastava vederlo a tavola. Mangiava a quattro ganasce, con ingordigia. Divorava la carne fino all’osso, vuotava i bicchieri colmi di vini prelibati d’un fiato, voltava via più di una alzata di frutta tra una facezia e l’altra, beveva una, due, tre tazze di moka conversando, fumando, mettendo tutti di buon umore.
Non ha avuto la malinconia di diventare vegetariano che una volta. Stava scrivendo un trattato sugli eccitanti moderni e diceva agl’invitati che i legumi erano pasti nutrienti che mantenevano libera la mente da ogni pesantezza o torpore.
Fra gli invitati erano Théophile Gautier e Gerard di Nerval (sic). Il pranzo è stata una risata dalla prima portata all’ultima. Minestra di cipolle, purée di cipolle, cipolle in guazzetto, cipolle con tartufi, tortelli di cipolle, ecc. Due ore dopo erano tutti malati e Balzac che aveva l’abitudine di abbandonare gli ospiti in sala per alzarsi alle due di notte, saliva la scala del piano superiore e andava a dormire con risate che precipitavano dalla scala come tanta allegria.
In tempi in cui vivevano Alessandro Dumas, padre, Victor Ugo (sic) e Sainte-Beuve – tre atleti della produzione letteraria – Balzac senza avere la memoria prodigiosa del primo, la velocità e l’abbondanza stilistica del secondo, e la forza di leggere e l’erudizione del terzo, è riuscito il più tenace, il più resistente, il più fecondo, il più grande, il più completo dei romanzieri che abbiano archiviata la vita dei loro contemporanei.
La febbre del lavoro l’ha preso in una soffitta a vent’anni e non l’ha lasciato che a cinquant’anni, nella sua casa sontuosa dell’avenue Fortunée (divenuta via Balzac), quando aveva le gambe gonfie, quando l’idropisia gli è salita al cuore e il rantolo lo ha illividito e soffocato come un uomo comune.
E con la resistenza a tavolino che gli ha permesso di scrivere la «fisiologia del matrimonio» dal primo settembre al dieci novembre 1829 e «Cesare Birotteau» dal 17 novembre al 15 dicembre del ’37, c’erano in lui una coscienza e una consapevolezza di scrittore che lo rendevano incontentabile. Correggeva e ricorreggeva sulle bozze fino alla disperazione dei compositori. Rifaceva i lavori, sempre sulle bozze, dieci, quindici, diciotto, fin venti volte e se le maledizioni delle stamperie non glielo avessero impedito li avrebbe rifatti parecchie volte ancora. C’è in me qualche cosa, scriveva a un suo editore, che lo affrettava e si lamentava, qualche cosa che mi impedisce di fare coscienziosamente male. Il suo metodo di scrivere e di correggere era il terrore di tutte le tipografie. Scrivere alla Balzac voleva dire una calligrafia scellerata, confusa, medicata, piena di gocce d’inchiostro, con ramificazioni da tutte le parti. Correggere alla Balzac voleva dire una carta geografica con le città, i fiumi, le montagne ingarbugliate dai fili trascinati in tutti i sensi da un gattino indiavolato. Aggettivi, sostantivi, verbi, pensieri, frasi che si ricorrevano in ogni direzione. Parole cambiate, cancellate, rinnovate, sottolineate, incrociate, allacciate, sovraposte, riunite da una pioggia di arabeschi. Questa è forse stata la ragione che l’ha indotto ad aprire una propria stamperia, dove i lavoratori del libro potevano abituarsi al suo manoscritto e a tacere anche se il padrone rifaceva le bozze cento volte.
Balzac non aveva goût per la miseria. Sapeva quello che valeva la sua penna e non consegnava i suoi manoscritti, anche se sgorbiati, se non gli si davano molte migliaia di scudi, tanto è vero ch’egli è stato il primo a protestare contro il pillage editoriale dei lavori cosidetti di fantasia. La pirateria lo indignava. Voleva che il lavoro intellettuale fosse rimunerato. I Charpentier, i Werdet, gli Houssiaux hanno dovuto pagare i suoi romanzi con tavolate di napoleoni d’oro. L’autore non era né il Golbseck (sic) né il Grandet dei suoi romanzi. Spendeva. Amava il fasto del gran signore che si circonda di un patrimonio in tele, in bronzi, in vasi, in porcellane, in tappeti, in bibelots che costano gli occhi della testa. Possedeva una carrozza principesca per le giornate di gala, andava fuori sovente in coupé, guidato dal cocchiere corpulento, nella ricca livrea marrone dai bottoni dorati, con le iniziali del padrone in rilievo. E dal dorso del coupé aveva il groom fatto venire a bella posta dal Lilliput per portare i suoi messaggi, spalancare le portiere delle sue vetture e gli usci dei suoi appartamenti. Aveva i gusti del Rochefort d’oggi. Lo si vedeva sovente nei negozi degli antiquarii e dei libri usati e nuovi. Aveva un palco all’Opera degli italiani e un palco al teatro della grand’Opera. Ma anche nei giorni dei suoi splendori lavorava le sue quindici ore come nei giorni in cui le sue speculazioni commerciali gli avevano ammucchiati debiti sopra debiti.
Molte donne sono intorno al banchetto intellettuale di Balzac. Ma la preferenza è sempre stata per la maritata, per la donna che godeva l’amore in tutta la sua espansione, che congiungeva alla sentimentalità le gioie della passione fisica, che sentiva nella polpa umana le intensità che stordiscono e s’impadroniscono dell’uomo. La donna maritata ha amato l’autore della fisiologia del matrimonio con fervore, con devozione, con ammirazione, con soggezione. Lui e lei erano convinti che la felicità fosse la fine che devono proporsi i popoli. Cito le figure più note: la marchesa di Castries, madame di Berny, madame Carraud, madame Hanska … La seconda ha avuto più posto nel cuore di Balzac. «Madame di Berny, quantunque maritata, è stata un Dio per me. E’ stata una madre, un’amica, una famiglia. E’ lei che ha fatto lo scrittore, che ha consolato il giovine, che gli ha dato un gusto, che ha pianto come una sorella, che ha riso fra le mie braccia. Ella veniva a vedermi tutti i giorni e il suo ricordo è incancellabile dalla mia vita». L’ultima, divenuta vedova, ha finito per sposarlo. Ma i pochi mesi di sposalizio lo devono avere smagato. L’amore coniugale è diverso. Nell’ultima notte, quando il grande uomo rantolava e moriva «madame era andata in uno dei suoi palazzi per non annegare nell’odore di cadavere diffuso per la casa prima che morisse». Coloro che l’hanno veduto negli ultimi momenti, curato solo dalla sorella e dai domestici, si sono sentiti stringere il cuore. L’isolamento di Balzac nell’ultima ora è in una pagina immortale di Victor Hugo. Inutile! la donna che passa al maritaggio si pietrifica in un egoismo che disgusta. L’amante invece è una fiaccola che non si spegne mai.
Oimè! il genio avvelena l’esistenza di chi lo possiede. La critica dei contemporanei che fanno l’opinione pubblica è implacabile contro gli uomini che si elevano sugli uomini. Il capo lavoro la indispone, la incollerisce, la inferocisce. Non appena lo ha in mano lo deturpa, lo denigra, lo sventra e lo denuncia come un libraccio mal cucito, mal scritto, carico di sciatterie e di nonsensi. L’odore ambientale nella fraseologia diventa delitto, la sintassi che rompe le dighe dei carabinieri della grammaticheria ufficiale circonda l’autore di ridicolo, i neologismi vivi e sani sono frantumati come ciarpame. Balzac ha subìto tutto il torrente degli improprii del suo tempo. I Jules Janin e i Chaudes-Aigues gli sono andati addosso come mastini per morderlo, addentarlo, disfarlo a pezzi. Lo hanno svillaneggiato mettendolo al disotto dei Federico Soulié e degli Eugenio Sue – due orribili scrivendoli che si sono arricchiti senza stile, senz’arte, senza letteratura – ammonticchiando solo della zavorra, delle narrazioni fantastiche con dei paradossi o virtuosi o cinici, con un materialismo svergognato o con un umanesimo burlesco o con dei personaggi di cartone, imbottiti di stoppa, animati dall’improvvisazione che masturba tutto.
Ma gli aboyeurs sono morti. E la Francia del suo tempo è la Francia di Balzac. E’ la vendetta dei forti sugli idioti. Ma ohimè! La gloria viene troppo tardi per coloro che come Balzac sanno movimentare tutta una nazione con la penna e vogliono contemplare la propria statua prima di morire, come compenso alle loro fatiche. Perciò i Lausteau (sic), critici e apprendisti di quotidiani e di riviste nella Commedia balzachiana, mi fanno ancora fremere. Li odio come e più di Zola.
Ugo Ojetti, Louis Bertrand. Gli italiani a Marsiglia, «Corriere della Sera», Milano, Anno 33°, Num. 3, 3 Gennaio 1908, p. 3.
Da Dante a Balzac, la vera e durevole opera d’arte è stata sempre fondata non solo sull’osservazione analitica degli individui attorno e dei loro volti e delle loro manie e delle loro passioni, ma anche sull’osservazione dei fatti e delle crisi politiche e sociali.
Paolo Orano, George Sand, in I Moderni. Medaglioni di Paolo Orano. Volume Primo. Parte Seconda, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1908 («Biblioteca storica»), pp. 166-174. [1904].
p. 167. L’anno [1804] era immane. […] Balzac e Victor Hugo erano bambini; ma la voce nova della vita gridava nelle arterie di chi veniva alla luce. […].
p. 170. […] Che in «Lelia» (sic), trascinata dalla furia del piacere, quella donna che era una madre, quella dominatrice di un’epoca che esercitò l’apostolato della rigenerazione sociale ed ha fatto piangere, con le sue pagine sante, come Sue, come Hugo, come Balzac, abbia osato tentare con febbrili mani colpevoli le vie più arcane dell’amore unisessuale. […].
p. 172. […] nel suo studio stravagante, Balzac e Sainte-Beuve vanno a trovare l’incredibile maschio che ha «le cigare à la bouche»; […].
Zola, pp. 207-240. [1902].
p. 214. La prima esperienza dello scrittore arricchitosi e divenuto celebre trent’anni dopo quanto il Voltaire e quanto il Balzac, si è fatta nei bassi fondi parigini […]. Quel mondo di spostati e di criminali, ove già Balzac ed Hugo avevano cacciato gli occhi assetati di straordinario e spesso impossibile naturalismo, ha ingigantito l’anima sana di chi poi scriverà il libro terribile della suprema grandezza ed infelicità del popolo. […]
pp. 218-223. E dopo l’Assommoir la traccia segnata da Honoré de Balzac e seguita da Gustave Flaubert con così luminosa orma, si è ridistesa nel plauso del mondo. […].
Va da sé che non si può dimenticare Balzac trattando di Emilio Zola. […] In Balzac c’è il figlio legittimo dell’abate Prevost (sic) e di Denis Diderot. […]. Onorato Balzac è il parto della società che si divincola, politicamente tra la eredità dell’ancien régime e le novità repubblicane, letterariamente tra il misticismo risorto a suon di campane nuove dello Chateaubriand e la generosa canzone goliarda del Béranger. Balzac conserva la storia e il sentimento, la fantasia e il colpo di scena, i sogni e i miracoli; ma la sua storia è ricostruzione, il suo sentimento è osservazione, la sua fantasia non esce, per una combinatoria di meccanismi artistici mirabili, dai confini del possibile, i suoi sogni spiegano i suoi miracoli. Caterina II, la madre medicea dei tre francesi, è una ricostruzione perfetta; e la Dernière Fée è una creatura soave, è una donna che consola del suo amore la vita cruciata di un ammalato di sogni vivente e vero.
Il Balzac ha dovuto lottare contro l’impeto oceanico del suo genio inventore e il gusto dei contemporanei e la vivacità sopravvivente dei ricordi della vecchia letteratura gesuitica anche nel materialismo, o nella più sottile e febbrile descrizione del vizio. Ma, dal fondo, la società del Direttorio e di Napoleone, – quella strana società della mannaia che si era imposta, nella stanchezza, un curiosissimo dovere di ordine burocratico e blasonato – si mutava. Il grande artista, cresciuto tra un solco e l’altro, ne aveva percezione verace, onde son veraci Le père Goriot e Vautrin e Rastignac, tre risultati della determinazione sociale nuova. Nei quasi cento volumi balzachiani vivono tremila personaggi. È una folla che si fa da sé, analizzata, rappresentata, raccogliendosene gli individui componenti qua e là. Vi sono tutti i tipi, e, sopra un terreno incerto, la generazione che deve andarsene combatte le ultime battaglie e scambia le ultime menzogne con la generazione nuova che vuol prenderne il posto. Una società come quella, matrice di tutte le altre società storiche, ha i minimi ed i massimi di moralità e di capacità. Ecco perché la scena di questo artista incommensurabile – al quale si incomincia a credere che l’antichità possa solo in parte paragonare i suoi celebrati autori – è invasa dai rappresentanti di ogni classe sociale, di ogni condizione morale, di ogni temperamento, e diventa la riprova molteplice delle combinatorie più interessanti delle passioni e delle virtù, degli ideali e dei calcoli, l’algebrismo arduo delle potenze più disparate, dei valori più varii, il documento artistico più scientifico che la umanità abbia mai potuto avere.
Senza Balzac la storia del secolo XIX è impossibile. Sarebbe un teatro senza retroscena, una piazza dipinta e non costruita, una analisi senza possibilità di rappresentazione viva e sicura; sarebbe un abisso incolmabile. E Balzac è più grande di Zola?
La domanda è un colpo di spada diritto ma insidioso. Certo Balzac ha un orizzonte più vasto rappresentativamente; egli guarda il passato e rammemora le colorite chimere evanescenti di epoche ideologiche. Eppoi Balzac e (sic) più vario nella molteplicità dei personaggi e nella maniera di colorirli.
Di quando in quando un raggio folgorante e generoso di umorismo rompe la prospettiva grigia o almeno solenne della narrazione. E balza in prima linea coi suoi gai bubboli argentini il giullare chiassoso dell’esprit gaulois. È il sangue di Pantagruel che riferve un istante; il bicchiere di Borgogna che accelera ed accresce il flusso al cuore. Balzac capisce molto la storia e, dentro, i suoi fenomeni, l’architettura, la forma politica, la letteratura, e perfino l’album dei costumi e il briquabraquismo delle manie collazionatrici.
L’arte zoliana, invece, è nel tema e nei quadri più limitata e più rettilinea. […].
Se Balzac era un filosofo, quantunque positivo o un fisiologo generale, Zola è un istologo. È il microscopista dopo e accanto all’anatomico. […]. Balzac aveva incominciato a rivelare ed a rivelare i lati materiali uniti in una connecessarietà con i fenomeni psichici: il colore del tempo, l’architettura delle vie, il tipo del mobilio, la foggia dei vestiti, la fisonomia delle persone, l’età, le malattie, le condizioni economiche, morali, religiose e giuridiche; tutto quello che è umano. Ma Balzac, eccetto qualche stupenda eccezione, accennava, a sbalzi, tratteggiando a linee larghe, come se non lo preoccupasse che la verità e la forza suggestiva dei limiti. Zola, invece, è il cesellatore scrupoloso dei particolari, il gareggiatore della fotografia e della documentazione tecnica di verità scientifiche. […].
pp. 226-228. Tra Onorato Balzac ed Emilio Zola sta l’anello di congiunzione che garantisce la continuità del metodo durante il secolo XIX. […].
M.me Bovary, derivata da una delle disperate attitudini del balzachismo, piantò il segno rinnovatore nel romanzo d’arte. […].
La povera donna – povera se capire è perdonare e il genio di Balzac, di Flaubert e di Zola intendeva sopratutto il perdono – muore nell’angoscia. […].
pp. 232-233. Zola è un caso tipico di cerebrazione tarda: è l’opposto di Hugo, di Balzac, della Sand. […] Balzac pure è stato un forte analitico: ma la incomparabile effervescenza mnemonica dell’autore della «Commedia umana», lo metteva in condizione di servirsi d’un tratto, senza falsariga, di quella riserva immane di nozioni e di impressioni che aveva accumulata, vivendo una vita furibonda, leggendo di tutto e di tutte le epoche. E poi Balzac era una mente storica quasi erudita. Zola è stato una mente di biologo priva della visione del passato. Si avvicina a Flaubert che, in fondo, è il suo maestro diretto. […].
Come risulta chiaro, Onorato Balzac e Gustavo Flaubert hanno preparato il terreno. […].
pp. 235-236. Zola è […] qualche cosa di più di un artista pensatore. Egli è anche il filosofo dell’epoca operaia, lo scienziato dei misteri del popolo […].
Da tale lato Emilio Zola, che abbiamo veduto meno erudito ed immaginativo in senso tradizionale del Balzac, lo supera. E lo supera sviluppando una tra le infinite attitudini mirabili di chi pose con la figura eroico-borghese di Eugène de Rastignac il primo cardine dell’analisi diretta nella evolvente società contemporanea. Balzac è intuitivo; Zola è scientifico tecnico. Il primo arriva provvisoriamente, dal ciarpame del vecchio materiale letterario agli ardimenti del tema verista della tesi materialista e dell’arte libera e nuda; il secondo esce, col passo lento e sicuro dell’assistente anatomista e microscopista, munito di un mezzo linguistico che il mondo non conobbe mai così perfetto, dal dottrinarismo schematico della scienza, e cerca ove si pena e si bestemmia e non si ragiona e si uccide e si pervertisce e si muore lividi e laceri, la prova, il documento, la verifica, l’esperimento. […].
Il titano di Médan ha cresciuto un potere alla Francia; ha illuminato un nuovo orizzonte alla lingua di Voltaire e di Balzac.
Angelo Pizzini, Il cuore di Baudelaire, «Rivista d’Italia», Roma, Anno XI, Fasc. XI, Novembre 1908, pp. 835-855.
pp. 835-836. In un certo giorno dell’anno 1840 due uomini si avanzavano per un «quai» qualunque della riva sinistra della Senna. Erano il giovane poeta ancora ignoto dei (sic) «Fleurs du Mal» e il già illustre autore del «Père Goriot».
Narra il Prarond che Baudelaire si fermò dinanzi a Balzac e gli sorrise come se lo conoscesse da lungo tempo. Balzac pure si arrestò e gli rispose col suo riso franco, tendendogli la mano come ad un vecchio amico Era la prima volta che si vedevano, ma, conosciutisi così tutto ad un tratto, cominciarono tosto una di quelle conversazioni strane in cui una sola parola, un solo gesto dischiude moltitudini di sogni, di idee, di fatti profondamente osservati e ... mentre l’uno cercava invano di stupire l’altro, la discussione faceva sprizzare scintille di verità ignote.
Da quel
tempo, forse, non si son più riveduti, ma in quel giorno presentirono i due
artisti i loro tragici destini, i due suicidi che, nei poli opposti,
rappresentano tutta la graduazione del volere umano! Presentì quegli che sin da
fanciullo ebbe l’audacia di scrivere un trattato sulla volontà e che ad una
riunione nella quale si discuteva intorno agli effetti dell’haschisch,
rifiutò recisamente di abbandonarsi anche per un solo istante alle
attrazioni del
dwameseck, presentì che dovea morire per eccesso di lavoro, vittima di un
conato supremo contro se stesso? E l’altro, il giovine ed elegante
dandy dell’hotel Pimodan, che sorrideva o meglio ghignava allora come
Mefistofele, presentì che doveva precipitare poi d’abisso in abisso sino agli
ultimi confini dell’abulia e scrivere col suo sangue una delle pagine più
dolorose della letteratura francese «Mon coeur mis à
nu»?
Joseph Poerio, Dix-neuvième siècle. I. Les Prosateurs français depuis le Consulat jusqu’à nos jours (1800-1850). Balzac, 1799-1850, in La France littéraire. Morceaux choisis des principaux écrivains français depuis Malherbe et Pascal jusqu’à nos jours avec introduction, notices biographiques et notes explicatives par Joseph Poerio. […]. Vingt-quatrième édition, Naples, Charles Preisig, Libraire Éditeur, Turin-Milan-Rome-Florence, Chez J.-B. Paravia & C.ie, 19o8, p. 368.
Alle pp. 368-371, è presente un estratto di Eugénie Grandet.
Cfr. 1872; 1878; 1896; 1898.
Ernesto Ragazzoni, Un pomeriggio nella biblioteca di Péladan, «La Stampa. Gazzetta Piemontese», Torino, Anno XLII, Num. 31, 31 Gennaio 1908, p. 3.
[Péladan] segnava all’obbrobrio, all’esecrazione universale una «femme Rothschild» la quale non si era peritata di demolire sacrilegamente una casa che fu abitata da Balzac […]. […].
Chi osava, chi voleva riconoscere, che questo fanatico, questo visionario, questo eccentrico era, nel romanzo, il più diretto continuatore della Comédie Humaine balzacchiana?
Ernesto Ragazzoni, Delinquenza parigina, «La Stampa. Gazzetta Piemontese», Torino, Anno XLII, Num. 54, 23 Febbraio 1908, p. 1.
Par di essere [nel centro di Parigi] in quei labirinti di vicoli che Gustavo Doré ha disegnato pei Contes drôlatiques di Balzac.
Ernesto Ragazzoni, La gloria per decreto legge, «La Stampa. Gazzetta Piemontese», Torino, Anno XLII, Num. 88, 28 Marzo 1908, p. 3.
E chi crea questa gloria: il culto di un popolo, o la passione di una setta?
Balzac, il quale seppe raccogliere in una maravigliosa sintesi tutti gli elementi della società e della vita moderna, Balzac, il Guglielmo Shakespeare del romanzo, non figura al Pantheon. […]
Perché Zola, piuttosto che Balzac, che Flaubert, che Taine, che Michelet, che Berlioz?
Ernesto Ragazzoni, La corsa all’immortalità, «La Stampa. Gazzetta Piemontese», Torino, Anno XLII, Num. 330, 27 Novembre 1908, p. 3.
E’ vero che si può essere grandi ed immortali anche senza l’Accademia (e Balzac per esempio, ha dimostrato che se ne può far senza) ma tutti coloro che non sono Balzac (e ce ne sono) non indegnano per nulla questa ipoteca sulla gloria futura, e trovano assai meglio e più profittevole incontrarla subito. […].
E Balzac, appartenne forse all’Accademia? […].
Non c’è nemmeno stato Molière!
Rodolfo Reiner, Scorrendo il carteggio dello Stendhal, «Fanfulla della Domenica», Roma, Anno XXX, N. 24, 1° Giugno 1908, pp. 1-2.
p. 2. L’elogio sperticato che della Chartreuse de Parme fece il Balzac, conciliò al Beyle le simpatie dei veristi, ultimo dei quali scese in campo ad esaltarlo, ma con più criterio e più moderazione del Balzac, lo Zola. […].
Tocchi realistici eccellenti non mancano qua e là, ed eran quelli che
facevano andare in visibilio il Balzac; ma nel suo complesso il libro è
illeggibile.
Edouard Rod, Le attuali tendenze della letteratura francese (1), «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XVIII, Vol. XXVIII, N. 20, 26 aprile 1908, pp. 467-469.
(1) Da un articolo di Edouard Rod, in Contemporary Review, aprile.
p. 468. Paul Bourget ci mostra, da solo, una strana evoluzione; nel 1885 egli ci presenta, con Cruelle énigme, un esempio dell’antico romanzo analitico, mentre nelle ultime opere egli sembra ravvicinarsi a Balzac.
Ettore Romagnoli, Libri di versi, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVIII – Della Raccolta CCXXII, Fascicolo 888, 16 dicembre 1908, pp. 588-601.
p. 600. Oh dunque un poeta non ha diritto di scegliere un argomento campestre? […].
Ecco, io credo fermamente che la vita dei contadini d’oggi sia quella che descrivono Zola nella Terra o, per lo meno, Balzac nei Paesani.
Onorato Roux [a cura di], Illustri Italiani Contemporanei. Memorie giovanili autobiografiche di letterati, artisti, scienziati, uomini politici, patrioti e pubblicisti raccolte e corredate di cenni biografici da Onorato Roux. Edizione popolare. Volume I – Letterati, Parte seconda, Firenze, R. Bemporad & Figlio Editori, 1908.
Ida Baccini, pp. 165-189.
p. 185. Da quei maghi dello stile [Daudet, Theuriet, Loti] risalii dolcemente la corrente e mi «sprofondai» – in Teofilo Gautier, nella Sand, in Victor Hugo, in Alfredo de Musset e nel divino insuperabile Balzac, di cui lessi, in poche settimane, tutta la «Comédie humaine». Cfr. 1904.
Clarice Tartufari, pp. 251-265.
p. 251. Poi scrisse per il teatro.
Fra le sue opere principali cito: […] L’opinione di Balzac, scherzo comico in 1 atto, (1904) […].
Sfinge, Adelaide Cairoli, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVII – Della Raccolta CCXXI, Fascicolo 884, 16 ottobre 1908, pp. 598-614.
p. 599. Taine dice che la storia è psicologia e che dovrebbero scriverla solo coloro che, per intuito generale, conoscono profondamente l’anima umana.
Secondo Taine gli storici ideali sarebbero Shakespeare e Balzac.
Scipio Sighele, Leggendo Balzac, «Nuova Antologia di Lettere, Scienze ed Arti», Roma, Direzione della «Nuova Antologia», Quinta Serie, Volume CXXXVIII – Della Raccolta CCXXII, Fascicolo 886, 16 novembre 1908, pp. 161-183.
Or sono sette anni Vincenzo Morello in un articolo della Nuova Antologia (1)[9] constatava che, malgrado i suoi sforzi per richiamare l’attenzione dei positivisti italiani sull’opera di Balzac, questi non avevano ancora fatto oggetto dei loro studî quella selva di intuizioni psicologiche e di divinazioni antropologiche che è la Commedia umana: non il Lombroso, il quale nelle molte sue citazioni di letterati aveva sempre dimenticato il Balzac, – non il Ferri, che nei suoi Delinquenti nell’arte (dove pure scandaglio i volumi di tanti romanzieri e poeti) non aveva dedicato al Balzac che una linea, – non il Sighele, che nella sua Coppia criminale non aveva saputo citare i tipi di Vautrin e di Luciano di Rubempré come i più perfetti esemplari psicologici di delitto a due.
Vincenzo Morello aveva ragione nel suo rimprovero; e sei io non l’ho ascoltato prima d’ora, gli è perché era molto difficile trovare il tempo necessario per rileggere attentamente, per annotare e per commentare i cinquantadue volumi che, nell’edizione pubblicata in occasione del centenario della nascita di Balzac[10], racchiudono tutta la superba fecondità letteraria di un uomo che si intitolava a buon diritto professore di scienze sociali e che poteva senza esagerazione gloriarsi d’aver portato una società intera nel suo cervello.
Ora che ho avuto agio, in un periodo di quiete campestre, di rituffarmi nella Commedia umana e di rivivere la vita multipla e intensa dei suoi duemila personaggi, posso con serena coscienza di studioso rispondere all’invito del Morello e recare il mio modesto contributo all’analisi di quella che è forse la più vasta e più completa rappresentazione della vita che sia uscita dal genio di un uomo nel secolo scorso.
***
Balzac è stato troppo studiato – dal libro del Lamartine fino agli essays (sic) del Brunetière e del Bourget – perché io possa e voglia osare sulla sua vita e sull’opera sua un lavoro di critica.
L’uomo che aveva lottato e sofferto durante quasi tutta la sua esistenza, che aveva sprecato gran parte delle sue meravigliose energie correndo dietro a fantasmi di progetti e di imprese industriali ch’egli non raggiungeva mai, doveva spegnersi tra il lusso e gli splendori della ricchezza da lui tanto agognata e da così poco tempo raggiunta. La sua vita potrebbe rassomigliarsi ad uno di quei giorni torbidi di tempesta che si chiudono, quasi per miracolo, nella rosea luce di un magnifico tramonto improvviso.
Egli aveva scritto in gioventù alla sorella: «io ho due soli e immensi desiderii: essere celebre ed essere amato». Era questo per lui (e per chi nol sarebbe?) il binomio della felicità. Dio, in cui credeva, lo esaudì. Una straniera milionaria, una polacca ammirata del suo ingegno, si innamorò di lui, lo sposò, gli dette l’amore e la ricchezza. Il suo sogno d’essere amato fu breve perchè lo spezzò la morte; ma la sua fama s’allunga e s’infutura nel tempo e cresce ogni giorno. Oggi egli è riconosciuto un precursore e un maestro: oggi tutti volgono a lui lo sguardo, quando, infastiditi dalle mediocri opere dei piccoli contemporanei, vogliono rivedere un gigante e compiacersi nella contemplazione d’un’opera colossale.
Io non farò – ripeto – un lavoro di critica, ma semplicemente un lavoro di esumazione. Io cercherò di rievocare — fuor dalle migliaja di pagine in cui sono confuse e nascoste — quelle idee in cui Balzac riassumeva e sintetizzava non solo lo spirito e la morale dell’età sua, ma le verità psicologiche fondamentali della civiltà nostra. Io non compirò insomma altro che l’ufficio modesto del minatore, il quale trae alla luce e alla vita dall’oscurità profonda d’una miniera il metallo prezioso: io mi accontenterò di riunire con pazienza di orafo in una sola collana le perle che il genio di Balzac aveva sparse nel. l’opera sua.
Credo sia questo il modo migliore — poichè il più securo e il più sincero — di onorare un uomo e di interpretarlo. Di fronte alla produzione vasta e multiforme dei grandi scrittori, ove essi profusero con prodigalità da milionari i lampi della loro genialità, il commento più utile e più fecondo è appunto quello che si limita a riunire, ad organizzare le idee gettate qua e là alla rinfusa ed inconsciamente, a dare cioè unità di sistema, quasi direi dignità di filosofia, a dei frammenti che per sè soli avrebbero soltanto un valore e un significato relativo e parziale.
I. — La donna e l’amore.
Scriveva il Lamartine che due sono i caratteri dominanti dell’ingegno di Balzac: la verità e la moralità. Io vorrei aggiungere che questa sua moralità non era premeditata, nojosa e cattedratica, ma risultava come conseguenza necessaria dalla pittura sincera ch’egli faceva della vita, ed era sempre insaporita dall’umorismo o nascosta sotto una pungente ironia. Balzac non è mai predicatore perchè, a differenza di altri autori, egli non parla quasi mai in prima persona. La sua morale è espressa dai fatti più spesso che dalle parole; è quando voi vi arrestate pensosi leggendo un’osservazione profonda, è lo spirito di una signora o lo scetticismo d’un giornalista o il cinismo d’un delinquente che l’ha pronunciata. Balzac non esiste nei suoi libri: sono i suoi personaggi che esistono. Egli si è trasfuso in loro per uno di quei miracoli di auto-suggestione da lui magnificamente descritti nelle prime pagine di Facino Cane; e nell’opera sua voi non trovate l’autore, trovate la società intera ch’egli portava nel suo cervello e ch’egli fa parlare, agire, sentire con una naturalezza inarrivabile e inarrivata.
E poichè questi personaggi son molti e varii, poichè essi appartengono a tutte le classi sociali, poichè essi vivono a Parigi e in provincia, poichè essi sono di diverse razze, e gli incroci dell’eredità e le suggestioni dell’ambiente si confondono e si diffondono in esse, è tutto un mondo che s’agita intorno a voi, che palpita, ama, soffre, piange, sorride, delinque, - e danza intorno alla vostra fantasia una ridda gioiosa o paurosa che vi dà la delizia calma d’un sogno o l’angoscia febbrile d’un incubo ...
Dice, mi pare, il Bourget che la vita è «un volume de Labiche interfolié par du Shakespeare». Anche l’opera di Balzac, che è una fotografia della vita, merita questa definizione. Una sottile vena di umorismo e di spirito la pervade e la feconda, pur essendo qua e là interrotta dall’impetuoso torrente del dramma e della tragedia.
Bixiou, Blondet, de Marsay, Rastignac, - questi viveurs cui Balzac affida il compito di sgranare elegantemente il rosario della sua filosofia di uomo di mondo – o le signore, come la principessa di Cadignan o la duchessa di Maufrigneuse o Mademoiselle de Touche (sic) — cui egli lascia l’arguta prerogativa di criticare le debolezze del loro sesso – sono dei personaggi pieni di spirito che inghirlandano la loro piacevole esistenza con una conversazione picchiettata di epigrammi e di bons mots in cui è spesso racchiusa una profonda morale. In Francia tutto si fa ridendo, dice Balzac; e i suoi personaggi fanno, ridendo, anche della filosofia.
Volete sapere che cosa questi viveurs pensino dell’amore?
«L’amour est une religion, et son culte doit coûter plus cher que celui de toutes les autres religions: il passe promptement, et passe en gamin qui tient à marquer son passage par des dévastations». Eugenio di Rastignac che, per riuscire nell’arte di seduttore, vuole appena arrivato a Parigi — rinnovare la sua modesta guardaroba di provinciale, si consola e si giustifica con questa definizione: «l’amour et l’église veulent de belles nappes sur leurs autels».
La baronessa Nucingen, che mantiene Eugenio di Rastignac, cerca di vincere gli ultimi scrupoli del suo amante cui ancor ripugna di accettar danaro da una donna, con questo curioso ragionamento: «Autrefois les dames ne donnaient-elles pas à leurs chevaliers des armures, des épées, des casques, des cottes de mailles, des chevaux, afin qu'ils pussent aller combattre en leur nom dans les tournois? Eh bien, Eugène, les choses que je vous offre sont les armes de l’époque, des outils nécessaires à qui veut être quelque chose».
Più seria di Delfina Nucingen, la principessa di Cadignan non dà consigli ai suoi amanti, ma pronuncia sentenze: «Beaucoup de femmes — essa dice – sont plus aimantes que mères, comme la plupart sont meilleures mères que bonnes femmes. Ces deux sentiments, l’amour et la maternité, développés comme ils le sont par nos mœurs, se combattent souvent dans le cœur des femmes ...». La principessa non era più giovanissima quando esponeva questa verità: ella era al tramonto della sua carriera di mondana, ma non rinunciava ancora a provare sugli uomini la potenza del suo fascino. «Je connais un peu ces couchers de soleil – dice un giornalista: - ça dure dix minutes à l’horizon, et dix ans dans le cœur d’une femme».
E la stessa principessa di Cadignan che nel suo orgoglio di gran dama trova questa giusta definizione: «l’une des gloires de la société c’est d’avoir créé la femme là où la nature avait fait une femelle».
La Palférine, il principe della bohème, stabilisce in germe quel paragone tra la donna e il fanciullo che la psicologia doveva poi sviluppare e dimostrare scientificamente: «La femme est l’être le plus logique après l’enfant: tous deux ils offrent le sublime phénomène du triomphe constant de la pensée unique». E quest’osservazione è completata e integrata da quest’altra: «Le caractère de l’amour véritable offre de constantes similitudes avec l’enfance: il en a l’irréflexion, l’imprudence, la dissipation, le rire et les pleurs».
Che cosa è più variabile della donna e del bambino? Eppure la donna è più costante in amore che l’uomo. E fra le donne, le più fedeli sono quelle che dovrebbero esserlo meno. Le femmine perdute, amanti dei delinquenti, mostrano verso di questi una devozione che forse poche donne oneste saprebbero raggiungere: «C’est ce dévoument femelle accroupi fidèlement à la porte des prisons, toujours occupé à déjouer les ruses de l’instruction, incorruptible gardien des plus noirs secrets, qui rend tant de procès obscurs, impénetrables. Dans le langage des filles avoir de la probité: c’est ne manquer à aucune des lois de cet attachement, c’est donner tout son argent à l’homme emprisonné, c’est veiller à son bien être, lui garder toute espèce de foi, tout entreprendre pour lui ... Aucune passion d’honnête femme, pas même celle d’une dévote pour son directeur, rien ne surpasse l’attachement de la maîtresse qui partage les périls des grands criminels». E in realtà, pochi uomini onesti sono stati amati come lo sono quasi tutti i grandi delinquenti. «L’amour qui ne comporte pas une indissoluble amitié — dice Bixiou – me semble un libertinage momentané»: ma quanti sono, fra gli amanti, i casi di questa amicizia indissolubile? Forse alla porta del carcere essa si trova più facilmente che nei salotti.
Se le donne oneste, secondo Balzac, amano meno intensamente delle altre, gli uomini superiori sono amanti meno abili e meno fortunati dei mediocri e degli imbecilli. «On peut être un grand homme et un méchant, comme on peut être un sot et un amant sublime», dire la principessa di Cadignan che aveva forse bisogno di giustificare certe sue avventure; e la baronessa Nucingen sottolinea il pensiero dell'amica affermando: «L’amour est la seule chance qu’aient les sots pour se grandir». E pare che gli sciocchi abbiano molto spesso quest’occasione di ingrandirsi. Forse perchè essi hanno più tempo degli altri. « Il n’y a pas de vertu absolue. mais de circonstances», e l’imbecille disoccupato ha più tempo per ... approfittar delle circostanze, e per riscaldare al fuoco della sua passione l’apparente freddezza di quelle dame aristocratiche le quali, come dice de Marsay, «sont des poêles à dessus de marbre».
Questa è la filosofia – o l’esperienza – delle classi ricche, colte e spensierate. Non è molto profonda, perchè non tocca che una parte della psicologia umana, la psicologia del gran mondo. Ma, entro i suoi limiti, è esattissima. Più ampiezza e più universalità noi troveremo nella frase di Blondet: «la passion qui ne se croit pas éternelle est hideuse», e nell’affermazione dolorosa ma vera: «toutes les passions sont essenliellement jésuitiques». Più arguzia noi troveremo nell’osservazione di madame Rabourdin (l’eroina del racconto: Les employés): «en tout pays, avant de juger un homme, le monde écoute ce qu’en pense sa femme », e nell’irriverente aforisma di de Marsay: «il y a toujours un fameux singe dans la plus jolie et la plus angélique des femmes ». E sopratutto noi troveremo più geniale intuizione della facoltà che ha la donna d’indovinar dall’espressione del viso un pensiero nascosto, nella frase che spiega perchè Esther sorprendesse con uno sguardo i segreti del suo amante: «la connaissance du visage d’un homme est chez la femme qui l’aime comme celle de la pleine mer pour un marin».
Povera Esther! Ell’era una di quelle donne «qui se vengent par un luxe insensé d’avoir vécu de pommes crues dans leur enfance»; ma ella amava il suo Luciano come nessuna altra donna ha mai amato l’amante. La lettera ch’ella scrive a Luciano di Rubempré prima di avvelenarsi e di morire per lui (dopo essersi, per lui, venduta a Nucingen al prezzo di 750 mila franchi), è forse una delle pagine ove l’arte di Balzac è più completa, poichè unisce il brivido della commozione all’eleganza dell’umorismo. È una lettera che fa piangere, fa sorridere, fa pensare. Tutte le corde della lira umana sono toccate con una misura, con una delicatezza che solo il genio e l’amore possiedono. È un cuore di donna che si rivela, mescolando l’allegria della gioventù alle lagrime d'una moribonda, come un fiore ingentilisce la vivacità dei suoi colori con le goccie della rugiada. Esther, per rendere men triste la sua morte all’amico, la commenta pariginamente così: «Je t’ai dit un jour: il vaut mieux mourir à trente ans. Ce jour là, tu m’as trouvé pensive, tu as fait des folies pour me distraire, et entre deux baisers je t’ai dit encore: tous les jours les jolies femmes sortent du spectacle avant la fin! ... Eh bien, je n’ai pas voulu voir la dernière pièce, voilà tout!».
II.— La politica e il parlamento.
Ho voluto mostrare con alcune citazioni intorno a un tema che si presta alla più facile e alla più comune delle psicologie, quale fosse il modo e, direi, il metodo di Balzac per riamare sul canevaccio dei suoi racconti la trama ora spiritosa ora profonda delle sue osservazioni.
Ma il compito mio è più specialmente rivolto a ricercare quali fossero le idee di Balzac intorno ai delinquenti e in genere su tutti quei problemi di morale e di sociologia che la scuola positiva italiana ha risollevati anni or sono dal semplicismo spiritualista, il quale s'accontentava di spiegarli molto ingenuamente col libero arbitrio.
Se io volessi continuare nel divertente e forse utile ma inorganico lavoro di citare le varie definizioni che Balzac ha disseminate nei suoi volumi intorno ai più diversi argomenti, non mi basterebbero molte pagine. Egli ha parlato di tutto ed ha sentenziato su quasi tutto. Sull’arte che, secondo lui, non è che la natura concentrata; - sulla coscienza che, secondo lui, è un bastone che ciascuno adopera per battere il suo vicino, e del quale non si serve mai per sè stesso; - sugli istinti, i quali non sono che «dei fatti vivi la cui causa giace in una necessità subìta»; - sul pentimento, che la Chiesa cattolica sancisce col sacramento della confessione, e che non è se non «un’ipocrisia, un premio dato alle azioni immorali o colpevoli»; - sulla rassegnazione, che è «un suicidio quotidiano»: sul giornalismo ch’egli detesta perchè «è un inferno, un abisso di iniquità da cui non si può uscir puri altro che protetti come Dante dal divino lauro di Virgilio»; - sulla burocrazia, che è «un sipario pesante fatto scendere tra il bene che bisognerebbe fare e l’uomo di Stato che dovrebbe farlo»; - sulla diplomazia, «la scienza di coloro che non ne hanno alcuna e che sono profondi appunto perchè son vuoti»: — sull’ alta banca e sui grandi banchieri, «i quali sono dei conquistatori che sacrificano le masse per arrivare a dei risultati nascosti, e i soldati che sacrificano son gli interessi particolari», poichè, secondo la frase di Blondet, «il danaro degli stupidi è per diritto divino il patrimonio della gente di spirito ...».
Lasciamo queste boutades, e stringiamo più da vicino il pensiero di Balzac su problemi più importanti e più vitali.
Che cosa pensa egli – o che cosa pensano i suoi personaggi – del parlamento e della politica?
Come quasi tutti gli uomini superiori che non mendichino il favore del pubblico e che siano quindi sinceri nel loro orgoglio brutale, Balzac è uno scettico di fronte al parlamento, non perchè non ne riconosca in teoria i diritti (1), e non perchè non ne apprezzi i vantaggi per l’esercizio della libertà, ma perchè — profondo conoscitore di psicologia collettiva — egli sa che in pratica la sovranità della folla è spesso un equivoco o un pericolo: «Rencontrer un grand prince est un hasard, mais se fier à une assemblée quelconque, fût-elle composte d’honnêtes gens, est une folie». Questa frase non è che la traduzione inconscia dell’adagio antico: Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia. Ed è spiegata e giustificata da queste altre frasi, in cui mi sembra veder l’embrione di quella teoria psico-fisiologica del pànico che l’Espinas doveva illustrare mezzo secolo dopo: «La plupart des hommes, comme les animanx, s’effravent et se rassurent avec des riens». E ancora: «Certains publics sont influencés par la vocifération comme les palais grossiers sont excités par les liqueurs fortes». Non c’è in queste parole il perchè di molti comizii? Non c'è in germe quella psicologia della folla che solo in questi ultimi tempi doveva essere scientificamente studiata? Ma il Balzac va più oltre, e non solo intravede il meccanismo oscuro che fa parlare e deliberare le assemblee e le folle, bensì anche il meccanismo che le fa agire e pur troppo molto spesso — commettere eccessi e delitti. «Les partis commettent en masses des actions infàmes qui couvriraient un homme d’opprobre ». Perchè le commettono? e perchè, commettendole, anzichè la condanna e il disprezzo, esse suscitano l’elogio e l’ammirazione? Per la semplice ragione che fra la morale privata e la morale politica vi è un abisso che il giornalista Blondet spiega chiaramente così: «Il y a des actes arbitraires qui sont criminels d’individu à individu, lesquels arrivent à rien quand ils sont étendus à une multitude quelconque, comme une goutte d’acide prussique devient innocente dans un baquet d’eau. Vous tuez un homme, on vous guillotine. Mais avec une conviction gouvernementale quelconque vous tuez cinq cent hommes, on respecte le crime politique. Vous prenez cinq mille francs dans mon secrétaire: vous allez au bagne. Mais avec le piment d’un gain à faire, habilement mis dans la gueule de mille boursiers, vous les forcez à prendre les rentes de je ne sais quelle république ou monarchie en faillite, - personne ne peut se plaindre. Voilà les vrais principes de l’âge d'or où nous vivons ...».
Principî che son riconosciuti veri anche oggi, non solo perchè è vera anche adesso, e sarà vera in eterno, la sentenza di Napoleone che «les crimes collectifs n’engagent personne», ma sopratutto perchè anche oggi, malgrado le proteste verbali degli ingenui e dei gesuiti, tutti siamo costretti a constatare che le leggi le quali reggono la morale individuale non sono le stesse di quelle che reggono la morale politica. Constatazione dolorosa, certamente, ma che noi non possiamo negare, se non vogliamo ripetere la sciocca psicologia dello struzzo, il quale crede di evitare un pericolo mettendosi apposta in posizione da non vederlo.
Per le moltitudini come per gli individui, la politica ha un codice assai diverso da quello che guida la morale privata. Voler trasportare nei parlamenti o sui banchi del governo quei rigidi principii che ci dirigono nella quiete della nostra vita famigliare, è un non senso. Che farebbe un ambasciatore, il quale sì ricordasse che un gentiluomo non deve mentire mai? Che farebbe un gran capitano, il quale cristianamente e tolstoianamente seguisse il precetto: non uccidere? Che farebbe un ministro dell’interno, il quale durante un periodo elettorale lasciasse passare senza nessun atto di corruzione o di suggestione la volontà del paese? Tutti costoro sarebbero degli onesti ma degli inabili. Non sarebbero degli uomini politici.
Quand’io, anni or sono, ho osato affermare queste verità – dolorose, ma, ripeto, innegabili – fu un coro di disapprovazioni, quasi che la colpa fosse in chi rivela un fatto, anzichè in chi lo compie. Pur troppo, se molti si scandalizzarono a parole, ben pochi si scandalizzarono in realtà, e la vita politica dei nostri collegi elettorali continuò, e continuerà, a somigliare a quella di Besançon (vedasi il racconto intitolato Albert Savarus), dove, dovendosi scegliere fra un deputato modesto ma galantuomo e un deputato di grande ingegno ma senza scrupoli, si scelse naturalmente il secondo. «Ne valait-il pas mieux pour une ville – dice un elettore – avoir un de ces hommes destinés à gouverner, qu’une machine à voter? Un homme d’État apporte tout un pouvoir, le député médiocre mais incorruptible n’est qu’une conscience».
Già il Montesquieu aveva detto che la morale piccola cioè privata uccide la morale grande cioè politica, perchè dà degli uomini di governo onesti ma inabili. Balzac ripete il concetto e forse ripetendolo lo esagera. Lo esagera quando alla fine di un banchetto, tra i fumi dello champagne, fa lanciare a Blondet la definizione del vero uomo politico: «Un grand politique – dice Blondet – doit être un scélérat abstrait, sans quoi les sociétés sont mal menées. Un politique honnête homme est une machine à vapeur qui sentirait, ou un pilote qui ferait l’amour en tenant la barre: le bateau sombre. Un premier ministre qui prend cent millions et qui rend la France grande et glorieuse, n’est-il pas préférable à un ministre enterré aux frais de l’Etat, mais qui a ruiné son pays?».
Qualche cosa si ribella in noi leggendo queste parole troppo scettiche e troppo ciniche, e vorremmo che non fossero vere: vorremmo poter gridare che vi sono stati degli uomini politici di genio che non vennero mai meno a nessuna delle leggi della morale privata. Ma sarebbe vera la nostra ribellione? E ad ogni modo i casi — più unici che rari — che potremmo citare, non confermerebbero appunto coll’eccezione la desolante realtà della regola?
Balzac ha intuito quel rapporto inverso che esiste tra genio e moralità, tra cervello e coscienza. Egli ha intuito quell’oscuro duello che si compie nel mistero degli organismi e che può forse spiegarsi come una legge di distribuzione delle forze umane. «Egalement distribuée, la force humaine produit les sots ou la médiocrité partout: inégale, elle engendre ces fonctions disparates auxquelles on donne le nom de génie, et qui, si elles étaient visibles, paraîtraient des difformités. La même loi régit le corps: une beauté parfaite est presque toujours accompagnée de froideur et de sottise».
Questa legge d’ineguaglianza, che sopratutto s’appalesa in politica, dovei genî – da Cesare a Napoleone, da Richelieu a Bismarck non ebbero certamente l’equilibrio morale dei galantuomini, si manifesta anche al di fuori della politica, nel campo della scienza, delle lettere, delle arti. In senso fisiologico è vero che «tous les grands hommes sont des monstres», vale a dire dei prodotti eccezionali della specie umana. E anche in senso psicologico il genio è spesso un mostro, nel senso che a fianco della sua altezza intellettuale egli possiede una grande deficienza morale. Dice Claude Vignon a Luciano di Rubempré: «Le génie est une horrible maladie. Tout écrivain porte en son cœur un monstre qui, semblable au toenia dans l’estomac, y dévore les sentiments à mesure qu’ils y éclosent. Qui triomphéra? La maladie de l’homme ou l’homme de la maladie? Certes, il faut être un grand homme pour tenir la balance entre son génie et son caractère. Le talent grandit, le cœur se dessèche. A moins d’être un colosse, à moins d’avoir les épaules d’Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent».
Magnifiche frasi, dove, in forma poetica, noi sentiamo quasi l’annuncio della teoria lombrosiana sui rapporti del genio colla follia. Il genio è una malattia, ecco la verità che Balzac afferma senza incertezze e senza perifrasi. Nè questo modo di considerar fisiologica mente le qualità intellettuali o sentimentali dell’uomo, può ritenersi un caso solitario nell’opera sua. Altrove egli ritorna sull’argomento (2), e in Grandeur et décadence de César Birotteau egli scrive: «N’est-ce pas une flatterie sociale un peu trop prolongée que de toujours peindre les hommes sous de fausses couleurs, et de ne pas révéler quelques-uns des vrais principes de leurs vicissitudes, si souvent causées par la maladie? Le mal physique, considéré dans ses ravages moraux, examiné dans les influences sur le mécanisme de la vie, a peut-être été jusqu’ici trop négligé ... ».
Ecco dunque enunciata ancor più chiaramente e più limpidamente la teoria scientifica che il morale è strettamente legato col fisico, ecco vibrato un fiero colpo alla teoria spiritualista del libero arbitrio, ecco tutta la società non più dipinta coi colori romantici, ma studiata nelle sue ragioni e condizioni di razza e di eredità, ecco l’uomo, i suoi vizi, le sue passioni, i suoi delitti spiegati non colla rettorica, ma colla fisiologia e coll’antropologia.
Se il genio è una malattia, che cosa sarà il suicidio? «Le suicide est l’effet d’un sentiment que nous nommerons l’estime de soi-même pour ne pas le confondre avec le nom honneur. Le jour où l'’homme se méprise, le jour où il se voit méprisé, au moment où la réalité de la vie est en désaccord avec ses espérances, il se tue et rend ainsi hommage à la société devant laquelle il ne veut pas rester déshabillé de ses vertus ou de sa splendeur». Si noti la finissinia analisi psicologica che condurrebbe a definire il suicidio, come è in realtà, un atto d'amor proprio postumo. « Quoiqu’on en dise, parmi les athées (puisqu’il faut excepter le chrétien du suicide) (3) les lâches seuls acceptent une vie déshonorée. Le suicide est de trois natures: il y a d’abord le suicide qui n’est que le dernier accès d'une longue maladie, et qui, certes, appartient à la pathologie: puis le suicide par désespoir, enfin le suicide par raisonnement. Il n'y a d’irrévocable que le suicide pathologique: mais souvent les trois causes se réunissent comme chez Jean-Jacques Rousseau».
Dunque, secondo Balzac, il suicidio come il genio hanno cause patologiche: non sono capricci della natura o atti arbitrari della volontà umana: sono fatalità fisiologiche.
Date queste premesse, sarà facile immaginare che cosa Balzac pensi del delitto e dei delinquenti.
III. — Il delitto e i delinquenti.
Ho già notato come il nostro autore, a proposito della politica e del parlamento, fosse piuttosto scettico, diffidente ed assolutista. Lo stesso scetticismo, la stessa diffidenza, lo stesso assolutismo noi ritroveremo a proposito della giustizia.
Egli stabilisce anzitutto questa verità dolorosa: «Il n’y a rien de moins connu que ce que tout le monde doit savoir: la loi». Parrebbe che l’unico rimedio a questo male fosse l’istruzione. Ma Balzac, se deplora l’ignoranza non solo della legge ma di ogni altra cosa utile a sapersi, non è viceversa favorevole al diffondersi dell’istruzione. Strana contraddizione di un uomo in cui la logica dell’ingegno lottava ancora contro pregiudizî conservatori! «L’instruction également dispensée aux masses, amène le fils d’un concierge à prononcer sur le sort d’un homme de mérite ou d’un grand propriétaire chez qui son père a tiré le cordon de la porte. Le dernier venu peut donc lutter avec le plus ancien». Ciò sembra uno scandalo e un’ingiustizia a Balzac, nelle cui vene scorre il sangue di un retrogrado e nelle cui parole è spesso un disdegno verso la folla e un’ammirazione devota per le individualità superiori. Egli, che condannava «le sentiment d’insubordination sociale caché sous le mot égalité». concepiva la giustizia come la missione che una casta privilegiata doveva esercitare senza intrusione della volontà popolare. E perciò riteneva assurda l'istituzione del giurì. Questo piccolo parlamento, trasportato dalla politica nel campo della giustizia, gli sembrava un errore e un pericolo: «Le jury, cette institution que les législateurs révolutionnaires ont crue si forte, est un élément de ruine sociale, car elle manque à sa mission». E manca alla sua missione, secondo Balzac, perchè è incoerente e indulgente. «Les jurés se divisent en deux camps, dont l’un ne veut plus de la peine de mort, et il en résulte un renversement total de l’égalité devant la loi. Tel crime horrible, le parricide, obtient dans un département un verdict de non-culpabilité, tandis que dans tel autre un crime ordinaire, pour ainsi dire, est puni de mort». E aggiunge con meraviglia e con dolore: «Il existe dans les bagnes 25 parricides a qui l’on a donné des circonstances atténuantes». Se Balzac rivivesse oggi, egli si consolerebbe vedendo la Francia invasa da una libidine di severità che vuole non solo più attiva la ghigliottina, ma vuole anche introdotta nelle carceri la frusta, resurrezione parziale della tortura! E sopratutto egli si consolerebbe constatando che il giurì, da lui accusato di indulgenza, non è in Francia avaro di condanne a morte. È il presidente della repubblica che ha la debolezza di far grazia troppo spesso!
Sarebbe ingiusto del resto il non tener conto delle cause che spiegano, se non giustificano, questa severità, quasi direi questa ferocia di Balzac. Egli viveva e scriveva in un’epoca in cui la Francia e specialmente la città di Parigi vedevano salire vertiginosamente le curve della statistica criminale ed erano spettatrici dei più orrendi misfatti.
Quando la marea del delitto sale, i più non credono vi sia altra diga che la severità delle pene. E Balzac partecipava all’opinione dei più. Per questo stesso sentimento di necessaria severità che era diffuso nell'aria, per questo bisogno di difendersi contro i delinquenti che abbondavano e incutevano terrore, Balzac è scettico di fronte agli errori giudiziarii, e per lui non solo un condannato è sempre ben condannato, ma anche ogni prevenuto, ogni accusato è a priori colpevole. «... Selon nous, nous paraît-il bien difficile qu'un innocent s’asseye jamais sur les bancs de la cour d’assises». E altrove: «Règle générale, les criminels parlent tous d’erreur! Allez dans les bagnes, questionnez-y les condamnés, ils sont presque tous victimes d’une erreur de la justice. Aussi ce mot fait-il sourire imperceptiblement tous ceux qui sont en contact avec les condamnés».
Questa regola generale è innegabilmente verissima ove all’assolutismo con cui la pronuncia Balzac si voglia sostituire la possibilità di qualche eccezione. Io ricordo che molti anni fa quando visitai per la prima volta con Enrico Ferri il bagno penale di Civitavecchia fui colpito dall’uniformità con cui le parecchie diecine di forzati che interrogammo ci rispondevano sempre: io sono innocente. Rarissimo il caso ch’essi confessino.
Ma viceversa, tra di loro, mutan contegno. Tra di loro, anzichè affermarsi innocenti, si vantano dei loro delitti, li esagerano, ne inventano. Come, verso gli estranei, mettono il loro orgoglio nel proclamarsi vittime d’un errore, così, verso i compagni, mettono il loro punto di onore nel dimostrarsi i più perfidi ed i più abili nella carriera del delitto.
Questa diversità di contegno è determinata da un'unica ragione: il loro interesse. Verso i galantuomini, essi debbono nascondersi sotto la maschera dell'innocenza per cercar di salvarsi: verso i colleghi, essi devono farsi belli delle loro atroci imprese, per incutere rispetto e terrore. Oggi – dopo lo sviluppo preso dagli studî di psicologia criminale – è facile conoscere questi due lati opposti della psicologia dei delinquenti; oggi tutti sanno che nelle carceri i banditi più temibili vogliono esercitare, ed esercitano, una suggestione, un fascino sugli altri, appunto coll’ostentare l’infamia delle loro azioni. Anche il delitto ha la sua aristocrazia, dietro la quale si pone, invidiando, la moltitudine dei mediocri. Ma è notevole che Balzac abbia esattamente intuito fin da allora questa caratteristica della psiche criminale. Nel Curé de village egli fa dire all’assassino Farrabesque: «J’étais célèbre au bagne avant d’y arriver. Deux de mes camarades avaient déjà parlé de moi comme d'un homme capable des plus grandes choses. Au bagne il n’y a rien qui vaille cette réputation, pas même l’argent. Pour être tranquille dars cette république de misère, un assassinat est un passeport ». E nella Dernière incarnation de Vautrin, dopo aver descritto l’ascendente che l’assassino La Pouraille esercitava sui condetenuti, scrive: «Là, comme partout où des hommes sont rassemblés, là comme au collège, règnent la force physique et la force morale. Là, l’aristocratie est la criminalité. Celui dont la tête est en jeu prime tous les autres ... L’homme qui se repent et veut se bien conduire est l’ennemi commun. Le préau est une école de droit criminel: on l’y professe infiniment mieux qu’à la place du Panthéon».
Come Eugenio Sue - che nei suoi Mystères de Paris ha rivelato una conoscenza profonda dell’anima criminale – così Onorato Balzac sembra abbia studiato sul vivo quei delinquenti e quegli ambienti criminali ch’egli descrive. V’è nelle sue descrizioni l’accento della verità, v’è nelle sue osservazioni lo spunto di quelle teorie che dovevano col tempo conquistare l’adesione del mondo scientifico. Quando parla dell'assassino Tascheron, egli fa un’aperta allusione all’antropologia criminale: «un trait de sa physionomie — egli dice – confirmait une assertion de Lavater sur les gens destinés au meurtre: il avait les dents de devant croisées». Quando ci presenta Farrabesque (un affigliato alla banda dei chaffeurs, condannato a dieci anni di lavori forzati) egli si esprime così: «Mme Graslin regarda cet homme et observa dans sa figure des signes de férocité cachée: les dents mal rangées imprimaient à la bouche un tour plein d’ironie et de mauvaise audace: les pommettes brunes et saillantes offraient je ne sais quoi d’animal. Cet homme avait la taille moyenne, les épaules fortes, le cou rentré, très court, gros, les mains larges et velues des gens violents et capables d’abuser de ces avantages d’une nature bestiale». E conferma e suggella queste allusioni e queste osservazioni parziali con un esplicito atto di fede nella fatalità antropologica. Dice Vautrin ad Esther: «Jai tenté de vous donner au ciel: mais la fille repentie sera toujours une mystification pour l’église: s’il s’en trouvait une, elle redeviendrait courtisane dans le Paradis ... Vous êtes fille, vous resterez fille, car, malgré les séduisantes théories des éleveurs de bêtes, on ne peut devenir ici-bas que ce qu’on est. L'homme aux bosses a raison: vous avez la bosse de l’amour».
Quest’allusione a Gall («l’homme aux bosses»), questo fatalismo che Balzac applica alle donne perdute (e che sarebbe più equo applicare soltanto a una parte di esse) illumina per riflesso la sua concezione del delitto e, in generale, di ogni forma dell’attività umana. On ne peut devenir ici-bas que ce qu’on est. Vale a dire: vi sono degli individui irriducibili, sui quali l’influenza dell’educazione e dell’ambiente è come il passaggio dell’onda marina sulle arene della spiaggia. Vale a dire: come esiste colui che per natura è onesto, l’uomo-quercia che nessun vento farà deviare dal retto cammino, così esiste il delinquente-nato, l’uomo a istinti malvagi, che nessun potere saprà modificare e volgere al bene.
Precursore inconscio di ciò che diventò il caposaldo della scuola positiva italiana — l’esistenza cioè del delinquente-nato — il Balzac seppe anche tracciare le prime linee della psicologia dei grandi cri. minali, riassumendola in due vizî: la viltà e la sensualità. «A part quelques exceptions très rares, ces gens là sont tous lâches». Il Despine, il Lombroso, il Ferri, il Corre, dopo molte osservazioni, sono venuti, come è noto, all’identica conclusione. Ma perchè i grandi delinquenti sono tutti vili? Balzac ce ne rivela limpidamente il motivo con un’analisi che l’esperienza scientifica ha confermato: «... leurs facultés étant incessamment tendues à l’exécution d’un coup exigeant l’emploi de toutes les forces de la vie, une agilité d’esprit égale à l’aptitude du corps, une attention qui abuse de leur moral, ils deviennent stupides hors de ces violents exercices de leur volonté, par la même raison qu’une cantatrice ou un danseur tombent épuisés après un pas fatigant ou après l’un de ces formidables duo comme en infligent au public les compositeurs modernes ... Après la réussite d’une affaire ils sont dans un tel état de prostration que, livrés immédiatement à des débauches nécessaires, ils s’énivrent de vin, de liqueurs et se jettent dans les bras de leurs femmes avec rage, pour retrouver du calme, en perdant toutes leurs forces, et cherchent l’oubli de leur crime dans l’oubli de leur raison ... Energiques à effrayer dans leurs conceptions, ils sont comme des enfants après la réussite. C'est, en un mot, le naturel des bêtes sauvages, faciles è tuer lorsqu’elles sont repues».
Sarebbe lungo ed inutile citare le pagine degli antropologi, dei medici, dei criminalisti che hanno dimostrato coi fatti la verità di questa analisi di Balzac. La viltà e la sensualità sono i due poli della psicologia dei grandi delinquenti, e l’una si spiega con l’altra. Essi son vili appunto perchè son sensuali, e sono sensuali perchè tali li vuole l’animalità dei loro istinti, le naturel des bêtes sauvages, perchè infine il Balzac stesso dichiara «qu’ils sont entraînés vers la femme constitutionnellement, comme disent les médecins».
Più utile e più importante parmi il constatare che Balzac, dopo avere intuito il delinquente-nato, ha intuito anche un’altra categoria di delinquenti, il delinquente d’abitudine o professionale. Il delinquente-nato è, per fortuna, l’eccezione nel mondo della criminalità: il delinquente professionale è la regola. L’uno rappresenta l’aristocrazia, l’altro la plebe della delinquenza («la haute pègre est pour ce monde son faubourg St. Germain»). Se l’attenzione dei profani è sopratutto attirata dalle gesta dei grandi assassini, le cosidette belve umane, la preoccupazione di quanti si occupano di criminalità si rivolge invece al numero immenso e sempre crescente di quei delinquenti comuni che sono come un esercito di microbi che infettano e corrompono l’organismo sociale. Questo esercito è composto di ladri e di prostitute, le due forme antisociali istintive con cui il maschio e la femmina possono conquistarsi da vivere. Rubare e vendersi, ecco ciò che qualunque uomo e qualunque donna può fare, ove non abbiano mezzi d’esistenza e ove una granitica onestà non li sostenga e li difenda contro le mille suggestioni dell'ambiente esteriore. « ‘La prostitution et le vol —- dice Balzac – sont deux protestations vivantes, mâle et femelle, de l’état naturel contre l’état social». E sono due proteste pur troppo così comuni, che coloro i quali le compiono hanno formato una casta, una elasse a sè che, per legge d’eredità nelle famiglie e per forza d’abitudine negli individui, possiede le sue caratteristiche speciali. Gabriele Tarde, studiando appunto questa criminalità professionale, notava come ogni mestiere lasciasse in chi lo esercita un carattere indelebile nel fisico e nel morale. Balzac lo aveva preceduto in questa osservazione. «Il en est du vol et du commerce de fille publique, comme du théâtre, de la police, de la prêtrise et de la gendarmerie. Dans ces six conditions l’individu prend un caractère indélébile. Il ne peut plus être ce qu’il est. Les stigmates du divin sacerdoce sont immuables, tout aussi bien que ceux du militaire. Il en est ainsi des autres états qui sont des fortes oppositions, des contraires dans la civilisation. Ces diagnostics violents, bizarres, singuliers, sui generis, rendent la fille publique et le voleur, l’assassin et le libéré, si faciles à reconnaître, qu’ils sont pour leurs ennemis l’espion et le gendarme – ce qu’est le gibier pour le chasseur: ils ont des allures, des façons, un teint, des regards, une couleur, une odeur, enfin des propriétés infaillibles». Da ciò, quella scienza del travestimento che è profonda nei criminali: da ciò, anche, il gergo, questo mezzo psicologico di difesa che il Balzac, primo fra i romanzieri e seguito più tardi dal Sue, ha ampiamente studiato.
Così, primo fra i romanzieri, egli intuì il rapporto tra pazzia e delitto. «Le crime et la folie — egli scrive – ont quelques similitudes. Voir les prisonniers de la Conciergerie en prison, ou voir les fous dans un jardin d’une maison de santé, c’est une même chose. Les uns et les autres se promènent en s’évitant, se jettent des regards singuliers atroces selon leurs pensées du moment, jamais gais ni sérieux, car ils se connaissent ou il se craignent».
Ci sono dunque in germe nell’opera di Balzac molte di quelle idee che furono poi sviluppate dai positivisti italiani: v’è il profilo del delinquente-nato e del delinquente abituale, vi è l’accenno alla somiglianza fra il delitto e la pazzia, vi è lo studio psicologico degli ambienti criminali, vi è insomma una concezione del delitto diversa da quella che dominava allora, v’è la preveggenza dell’artista che, additando la via per la quale procederà poi la scienza, più lenta ma più organica, enuncia inconsciamente quei paradossi che non sono altro se non le verità del domani.
E – cosa ancor più notevole — v’è nell’opera di Balzac anche un giudizio sui sistemi penitenziarii, che pare scritto ai nostri giorni. Il sistema cellulare, dopo essere parso il migliore, perchè socialmente il più sicuro se non sempre il più umano, è considerato oggi come una costosa crudeltà che non migliora il colpevole, ma lo conduce ai confini della follia. Ebbene, Balzac ha, sul valore psicologico dell’isolamento, una pagina magnifica che mi piace di riprodurre intera: «L’aimable philanthropie moderne croit avoir deviné l’atroce supplice de l’isolement. Elle se trompe. Depuis l’abolition de la torture, le Parquet, dans le désir bien naturel de rassurer les consciences déjà bien délicates des jurés, avait deviné les ressources terribles que la solitude donne à la justice contre le remords. La solitude, c’est le vide: et la nature morale en a tout autant d’horreur que la nature physique. La solitude n’est habitable que pour l’homme de génie qui la remplit de ses idées, filles du monde spirituel, ou par le contemplateur des œuvres divines qui la trouve illuminée par le jour du ciel, animée par le souffle et par la voix de Dieu. Hormis ces deux hommes si voisins du Paradis, la solitude est à la torture ce que le moral est au physique. Entre la solitude et la torture il y a toute la différence de la maladie nerveuse à la maladie chirurgicale. C'est la souffrance multipliée par l’infini. Le corps touche à l’infini par le système nerveux, comme l’esprit y pénètre par la pensée».
Leggendo questa pagina, i nostri legislatori e cultori di studii penitenziarii potranno vedervi spiegate le cause di quell’abbrutimento cui arrivano i condannati all’ergastolo dopo alcuni anni di quella solitudine «che è una tortura morale».
IV. — La filosofia di «Vautrin».
Finora io ho considerata la Commedia umana unicamente dal punto di vista sociologico: ne ho estratte alcune idee o alcuni frammenti di idee: non l’ho considerata dal punto di vista estetico: non ho mostrato quali tipi veramente umani in essa campeggino, quali figure vive ed eterne abbia saputo plasmare Balzac, questo grande scultore.
Tale lavoro d’analisi psicologica — come ho detto al principio di questo studio — era al di fuori del mio compito, non solo perchè da altri fu già tentato, ma anche e sopratutto perchè io non oserei, come profano all’arte, giudicare l’opera di Balzac artisticamente. Io cerco in quest’opera i pensieri; non cerco le emozioni estetiche: io voglio indagare quali verità scientifiche avesse fin da allora Balzac intuito: non voglio indugiarmi ad ammirare i capolavori ch’egli ha creato.
Quali sieno questi capolavori, altri ha già detto: Eugénie Grandet, la tragedia delle crudeltà lente e silenziose dell’avarizia, — César Birotteau, il poema eroi-comico dell’ambizione, — il Père Goriot, la pittura shakespeariana della debolezza colpevole d’un padre e dell’ingratitudine inverosimile di due figlie, — Le Lys dans la vallée, l’inno all’amore puro, all’amore platonico, che si deforma in una specie di ermafroditismo morale.
Ma v’è un capolavoro intorno al quale credo di poter dire anche io qualche cosa: v’è una figura che s’eleva sulle altre colle linee di una statua michelangiolesca, e che io pure voglio ammirare e descrivere. Questo capolavoro, questa statua michelangiolesca è il personaggio di Vautrin.
Vautrin è uno dei nomi sotto cui si nasconde il forzato Jacques Collin, il quale — condannato più volte e più volte fuggito dal bagno penale – doveva compiere i suoi maggiori delitti travestito da abate spagnuolo, l’abate Carlos Herrera, e doveva finire, per la viltà degli uomini e per la genialità della sua perfidia, non già sulla ghigliottina, ma capo della polizia a Parigi.
Egli è, più che un uomo, un simbolo, come tutte le grandi creazioni artistiche. «En lui se résument la vie, les forces, l’esprit, les passions du bagne, et il vous en présente la plus haute expression». Egli non è un delinquente: egli è la personificazione mostruosa del delitto: è, se posso dir così, la quintessenza di tutto ciò che di più perverso e di più satanico ha mai strisciato nel fondo dell’anima umana.
Perchè egli rappresentasse degnamente questa sua parte, Balzac lo descrive fisicamente come un delinquente-nato. Ed erano così spiccati i suoi caratteri degenerativi che, malgrado la sua straordinaria abilità di metamorfosi, il giudice istruttore Camusot mentre lo guardava — vestito da abate e tutto untuosamente occupato a leggere il suo breviario — era costretto ad esclamare: «C’est pourtant bien là une physionomie de bagne!».
Non è, del resto, nel ritratto fisico dei suoi personaggi che meglio s’appalesa l’arte di un romanziere: è nel loro ritratto morale. Vautrin, il cui viso era «un poème infernal où se peignaient tous les sentiments humains moins un seul, celui du repentir», si rivelava meglio cogli atti e colle parole che colla fisonomia. Egli dice a Eugenio di Rastignac: «Je suis un grand poète. Mes poésies je ne les écris pas: elles consistent en actions et en sentiments». Infatti, egli era il poeta del male. Egli era un artista che meditava, componeva ed eseguiva i suoi delitti, con la stessa passione sincera, con la stessa febbre di creazione che agita il cervello e il cuore di chi spera produrre un’opera d’arte. Egli era, più che un poeta, un genio del male. «Le génie en toute chose est une intuition. Au dessous de ce phénomène le reste des œuvres remarquables se doit au talent. En ceci consiste la différence qui sépare les gens du premier des gens du second ordre. Le crime a ses hommes de génie».
Vautrin era quest’uomo di genio, perchè egli aveva il dono dell’intuizione. Intuizione, non solo nell’architettare delitti che ad altri sarebbero apparsi i più inverosimili e i più difficili, ma intuizione anche e sopratutto nel conoscere gli uomini, nel farli servire inconsciamente ai suoi scopi, nell’adoperarli come stromenti e come sgabelli per raggiungere la fortuna. Un Napoleone della criminalità ecco che cosa era Vautrin.
La prima condizione per farsi largo nel mondo è di non preoccuparsi se altri resteranno schiacciati mentre noi ci innalziamo. Vautrin possedeva questo supremo dispregio d’ogni scrupolo, questa insensibilità che è la caratteristica del delinquente-nato. «Il est bon de vous apprendre que je me soucie de tuer un homme comme ca – dit Vautrin en lançant un jet de salive» (e questa frase e questo atto mi ricordano le parole di un celebre assassino francese: - couper la caboche à un homme, qu'est-ce que c’est ? c'est du chocolat, c'est du velours!). «Seulement – continua Vautrin – je m’efforce de tuer promptement, quand il le faut absolument. Je suis ce que vous appelez un artiste. J’ai lu les Mémoires de Benvenuto Cellini ... J’ai appris de cet homme là, qui était un fier luron, à imiter la Providence qui nous tue à tort et à travers, et à aimer le beau partout où il se trouve. N’est-ce pas d’ailleurs une belle partie è jouer que d’être seul contre tous les hommes et d’avoir la chance?». Ed ecco in queste ultime parole una visione artistica del delitto, l’orgogliosa ambizione dell’egoarca di sentirsi solo contro tutti, di sentirsi un’eccezione di audacia tra un gregge di deboli, un superuomo contro la folla. Vautrin concepisce il mondo come certi artisti degenerati: lo crede la pasta informe di cui pochi individui geniali costituiscono il lievito: lo erede l’arena dove alcune personalità d’eccezione possano compiere impunemente le loro gesta. Ascoltate questa sua professione di fede. «L’homme est imparfait. Il est parfois plus ou moins hypocrite, et les niais disent alors qu'il a ou qu'il n'a pas de meurs. Je n’accuse pas les riches en faveur du peuple: l’homme est le même en haut, en bas, au milieu. Il se rencontre par chaque million de ce haut bétail dix lurons qui se mettent au dessus de tout, même des lois, — j’en suis».
E poichè egli è uno di quei pochissimi che si mettono al di sopra di tutto, anche delle leggi, Vautrin guarda la vita e il mondo come il campo della sua conquista, e dall’alto della sua superiorità cinica ed orgogliosa rinnova la psicologia del signorotto medioevale che dal suo nido d’aquila in cima a una montagna dominava e taglieggiava il volgo dei vassalli.
Che è per lui Parigi, questo oceano di cui, pur gettandovi la sonda, non si può mai conoscere la profondità? Parigi è per Vautrin «un bourbier et un drôle de bourbier: ceux qui s’y crottent en voiture sont d’honnêtes gens, ceux qui s’y crottent à pied sont des fripons». E aggiunge: « Paris est comme une forêt du Nouveau Monde, où s’agitent vingt espèces de peuplades sauvages, qui vivent du produit que donnent les différentes classes sociales ... Il y a plusieurs manières de chasser. Les uns chassent à la dot: les autres chassent è la liquidation: ceux-ci pêchent des consciences, ceux-là vendent leurs abonnés pieds et poings liés. Celui qui revient avec sa gibecière bien garnie est salué, fêté, reçu dans la bonne société».
Forse queste parole che scolpiscono l’ambiente parigino, potrebbero adattarsi anche ad altri ambienti, perchè pur troppo nel cinismo di Vautrin è un’anima di verità che trascende l’osservazione partico lare per raggiungere il significato e il valore di una considerazione generale. Vautrin è un filosofo, un torbido e amaro filosofo che ha la sfrontatezza di dire ad alta voce ciò che una parte degli uomini pensa e pratica senza osar di vantarsene.
«Savez-vous - domanda Vautrin a Rastignac – comment on fait son chemin ici? par l’éclat du génie ou par l’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d’hommes comme un boulet de canon ou s’y glisser comme une peste. L’honnêteté ne sert à rien .. Aujourd’hui la corruption est en force, le talent est rare. Ainsi la corruption est l’arme de la médiocrité qui abonde ...».
Guardiamoci attorno, e confessiamo che a distanza di quasi ottant’anni (il Père Goriot da cui ho preso queste parole è del 1834) la filosofia di Vautrin è ancor viva e vera —- e non a Parigi soltanto. È un forzato che parla, e c’è nelle sue frasi tutto il rancore e il livore del ribelle contro la società che lo ha condannato e infamato: ma quanta verità sotto le sue esagerazioni, quanta sapienza sotto il veleno delle sue invettive! Come Jago, egli recita un credo in cui urla tutto l’egoismo e il pessimismo umano, ma cui non si può negare qualche lampo di genialità psicologica tra la grande oscurità dei principii morali. «Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements: il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances: l’homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire».
Abolita la legge morale, abolito l’imperativo categorico della coscienza, - che in Vautrin non esiste — la vita per lui non è dunque che una corsa alla fortuna, alla ricchezza, al piacere, una corsa dove non esistono quegli ostacoli psicologici che si chiamano scrupoli, e dove ogni altro ostacolo materiale deve essere eliminato. Il mondo è una pista dove unico scopo è di arrivare buon primo; e in questa pista «l’onestà non serve a niente», ciò che giova è la corruzione e l’audacia geniale. «N’acceptez les hommes et les femmes — dice Vautrin a Rastignac —- que comme des chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais: vous arriverez ainsi au faîte de vos désirs». E parlando a Luciano di Rubempré insiste su questa idea e la sviluppa: «Ne voyez dans les hommes et surtout dans les femmes que des instruments, mais ne le leur laissez pas voir. Adorez comme Dieu même celui qui, placé plus haut que vous, peut vous être utile, et ne le quittez pas qu’il n’ait payé très cher votre servilité. Dans le commerce du monde, soyez âpre comme le juif et bas comme lui; faites pour la puissance ce qu'il fait pour l’argent. Mais aussi n’ayez pas plus de souci de l’homme tombé que s’il n’avait jamais existé».
Questa scuola d’egoismo feroce è necessaria, secondo Vautrin, se si vuol riuscire. Per dominare il mondo, bisogna prima obbedirvi e studiarlo. Vautrin contempla con ironia gli scienziati e i moralisti che studiano sui libri, e si foggiano colla fantasia leggi e doveri e principii astratti a cui ben pochi si sottomettono in pratica: egli ammira i grandi uomini politici, di cui si sente fratello, i quali lasciano i libri alle biblioteche e le teorie ai cervelli solitarii ed ingenui, e studiano l’uomo qual’è, i suoi interessi, le cause generatrici delle sue azioni. E da questo studio egli ricava la conclusione arida e pessimista, ma pur troppo talvolta vera, che il mondo, la società, gli uomini, presi nel loro insieme, son fatalisti perchè non considerano le intenzioni, ma soltanto adorano il risultato. Per qualunque via voi siate arrivato alla ricchezza e al potere, voi sarete temuto e invidiato. Il successo è la legge del mondo. «La fortune est la vertu».
Se noi volessimo giudicare la storia, sopratutto la storia politica, tenendo conto di questi criterî, noi dovremmo riconoscere che in molti casi Vautrin ha ragione. La bellezza artistica di questo personaggio e la profonda moralità sua consistono appunto nel fatto che Balzac affida a un forzato, a un delinquente reo dei più gravi delitti, l’ufficio di dimostrare quanto sia ingiusta e immorale la società in cui viviamo. Vautrin è l’ironista inconscio che svelando l’anima sua e i suoi pensieri, ci fa riflettere quanto poco limpida sia anche l’anima nostra, e di quali intenzioni egoiste e malvagie sia lastricata questa nostra civiltà di cui siamo tanto orgogliosi. Sentendolo parlare, sentendolo giustificare con degli aforismi filosofici la perfidia delle sue azioni, noi siamo costretti a domandarci: ma il cinismo ch'egli ostenta ed esagera, non è forse nascosto, in minori proporzioni, in ognuno dei nostri pensieri? Siamo noi veramente, totalmente diversi da lui, o non è egli piuttosto il simbolo mostruoso di quella febbre di danaro e di potenza che travolge certe classi sociali, e che è stata – nel tempo – l’origine di ogni grandezza politica e forse anche di molte ricchezze private?
Non ricordo chi ha pronunciato la frase che deve suonar male alle orecchie dei commercianti fortunati: «toute fortune rapide a une source impure». Balzac, meno assoluto, fa dire a Vautrin: «Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu’il a été proprement fait». Certo è che quando politicamente o privatamente si fa fortuna, quando si sono conquistati il potere o i milioni o i miliardi, ben pochi volgono l’occhio indietro per guardare di quale scala ci si è serviti per arrivare in alto. Vi sono due morali: una, severa, per chi commette il male ma non riesce: l’altra, assai indulgente, per chi, pur commettendo il male, arriva al successo. «Ne pas réussir — dice egregiamente Balzac — est un crime de lèse majesté sociale».
E così, vi sono due giustizie: una, severa, per il povero od il mediocre che non sanno dare al loro delitto quell’apparenza che lo eleva a un affare finanziario o a un’azione politica: l’altra, mitissima, per i furbi, i quali sanno che la legge, al pari della società, non punisce la sostanza di un atto criminoso, ma soltanto la forma.
Vautrin, anche a questo proposito, è il lucido interprete di tale verità dolorosa: «... tout est dans la forme. Saisissez bien ce que j’appelle la forme – egli dice a Luciano: - il y a des gens sans instruction qui, presses par le besoin, prennent une somme quelconque par violence à autrui: on les nomme criminels et ils sont forcés de compter avec la justice. Un pauvre homme de génie trouve un secret dont l’exploitation équivaut à un trésor, vous lui prêtez trois mille francs, vous le tourmentez de manière à vous faire céder tout ou une partie du secret, vous ne comptez qu’avec votre conscience, et votre conscience ne vous mène pas en Cour d’assises. Les ennemis de l’ordre social profitent de ce contraste pour japper après la justice et se courroucer au nom du peuple de ce qu’on envoie aux galères un voleur de nuit et de poules dans une enceinte habitée, tandis qu'on met en prison à peine pour quelques mois un homme qui ruine des familles en faisant une faillite frauduleuse; mais ces hypocrites savent bien qu’en condamnant le voleur, les juges maintiennent la barrière entre les pauvres et les riches, qui, renversée, amènerait la fin de l’ordre social: tandis que le banqueroutier, l’adroit capteur de successions, le banquier qui tue une affaire à son profit, ne produisent que des déplacements de fortune …».
Chi conta gli anni da che furono pronunciate queste parole? Esse non hanno perso nulla della loro opportunità. Chi riflette che esse escono dalla bocca d'un assassino? Le avrebbe potute pronunciare la coscienza severa d’un moralista. Chi ricorda ch’esse appartengono a un libro di un autore conservatore e retrogrado che non nascondeva la sua simpatia pei Borboni? Esse hanno un sapore di liberalismo e di socialismo come se uscissero dall’eloquenza d’un deputato di estrema sinistra.
Vautrin, nella sua cinica sincerità, è l’interprete d’un sentimento che sorpassa tempi, ambienti, costumi: è lo spavaldo assertore di verità che l’interesse gesuitico dei più non vuol confessare.
Ed egli incalza nella sua critica alla società e alle leggi, e ironicamente domanda: «Pourquoi deux mois de prison au dandy qui, dans une nuit, ôte à un enfant la moitié de sa fortune, et pourquoi le bagne au pauvre diable qui vole un billet de mille francs avec les circonstance aggravantes? Voilà vos lois. Il n’y a pas un article qui n’arrive à l’absurde. L’homme en gants et à paroles jaunes a commis des assassinats où l’on ne verse pas de sang, mais où l’on en donne: l’assassin a ouvert une porte avec un monseigneur: deux choses nocturnes».
Credo che mai, con più concisione, con più spirito e con più delicata signorilità di forma, sia stata scolpita l’antitesi immorale delle nostre leggi che puniscono severamente il ladro o l’omicida comune e sono viceversa tanto indulgenti verso i ladri dell’onore, verso coloro che turbano gli interessi e uccidono la pace delle famiglie.
V. — La coppia criminale.
Il tipo di Vautrin non sarebbe stato una creazione completa, se Balzac non avesse fatto risplendere nell’anima di questo filosofo del male la luce di un sentimento umano.
Ogni coscienza pura e illibata ha le sue chiazze d'ombra: così ogni anima perfida ha i suoi lampi d’affetto e di bontà. Il più feroce dei delinquenti, il più ostinato dei ribelli non può sempre e soltanto odiare: egli deve anche amare. E Vautrin, che pur aveva nel suo carattere gli istinti della belva e del selvaggio, sentì che, come la belva e come il selvaggio, anche l’uomo non può isolarsi totalmente dai suoi simili, nemico e lontano da tutti, ma ha bisogno di qualcuno su cui esercitare direttamente la sua influenza, ha bisogno di un altro da associare al suo destino, ha la necessità di riporre su una creatura umana le sue speranze, il suo orgoglio, il suo avvenire. E poichè Vautrin, oltre ad essere un criminale di genio, è un analista dei più profondi, spiega egli stesso il perchè di questa necessità cui egli, come tutti, deve sottostare, e lo spiega in una pagina che potrebbe servir di proemio a un trattato su la psicologia dell’associazione: «... L’homme a l’horreur de la solitude. Et de toutes les solitudes, la solitude morale est celle qui l’épouvante le plus. Les premiers anachorètes vivaient avec Dieu, ils habitaient le monde le plus peuplé, le monde spirituel. Les avares abitent (sic) le monde de la fantaisie et des jouissances. L’avare a tout jusqu’à son sexe dans le cerveau. La première pensée de l’homme, qu'il soit lépreux ou forçat, infâme ou malade, est d’avoir un complice dans sa destinée. A satisfaire ce sentiment, qui est la vie même, il emploie toutes ses forces, toute sa puissance, la verve de sa vie. Sans ce désir souverain, Satan aurait-il pu trouver des compagnons?».
E questa la pagina che il Morello mi rimproverava di non aver citata nel mio libro La Coppia criminale: e infatti essa racchiude in germe tutte le ragioni che determinano la formazione di quel legame psicologico fra due individui, che è il primo anello delle più ampie associazioni umane.
Vautrin, dunque, vuole un complice nel suo destino, vuole trovare una creatura «pour l’aimer, la façonner, la pétrir à son usage, afin de l’aimer comme un père son enfant », e afferma: «j’ai la passion de me dévouer pour un autre». Il caso gli fa incontrare Luciano di Rubempré. Questo poeta, bello come una fanciulla e debole come un giunco, sarà il suo succube, la sua vittima, il suo stromento e il suo amore.
Perchè si stabilisca fra due persone uno di quei rapporti psicologici che ne fanno, secondo la frase abusata ma vera, due corpi in un’anima sola, occorre – come io ho dimostrato altrove – che l’una eserciti un certo impero sull’altra, occorre che l’una sia la testa, l’altra il braccio, l’una il padrone, l’altra lo schiavo. Luciano di Rubempré rappresentava appunto, di fronte all’imperiosa volontà di Vautrin, questo tipo di delicatezza quasi feminea, facile e pronto a tutte le suggestioni. Il suo amico D’Arthez così lo descrive: «Lucien est un homme de poésie et non un poète, il rêve et ne pense pas, il s’agite et ne crée pas... C’est une femmelette qui aime è paraître, le vice principal des français. Il signerait volontiers un pacte avec le démon, si ce pacte lui donnait pour quelques années une vie brillante et luxueuse ... Il se méprisera lui-même, il se repentira, mais la nécessité revenant, il recommencerait, car la volonté lui manque: il est sans force contre les amorces de la volupté, contre la satisfaction de ses moindres ambitions. Lucien est une harpe dont les cordes se tendent ou s’amollissent au gré des variations de l’atmosphère ... On peut tout attendre de lui en bien comme en mal».
E noi ritroviamo in queste parole la psicologia di tutti i succubes: di quelle nature composte, come il bronzo, di diversi metalli, che vanno indifferentemente al vizio e alla virtù, tabulae rasae su cui il destino scrive quello che vuole, tipi che il Ball definiva effacés e che il Ribot più energicamente chiamava gli idioti della volontà.
Dice Balzac: «... il est des natures vigoureusement munies, des crânes à rempart d’airain sur lesquels les volontés des autres s’aplatissent et tombent comme des balles devant une muraille; puis il est encore des natures flasques et cotonneuses où les idées d’autrui viennent mourir comme des boulets s’amortissent dans la terre molle des redoutes; il y a enfin des natures tendres où les idées se logent et qu’elles ravagent ...».
Luciano era una di queste nature, che diventan l’ombra delle nature energiche che sanno dominarle, gli esecutori automatici di ogni loro comando, Egli incontra Vautrin sotto le spoglie dell’abate Carlos Herrera, inviato straordinario di S. M. il re di Spagna alla Corte di Francia, e lo incontra nel momento più triste e più terribile della sua vita. Tutto crolla intorno a lui: egli ha perduto la sua posizione, la stima degli amici, l’affetto dei parenti: egli è in miseria e disonorato, e sta per uccidersi. Vautrin lo richiama alla vita, gli infonde la passione di vivere. Con un atto di impero, si impadronisce satanicamente di quest’anima che ormai nulla sperava e voleva morire. Vautrin compie un miracolo di resurrezione: ma l’uomo ch’egli strappa alla morte sarà nel mondo l’opera sua, il suo complice inconscio.
— «Voulez-vous être soldat? — egli dice a Luciano. – Je serai votre capitaine. Obéissez-moi comme une femme obéit à son mari, comme un enfant obéit à sa mère, je vous garantis qu’en moins de trois ans vous serez marquis de Rubempré, vous épouserez une des plus nobles filles du faubourg St.-Germain, et vous vous assiérez un jour sur les bancs de la Pairie».
Il sogno è bello. Luciano ascolta. Vautrin incalza ed insiste: «Vous m’appartiendrez comme la créature est au créateur, comme, dans les contes des fées, l’afrite est au génie, comme l’icoglan est au sultan, comme le corps est à l’âme».
E Luciano, vinto a poco a poco dal miraggio di un avvenire felice, ricco, glorioso, sta per «segnare il patto col demonio», secondo la predizione di D’Arthez.
Vautrin si fa più suggestivo ancora, e prosegue nella sua opera di seduttore: «Enfant, as-tu médité la Venise sauvée d’Otway? As-tu compris cette amitié profonde, d’homme à homme, qui lie Pierre à Jaffier, qui fait pour eux d’une femme une bagatelle et qui change entre eux tous les termes sociaux?» (4). Ed egli «dardeggiò su Luciano uno di quegli sguardi fissi e penetranti che fanno entrare la volontà degli individui forti nell'anima delle persone deboli: questo sguardo fascinatore ebbe per effetto di annullare ogni resistenza».
Il terribile forzato, col suo magnetismo, avrebbe ben vinto altre resistenze che non quella di Luciano: contro questo, la vittoria gli fu facile e pronta. Il poeta si lasciò conquistare, o meglio vendette la sua dignità e l’anima sua, forse perchè – come diceva tristemente sua sorella Eva – «dans un poète il y a toujours une jolie femme de la pire espèce». Per la soddisfazione vanitosa di ritornar ricco in quel mondo parigino da cui aveva dovuto fuggire pezzente e pieno di debiti, Luciano accetta di essere mantenuto dall’abate Carlos Herrera, di vivere con lui, e di tentare coi denari di lui la fortuna in quel mondo aristocratico, dove voleva entrare e fissarsi con un gran matrimonio.
Aveva forse, ogni tanto, Luciano qualche scatto di ribellione? Il succube tentava forse di liberarsi dalla suggestione dell’incube? Frano fuochi di paglia, fiammate di energia passeggiera. Vautrin, dotato del genio della corruzione, distruggeva a poco a poco gli ultimi residui dell’onestà di Luciano, gettandolo in necessità crudeli (per esempio, perdite al gioco) e salvandolo da queste col mezzo di consentimenti taciti a quelle azioni losche o infami che tuttavia, poichè erano compiute nell’ombra, lo lasciavano in apparenza puro e leale agli occhi del mondo. «Je suis l’auteur, — gli diceva — tu seras le drame : si tu ne réussis pas, c'est moi qui sera sifflé».
Ma Luciano rappresentava qualche cosa di più che il dramma immaginato dalla fantasia di Vautrin: oltre e più che l’opera del cervello del suo despota, del suo autore, egli era l’opera del suo sentimento.
Vautrin, costretto a vivere lontano dal mondo, dove ormai la legge gli interdiceva per sempre di rientrare, stanco dai vizî ed esausto per tutte le vicissitudini terribili della sua vita, ma nondimeno dotato d’una forza d'animo meravigliosa e divorato ancora, benchè vecchio, da una febbre di vita, Vautrin, questo personaggio ignobile e grande, oscuro e celebre, «riviveva nel corpo elegante di Luciano, la cui anima era diventata la sua. Egli si faceva rappresentare nella vita sociale da questo poeta, al quale egli dava la sua consistenza e la sua volontà di ferro. Per lui, Luciano era più che un figlio, più che una donna amata, più che una famiglia, più che la vita: egli era la sua vendetta; e poichè le anime forti tengono più a un sentimento che all’esistenza, egli se lo era attaccato con dei legami indissolubili». Quali erano questi legami?
Mentre nei primi tempi egli s'era lasciato credere da Luciano l’abate Carlos Herrera, ambasciatore del re di Spagna, più tardi gli aveva confessato il suo vero nome e i suoi delitti, e gli aveva rivelato che i denari ch’egli dava a Luciano e che questi spendeva, non erano altro che il bottino di tutti i reati commessi dai forzati dei quali egli era il cassiere. «Au milieu de sa force, Vautrin était si faible contre les fantaisies de sa créature qu’il avait fini par lui confier ses secrets. Peut-être fut-ce un lien de plus entre eux que cette complicité purement morale». Ecco il legame indissolubile con cui il forzato aveva per sempre legato al suo carro il poeta. Ecco la prova suprema dell’amore di Vautrin per Luciano. Confidandosi a lui, egli correva il rischio di perdersi. « Il est si beau de se perdre, c'est la volupté de l’âme ». Tale novissima voluttà dell’anima egli aveva voluto concedersi dimenticando per il suo amico, per il suo figlio, per il suo discepolo intellettuale quella prudenza che aveva fatto nella vita la sua fortuna. Ed egli diventava mostruosamente bello per questa devozione «degna della razza canina» verso Luciano, per questo abbandono d’ogni egoismo nella fiducia verso di lui. «L’ignoble forçat, en matérialisant le poème caressé par tant de poétes, par Moore, par lord Byron (un démon possédant un ange attiré dans son enfer pour le rafraîchir d’une rosée dérobée au paradis) avait renoncé à lui-même ... Les puissantes facultés, absorbées en Lucien, ne jouaient que pour Lucien: il jouissait de ses progrès, de ses amours, de son ambition. Pour lui, Lucien était son âme visible».
Dove si può trovare un’analisi più perfetta di coppia criminale? Chi mai ha saputo descrivere con più profonda verità il fenomeno della suggestione a due? Io che ho dedicato a questo fenomeno un intero volume [La Coppia criminale, 1908] ed ho raccolto e studiato centinaia di fatti veri, dichiaro che Balzac è stato, anche in questo, un precursore, e che il suo genio ha divinato ciò che la scienza più tardi doveva dimostrare.
Ed egli ha intuito anche come nella vita si sciolga questo impuro e patologico legame d’impero e di servilismo. Egli ha intuito che lo schiavo, la vittima, ha talvolta all’ultimo verso il suo despota un attimo di ribellione, tanto più forte ed intenso, quanto più lungo fu il periodo della soggezione e dell’abbrutimento. Si direbbe che le rinuncie quotidiane si accumulino nel fondo dell’anima del succube per prorompere e scoppiare con maggior violenza tutte ad un tratto.
Quando, per il suicidio di Esther, Vautrin e Luciano vengono arrestati e Luciano confessa al giudice istruttore chi sia l’abate Carlos Herrera e come la sua tonaca di prete nasconda il marchio del forzato, quando vengono a galla le losche imprese contro il barone Nucingen, al quale Vautrin e Luciano avevano venduto Esther per settecentocinquantamila franchi, allo scopo di costituire la somma necessaria per il matrimonio di Luciano con la duchessina di Grandlieu, quando insomma tutto il tessuto d’infamia su cui vivevano i due complici viene scoperto, il poeta non sa resistere al crollo di tutte le sue speranze, vede finalmente il baratro in cui l’ha gettato Vautrin, e dopo aver deciso d’uccidersi, prima di mettere in esecuzione il suo disegno, scrive al suo corruttore questa lettera, che è il canto del cigno della sua coscienza, la protesta estrema della vittima che ha finalmente conosciuto il suo carnefice. Leggiamola questa lettera: è un documento di verità: è la morale della lugubre istoria, la morale che, come sempre, vien troppo tardi: «... Il y la postérité de Cain et celle d’Abel. Cain dans le grand drame de l’humanité, c’est l’opposition. Parmi les démons de cette filiation, il s’en trouvent de temps en temps de terribles, à organisation vaste, qui résument toutes les forces humaines et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du désert dont la vie exige les espaces immenses qu’ils y trouvent. Ces gens là sont dangereux dans la société comme les lions le seraient en pleine Normandie : il leur faut une pâture, ils dévorent les hommes vulgaires et broutent les écus des niais: leurs jeux sont si périlleux qu’ils finissent par tuer l’humble chien dont ils se sont fait un compagnon, un idole. Quand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila, Charle-magne, Robespierre ou Napoléon: mais quand il laisse rouiller au fond de l’océan d’une génération ces instruments gigantesques, ils ne sont plus que Fouché, Louvel ou l’abbé Carlos Herrera. Doués d’un immense pouvoir sur les âmes tendres, ils les attirent et les broient. C’est grand, c’est beau dans son genre. C'est la plante vénéneuse aux riches couleurs qui fascine les enfants dans les bois. C'est la poésie du mal. Des hommes comme vous autres doivent habiter des antres, et n’en pas sortir ... Tu m’as fait vivre de cette vie gigantesque, et lai bien mon compte de l’existence. Ainsi je puis retirer ma tête des nœuds gordiens de ta politique pour la donner au nœud coulant de ma cravate ... Mon mépris pour toi est égal à mon admiration ...».
Luciano s'impicca, e Vautrin che per lui solo mostrava d’aver un cuore, lo piange a lagrime di sangue. «Mai una mamma – egli dice al procurator generale — ha amato così teneramente il suo unico figlio come io ho amato quell’angelo!».
Ma l’amore di Vautrin per Luciano non va fino al sacrificio della vita come quello di Esther. Passato il momento terribile, l’abate Carlos Herrera ritorna il delinquente ch’egli è. Morto il suo idolo, il suo egoismo risorge pieno ed intero, ed egli non pensa che a sè. Come salvarsi? Come uscir di prigione? Egli possiede le lettere compromettenti che molte signore dell’aristocrazia avevano dirette a Luciano, questo enfant gâté del gran mondo. E sono questi documenti che gli permetteranno d’uscire da una situazione pericolosissima: è cioè ancora la sua vittima che, dalla tomba, gli dà il modo per combattere e vincere la sua estrema battaglia. Vautrin minaccia uno scandalo se a lui si farà il processo: i più bei nomi di Parigi, le famiglie più illustri di Francia saranno trascinate nel fango della Corte d’assise. Il giudice istruttore ha paura: il procuratore generale e il ministro della giustizia indietreggiano di fronte a questo pericolo. Che fare? L’istruttoria sarà chiusa con un non luogo a procedere, e per comprare il silenzio di Vautrin lo si nominerà capo della polizia.
Dissero i critici: ciò è inverosimile. Questi critici erano degli ignoranti, perchè non sapevano che Vidocq, il celebre chef de la sûreté, era stato in gioventù un delinquente comune condannato più volte. Balzac dunque è stato, come sempre, vero, non inverosimile.
Ma questi critici non solo ignoravano la storia della polizia giudiziaria che conta molti casi simili a quello di Vidocq (voler far la polizia con dei funzionarii galantuomini anzichè con dei delinquenti «c’est comme si l’on voulait faire la cuisine en gants blancs», ha letto l’agente Peyrade), ma dimostravano anche di non intendere tutta la filosofia che si racchiude in questa ultima incarnazione di Vautrin.
Una filosofia che è un insulto ironico alla giustizia, di cui svela la viltà e l’impotenza. Non vi sono al mondo nè leggi nè magistrati: vi sono dei deboli che cedono dinnanzi al più forte. Vautrin è il più forte ed è quindi il giustiziere di quella società che non ha saputo punirlo.
Ecco la morale di Balzac. Una morale triste, che lascia nell’animo un senso oscuro di scoraggiamento. Ma contemplando e giudicando il mondo, si può forse essere veri senza essere tristi?
Note. [La numerazione è nostra].
(1) Nella prefazione alla Maison da chat qui pelote, ove spiega l’origine, il piano, lo scopo della Commedia umana, e ove apertamente espone le sue idee conservatrici e in alcuni casi retrograde, Balzac così si esprime: «Sans être l’ennemi de l’élection, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l’élection prise comme unique moyen social».
(2) Per esempio, in Albert Savarus, dove a pag. 209 scrive: «Les physiologistes et les profonds observateurs de la nature humaine vous diront, à votre grand étonnement peut-être, que dans les familles les humeurs, les caractères l’esprit, le génie reparaissent à des grands intervalles, absolument comme ce qu’on appelle les maladies héréditaires. Ainsi le talent de même que la goutte, saute quelquefois de deux générations. Nous avons, de ce phénomène, un illustre exemple dans George Sand en qui revivent la force, la puissance et le concept du maréchal de Saxe, de qui elle est petite fille naturelle».
(3) Qui, i fatti smentiscono Balzac, poichè molti credenti si uccidono.
(4) Su Balzac, il romanzo dell’Otway (ove è analizzato il fenomeno di suggestione a due forse più minutamente che nelle Affinità elettive di Goethe) deve aver fatto una grande impressione. Egli, che nei suoi cento romanzi o racconti non si ripete mai, ricorda invece la Venezia salvata in tre dei suoi libri: nelle Illusions perdues, II, pag. 315, nel Père Goriot, pag. 178, e in Un ménage de garcon, pag. 164.
Valentino Soldani, L’abito “Direttorio”. Gli eredi della venditrice di Guardinfanti, «Il Secolo XX», Milano, Fratelli Treves, Editori, Anno VII, N. 8, Agosto 1908, pp. 633-634.
p. 633. Balzac, — fa tanto comodo aver sotto mano una bella citazione per passare da eruditi e per scaricare ogni responsabilità sopra un altro, — Balzac diceva presso a poco che un giorno la Pudicizia andando a spasso con l’Amore trovò un labirinto, ci entrò col compagno di viaggio.
La loro figlia fu la quarta Grazia e si chiamò
Coquetterie.
Vu-elle, Il Giudice, «La Conquista. Settimanale Socialista di Terra di Bari», Bari, Anno II, N. 53, 5 gennaio 1908, pp. 1-2.
p. 1. Scrive Onorato di Balzac nel Tenebreuse (sic) affaire: «da quando le Società hanno inventato la giustizia non si è saputo trovare il mezzo di dare all’accusato un potere eguale a quello di cui dispone il magistrato contro il delitto, rendendo così la giustizia bilaterale».
L’affermazione del grande scrittore della Commedia umana rispondeva a tempi nei quali l’arbitrio ora l’unica realtà nella amministrazione della giustizia.
Ben altro dice oggi della giustizia il mefistofelico spirito moderno, che demolisce ogni sacra istituzione, per quanto barbuta di pelo venerando, e va atterrando tutti i vecchi idoli e le antiche deità.
T. de Wyewa, Ancora il romanzo inglese nel 1907 (1), «Minerva. Rivista delle Riviste», Roma, Società Editrice Laziale, Anno XVIII, Vol. XXVIII, N. 4, 5 gennaio 1908, pp. 83-86.
(1) Da un articolo di T. De Wyzewa, in Revue des Deux Mondes, 15 dicembre. […].
Marlott Watson.
p. 84. Il Watson è oggi il miglior maestro del genere puramente inglese, come lo è stato prima di lui Robert Stevenson, di quel genere che – mentre in Francia, dopo Balzac e Flaubert, si analizzava soltanto il sentimento amoroso – ha trovato i suoi argomenti all’infuori dell’amore e i suoi tipi fra avventurieri e frodatori simpatici e garbati […].
Yambo, Spigolando. La gloria e l’appetito, «La Scintilla. Giornale della Domenica», Matera, Anno IX, Numero 27, 19 Luglio 1908, p. 2.
Balzac era un ghiottone numero uno, e i suoi pranzi non finivano mai […].
F.[rancesco] Zingaropoli, L’amore nelle vite successive, «Luce e Ombra», Milano, Anno VIII, Fascicolo 3, Marzo 1908, pp. 113-122.
p. 113. «... i legami indivisibili che riattaccano ciascuna delle nostre esistenze, l’una alle altre e che l’Anima sola si ricorda, perché la materia non può ricordarsi di alcuna cosa spirituale. Solo il pensiero ha il ricordo dell’anteriore».
Balzac, Séraphitus-Séraphita.
[1] De Potter, 1844; «Revue Parisienne», 1840, oppure una delle due contraffazioni belghe pubblicate nel 1841. Le nostre perplessità nascono dal fatto che, sulla base dell’esame delle varianti testuali, l’anonimo compilatore italiano sembra aver avuto dinnanzi a sé anche il testo dell’edizione Furne.
[2] Cfr. Balzac, Un Prince de la Bohème. Introduction de Patrick Berthier, in La Comédie humaine … cit., ‘Nouvelle Pléiade’, t. VII, 1977; Histoire du texte; notes et variantes, pp. 1497-1521.
[3] Cfr. Félicien Pascal, Le royalisme de Balzac, «Le Figaro Littéraire», 4 Janvier 1908.
[4] Cfr. J. Pérès, Le mysticisme de la volonté chez H. de Balzac, «Mercure de France», Vol. LXXIV, 1er juillet 1908, pp. 5-22.
[5] Cfr. Jules Bertaut, Balzac homme politique, «Revue du Mois», Vol. VI, Octobre 1908, pp. 440-456.
[6] Cfr. A Laurent-Jan, 10 décembre [1849], in H. de Balzac, Correspondance. Textes réunis, classés et annotés par Roger Pierrot. Tome V (Mai 1845-Août 1850) et Supplément, Paris, Éditions Garnier Frères, 1969, pp. 684-685.
[7] La copia anastatica dell’edizione del 1908 di questo testo del Lucini è stata pubblicata, a cura di Pier Luigi Ferro, dalle Edizioni Interlinea di Novara nel 2008.
[8] Cfr. Stefan Zweig, Balzac, «Zukunft», Vol. LXIV, 1908, pp. 53-62; 100-111.
[9] Fascicolo del 1° marzo 1901. [N.d.A.].
[10] Cfr. Balzac, La Comédie humaine, Paris, Calmann-Lévy, 1899-1902, 52 voll.
Marco Stupazzoni